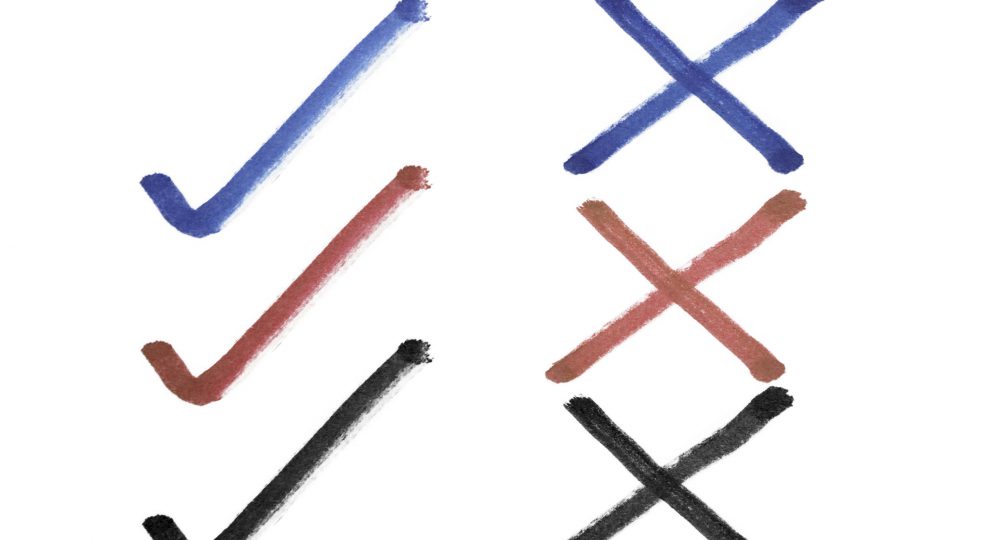L’italiano continua a cambiare: cambia il nostro modo di usarlo, perché cambia il mondo in cui lo usiamo. Ne parla nel suo nuovo saggio il linguista Giuseppe Antonelli, che spiega anche come si sta evolvendo la grammatica… – Su ilLibraio.it un capitolo da “Un italiano vero – La lingua in cui viviamo”
L’italiano perfetto non esiste, e non è mai esistito. L’italiano continua a cambiare: cambia il nostro modo di usarlo, perché cambia il mondo in cui lo usiamo. In pochi anni si è passati dall’epistola all’e-pistola: e-mail, chat, messaggini, social network. E così – per la prima volta nella sua storia – l’italiano si ritrova a essere non solo parlato, ma anche scritto quotidianamente dalla maggioranza degli italiani.

LEGGI ANCHE – Ormai non scriviamo più in italiano, ma in “e-taliano”: intervista a Giuseppe Antonelli
Giuseppe Antonelli insegna Linguistica italiana all’Università di Cassino e conduce su Radio Tre la trasmissione settimanale La lingua batte. Nel suo nuovo saggio, Un italiano vero – La lingua in cui viviamo (Rizzoli), racconta la storia di ognuno di noi: noi che scrivevamo le lettere e oggi scriviamo su Whatsapp. Ci accompagna tra sigle e parole inglesi, tra punteggiatura ed emoji, tra dialettismi ed espressioni alla moda.
Antonelli ci spiega anche come si stanno modificando alcuni aspetti della grammatica. Ricostruisce il passaggio epocale dall’italiano all’e-taliano: dai cyberpioneri al salto con l’hashtag, passando per le leggende metropolitane sugli effetti del computer e sulla lingua degli sms…

Su ilLibraio.it, per gentile concessione dell’editore, il capitolo “Per filo e per segno”
E tu, lettore, di che segno sei? Punto, virgola o punto e virgola? I segni di punteggiatura stanno diventando un po’ come quelli zodiacali. Percepiti sempre più come indicatori di una certa personalità (i due punti ragionano da filosofi, le virgolette copiano sempre gli altri, le parentesi tendono a isolarsi). O addirittura come rivelatori dell’umore di un dato momento. Di che segno ti senti stamattina? Esclamativo! Interrogativo? Di sospensione…
Certo, all’interno della norma grammaticale le regole della punteggiatura hanno sempre avuto un loro statuto speciale. Al punto che, come notava un manuale scolastico di fine Ottocento, «anche i migliori grammatici finiscono per levarsi d’impiccio col dire che la punteggiatura si deve imparare coll’uso». Una percezione soggettiva della punteggiatura, d’altra parte, c’è sempre stata. «L’uso della virgola sembra sciolto da ogni regola o legato soltanto al capriccio dello scrittore», notava in quegli stessi anni il filologo Rigutini, censurando il fittissimo uso delle virgole nella seconda edizione dei Promessi sposi. Per gli scrittori, appunto, era una questione di gusti. Se Manzoni amava le virgole, D’Annunzio le aborriva («costrutto molto virgolato è costrutto molto bacato») e Carducci le evitava nelle enumerazioni: «finita la villeggiatura, me la batto tra l’aure i raggi gli zefiri e l’ombre a veder ballare le stelle». La lineetta, usata spesso da Foscolo nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis, era considerata da Leopardi come il segno di un’allarmante deriva: «che è questo ingombro di lineette, di puntini, di spazietti, di punti ammirativi doppi e tripli, che so io?», sbottava nel suo Zibaldone il 22 aprile 1821. Poi continuava, come abbiamo già visto, prendendosela con «la scrittura gerogli- fica» fatta di segni invece che di parole. Come se già prevedesse l’allora imprevedibile avvento delle emoticon: quelle faccine che cercano di rendere iconicamente (cioè, grosso modo, come dei geroglifici) le emozioni di chi scrive. La prima fu usata dal giovane informatico americano Scott Fahlman nel 1982; era – neanche a dirlo – una faccina sorridente :-). In fondo, bastava ruotare lo sguardo di novanta gradi perché la punteggiatura assumesse tutto un altro aspetto. Con l’avvento degli emoji, provenienti dal Giappone, il passaggio ai pittogrammi sembra compiuto. Al posto delle faccine si usano disegnini già pronti che riproducono oggetti o situazioni di ogni tipo e ormai con i segni di punteggiatura non hanno più nulla a che spartire.
È evidente che l’influsso di emoticon ed emoji sta cambiando anche la percezione collettiva dei segni di punteggiatura tradizionali. Nell’àmbito di una scrittura che è – per frequenza, utenti, mezzi – molto diversa da quella tradizionale, anche la punteggiatura è oggi interpretata in modo diverso. Un tempo si oscillava tra la punteggiatura «per l’orecchio» (mirante a rendere soprattutto le pause del discorso) e quella «per l’occhio» (più attenta alle scansioni logiche e sintattiche). Oggi sarebbe forse più giusto parlare di punteggiatura «per il cuore». Il sentiment della punteggiatura è diventato sentimentale: a dominare sono – come per emoticon ed emoji – le emozioni.
Negli SMS, in chat, nei social network la punteggiatura gode di una centralità e di un’autonomia che finora aveva conosciuto solo nei fumetti. In una storia di metà anni Settanta, Snoopy assiste a una diatriba tra il suo amico Woodstock e altri uccellini gialli. Tutta la discussione avviene per mezzo di cartelli in cui è disegnato un segno di punteggiatura. Quando alla fine la spunta la virgola, Snoopy commenta: «Sono contento che abbia vinto… Sto sempre per il proletariato…». In una concezione simbolica della punteggiatura la virgola è l’elemento più debole, più fragile, più delicato. Di qui l’atteggiamento protettivo mostrato anche di recente in un libro come Between You and Me. Confessions of a Comma Queen scritto da Mary Norris, a lungo editor del “New Yorker” e considerata, come ricorda il sottotitolo, la «regina delle virgole» (virgola, in inglese, è comma). Il capitolo specifico s’intitola, giocando su una vecchia canzone di Boy George, Comma comma comma Chameleon. In un libro sulle nuove forme di scrittura quel capitolo si sarebbe potuto chiamare, parafrasando un titolo dei Massive Attack, Karma comma. In rete, infatti, l’uso delle virgole e degli altri segni di punteggiatura sembra affidato al karma individuale più che a una serie di regole condivise. Le licenze che prima erano riservate agli scrittori appaiono adesso un diritto di tutti, il che rende la punteggiatura molto più libera. In alcuni casi persino licenziosa. Su una maglietta pubblicizzata in vari siti Internet c’è scritto: «The Comma Sutra. Making Grammar Sexy Since 1875» (da noi, in realtà, il comma sutra fa pensare più che altro alle contorsioni di certo linguaggio giuridico). Ma proprio qui sta il punto, verrebbe da dire; perché invece quest’uso della punteggiatura è sempre più distante dalla grammatica. Le sue implicazioni, più che linguistiche, sono psicologiche.
Prendiamo il caso del punto fermo. Si è diffusa da qualche tempo l’idea che il punto fermo abbia – nel dialogo telematico – una valenza ostile, che corrisponda a un atteggiamento aggressivo. La questione è stata sollevata qualche anno fa da Ben Crair in un articolo del “New Republic”: «nelle mie conversazioni online la gente non lo utilizza semplicemente per chiudere una frase, ma per segnalare una cosa del tipo “non sono contento di come si stia mettendo la conversazione”». Di qui un uso che si starebbe facendo sempre più raro. Nel lungo dibattito che ne è seguito, qualcuno ha scritto che a uccidere il punto fermo sarebbe stato il punto esclamativo. Forse per via di quella forma da «pugnalettaccio dell’enfasi», da «daga dell’iperbole», da «alabarda della retorica» che tanto infastidiva il giornalista e scrittore Ugo Ojetti (la sua celebre invettiva risale al 1928). La vera alternativa, però, quella che in questo mondo sempre connesso consente di non chiudere mai del tutto la comunicazione, è un’altra: «applico alla vita i puntini di sospensione», cantava Morgan, «che nell’incosciente non c’è negazione…». Solo che il punto è tutt’altro che morto e sepolto. A testimoniarlo, negli stessi anni e negli stessi Stati Uniti, l’uso vincente che Obama ne ha fatto durante la sua seconda campagna elettorale, aggiungendolo al suo slogan che prometteva di andare avanti. «Forward.». Fermo. Sicuro. Perentorio.
Poco più di dieci anni fa, nel suo Prontuario di punteggiatura, Bice Garavelli notava il diffondersi di un atteggiamento che deiniva «estremismo interpuntorio». Ovvero la tendenza a usare solo due segni: la virgola e il punto. A caratterizzare la nuova percezione collettiva è, invece, un radicale relativismo interpuntorio. La sensazione diffusa che non esista una punteggiatura oggettivamente corretta, ma che l’uso dipenda – di volta in volta – dai diversi contesti e dai diversi (è proprio il caso di dirlo) punti di vista. Un’interpretazione soggettiva e contingente dettata dal prevalere della funzione emotiva su tutte le altre. Come per il punto e virgola, che nella lingua inglese se la passa molto peggio rispetto a quanto succede in italiano. I manuali di seduzione lo sconsigliano, perché – dicono – usare un punto e virgola in chat è un po’ come truccarsi per andare in palestra. Ma a sconsigliarlo sono anche i manuali di scrittura creativa, forti di affermazioni come questa di E. L. Doctorow: «Detesto i punti e virgola. Non hanno nulla a che fare con il raccontare una storia». O come quelle – lapidarie – di Kurt Vonnegut, per cui i punti e virgola «non rappresentano assolutamente niente. Dimostrano solo che avete fatto l’università». E poi: «quando Hemingway si è ucciso, ha messo un punto fermo alla sua vita. La vecchiaia somiglia piuttosto a un punto e virgola». Ma quel segno, che in inglese porta il nome di semicolon, può trasformarsi anche in un segno di vita. Proprio Semicolon project si chiama un’iniziativa che deliberatamente rovescia il senso delle parole di Vonnegut. Il progetto invita chi abbia sofferto di ansia o depressione, chi in passato abbia seriamente pensato al suicidio, a disegnare sul polso o su un’altra parte del corpo un punto e virgola. «Il punto e virgola rappresenta una frase che l’autore avrebbe potuto chiudere, ma ha deciso di non farlo. Quell’autore sei tu e la frase è la tua vita». Metterci la faccina non basta più: la punteggiatura va vissuta sulla propria pelle.
E allora, di punto in bianco. Un maestro indù mostrò un giorno ai discepoli un foglio di carta con un puntino nero nel mezzo. «Che cosa vedete?», chiese. E loro: «un punto nero!». «Come? Nessuno di voi è stato capace di vedere il grande spazio bianco tutt’attorno?» Già Daniello Bartoli, nella sua Ortografia italiana (1670), notava – citando Aristotele – che una scrittura ininterrotta risulta faticosa come una corsa senza fine o come un mare senza isole: di qui l’importanza dei capoversi, ovvero del «tornar la scrittura da capo». Ben consci del valore simbolico di quel vuoto, i manuali epistolari prescrivevano fino all’Ottocento di lasciare tra l’intestazione e l’attacco della lettera (e poi tra la fine del testo e la firma) uno spazio bianco di ampiezza direttamente proporzionale all’importanza del destinatario. Come ricorda Il nuovo segretario italiano (1827), «è questo ciò che si chiama dar la linea». Da non confondersi con l’alinea, come si prende a chiamare in quegli anni l’accapo con rientro a inizio del rigo (dal francese alinea, a sua volta dal latino medievale a linea, cioè “lontano dalla linea che delimita la colonna”, come si diceva dettando ai copisti). Spazi, capoversi, rientri: è la «punteggiatura bianca», concorrente e complementare rispetto alla «punteggiatura nera» dei tradizionali segni d’interpunzione. Secondo Marinetti, l’unica che sarebbe dovuta sopravvivere nella letteratura futurista. «Le parole liberate dalla punteggiatura irradieranno le une sulle altre», spiegava: «uno spazio bianco, più o meno lungo, indicherà al lettore i riposi o i sonni più o meno lunghi dell’intuizione». Bianca che più bianca non si può.
(continua in libreria…)