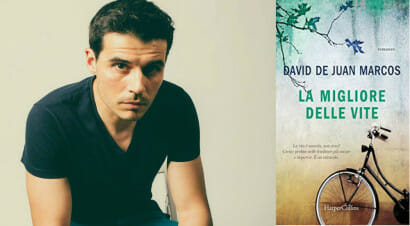Fin dove saremmo capaci di arrivare per proteggere chi amiamo? “Dammi tutto il tuo male” di Matteo Ferrario ruota intorno a questa domanda. Andrea è un uomo normale e un padre premuroso. Ma è anche un assassino. Ha ucciso e non è pentito. Ma si può uccidere per amore? – Su ilLibraio.it un capitolo
Dammi tutto il tuo male di Matteo Ferrario, classe 1975, è il primo romanzo italiano pubblicato da Harper Collins Italia, e ruota intorno a una domanda: fin dove saremmo capaci di arrivare per proteggere chi amiamo? Dammi tutto il tuo male è una storia che parla del buio presente in ogni uomo, ed è la storia struggente di un padre, di una figlia e di un amore che porta alle estreme conseguenze.
Può interessarti anche
Andrea ha quarant’anni ed è un uomo normale, con una vita normale. Fa il bibliotecario e, da quando la sua compagna Barbara non c’è più, cresce da solo sua figlia Viola, come un adulto responsabile può e deve fare. Ma Andrea non è soltanto un uomo normale e un padre premuroso. È anche un assassino. Barbara e Andrea si erano conosciuti a un esclusivo party milanese e da quel momento erano diventati inseparabili. Barbara, una tatuatrice dalla bellezza androgina, dura e sfuggente, si era illusa di trovare in lui l’unica persona al mondo che potesse salvarla. Ma salvarla da cosa? E perché la donna è sparita poco dopo la nascita di Viola? Andrea è l’unico a conoscere la verità. Ha ucciso, ma non è pentito, perché si può uccidere per odio, ma, come ci rivela Dammi tutto il tuo male, a volte si può anche uccidere per amore.

Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo su ilLibraio.it un estratto del libro:
Capitolo 1
Sono un padre e un assassino, e dopo tanti anni non ho ancora capito se devo essere grato a Barbara oppure odiarla, perché senza di lei non mi sarei scoperto capace di nessuna delle due cose.
Ma non ha più molto senso porsi problemi del genere, adesso che tutto è finito.
Le indagini sono chiuse da anni, e anche nell’eventualità remota in cui si decidesse di riaprirle, facendo di me un sospettato, non si troverebbe una sola prova a mio carico.
Un esame col luminol avrebbe forse evidenziato qualche traccia di sangue o DNA rimasta nella macchina, perché era ben difficile che non ce ne fossero: pur essendomi preparato a lungo, quella notte avevo agito d’impulso, senza rendermi conto dei rischi che correvo. Comunque sia, se esisteva ancora qualche prova almeno potenziale da usare per incriminarmi, a quest’ora è già finita accartocciata da tempo sotto la pressa di un demolitore: dopo un lungo servizio la mia vecchia Golf ha concluso un paio d’anni fa il suo onesto ciclo di vita, con più di duecentotrentamila chilometri sul groppone. Approfittando degli incentivi, l’ho sostituita con una piccola Toyota ibrida color bianco perla, che quando è in modalità elettrica scivola per le strade senza alcun rumore.
Questo all’inizio faceva molto ridere Viola. “Ma è spenta, papi, chi è che ci sta spingendo?” Se è rimasto qualcosa di buono in me – qualcosa di umano – lo devo a mia figlia. La sua sola presenza
mi ha tenuto lontano dalla parte peggiore di me stesso, dopo che siamo rimasti solo io e lei.
“Il tuo cuore è fatto a macchie, come il manto di un leopardo” mi aveva detto Barbara una notte, con la testa appoggiata sul mio petto.
Ma lo conosceva meno di quanto pensasse, il mio cuore. Non aveva mai guardato dentro le parti più scure, o non le prendeva abbastanza sul serio.
E poi quelli erano i primi tempi per noi due, i migliori, finiti ancor prima che nascesse Viola.
La partorì il 25 agosto 2008, nel tardo pomeriggio. Anche in un letto d’ospedale, almeno in apparenza, era la stessa che avevo incontrato una sera di giugno dell’anno precedente: zigomi scolpiti, occhi dal taglio a fessura, capelli scuri e impossibili da domare.
“La tatuatrice meno tatuata che esista” come si era definita in quell’occasione, con la sua flemma ironica.
Ma dopo la nascita della bambina era diversa, ancora più fragile, e non solo per via del parto o delle complicazioni dell’ultimo periodo, tra cui mi veniva naturale includere anche il fatto che non vivessimo più insieme da oltre due mesi.
“Sono stanca” ripeteva.
Solo io potevo conoscere il significato di quella stanchezza. Non le infermiere, non il dottore che passava per il giro di controllo.
Solo io la vedevo. Anche se non aveva fatto altro che nascondersi, fin dall’inizio, la vedevo davvero, perché non importava quanto di orribile stesse cercando di tenersi dentro, né cosa sarebbe successo da lì in avanti: io l’amavo, e non avrei mai smesso di farlo.
Lei, invece, si era già tirata indietro, senza nemmeno averci provato sul serio.
Smarrita e senza l’ombra di un sorriso, guardava Viola come un’estranea arrivata per mettere a rischio i suoi segreti.
Non immaginava che io li conoscessi già.
Capitolo 4
Io tutto mi sarei augurato, tranne avere una figlia dalla donna della mia vita e doverla crescere senza di lei, ma col passare degli anni eravamo riusciti a trovare un nostro equilibrio. Non ce l’eravamo cavata poi tanto male fino all’estate del 2014, io e Viola, e mi ero abituato all’idea che si andasse avanti così: niente più scossoni o sorprese. L’oscurità non si era presa proprio tutto. C’erano momenti in cui riuscivo a convincermi che ce l’avremmo fatta, anche senza Barbara.
Come la sera della foto, un paio d’anni prima che le cose precipitassero di nuovo.
Saranno state le sette, e il cielo era un soffitto di nubi giallo elettrico, c’era una luce strana, da apocalisse imminente. Ero al computer in mansarda a finire uno dei piccoli lavori di editing che sbrigavo ogni tanto a tempo perso per una casa editrice di testi giuridici, quando udii i passettini di Viola sulla scala interna: inspirai a fondo e alzai gli occhi al soffitto, poi mi voltai e la vidi lì davanti a me, accarezzata da quella luce gialla.
Allora immaginai entrambi come i protagonisti di un film catastrofico, dove c’è una casa che sta per essere investita da una gigantesca tempesta di sabbia, o dal più grande tsunami nella storia dell’umanità, e un padre all’interno che ha una sola preoccupazione: portare in salvo la propria figlia.
La madre non ci ha creduto abbastanza, il suo sotto certi aspetti è stato un tradimento. Come quello di Charlize Theron in The road, quando se ne va in piena notte per non farsi vedere dal figlio, consegnandosi in modo simbolico alla morte.
“Papi” mi disse Viola, “stai lavorando?”
Sbuffai dal naso e la guardai sgranando gli occhi.
“Secondo te, pollastra?”
Si mise a ridacchiare, come tutte le volte che la chiamavo così, perché aveva sentito usare quell’espressione in un cartone animato e le piaceva. Poi si portò le mani dietro la schiena e si dondolò sui piedi, con la testa di sbieco. La tipica postura di quando voleva muovermi a compassione.
“Guardiamo insieme le foto?”
In preda alla disperazione, un giorno di qualche anno prima ne avevo messe alcune centinaia su una chiavetta usb – foto di me e Barbara, di lei soprattutto – e le avevo portate in un negozio di stampe digitali. Non immaginavo che per Viola sarebbero diventate una specie di rito, un modo per sentire lo stesso la presenza di sua madre.
“Le foto?” le dissi quella sera. “Ma le abbiamo riguardate anche la settimana scorsa!”
Lei fece un paio di saltelli, come se volesse scavare un buco nel pavimento.
“Ma a me piace!”
“Ascolta, tesoro, non è che puoi iniziare a tirarle fuori e guardarle da sola, e dopo un po’ arrivo anch’io? Ho ancora del lavoro da fare e…”
Viola crollò il capo scuotendo appena la massa di capelli scuri, mostrandomi quel tanto che bastava il faccino mortificato, poi fece dietrofront verso la scala.
“Va bene, ho capito, fa niente.”
Con quella tattica sapeva già di aver vinto. E infatti mi sentivo troppo dispiaciuto per non salvare il file ancora incompleto su Dropbox e spegnere il pc.
Le stampe delle nostre foto erano insieme agli altri album più vecchi. Al momento di estrarle per l’ennesima volta dai cassetti in soggiorno, saltò fuori una busta di carta con dentro una decina di polaroid che non vedevo da anni.
“Chi è questo bambino, papi?”
Viola aveva tra le mani un’immagine scattata un trentennio prima che lei nascesse, nello studio personale di mio padre all’interno della nostra prima casa, quella in cui avevamo sentito la scossa di terremoto e mia madre gli aveva detto: “Fai qualcosa!”.
Lui si era messo a ridere e aveva allargato le braccia. “Che cosa posso fare? Aspettiamo che passi.”
Forse era allora che avevo smesso di considerarlo onnipotente, ed erano cominciate le recriminazioni. Ma la verità è che, soprattutto da un certo punto in poi, non c’è molto che un genitore possa fare per un figlio, almeno in positivo. Si tratta di fare meno danni possibile, e limitarsi ad amarlo.
Convivevo con quel pensiero ormai da molto tempo, ma alcune volte si sovrapponeva a quello di Barbara e della sua mancanza di fede in noi, quel suo partire battuta che forse avrebbe finito per contagiarci tutti come un morbo, se ci fosse rimasta accanto.
Il bambino nella foto, con il nome Andrea stampato a lettere rosse sulla maglietta, era ritratto mentre guardava dentro il plastico della nuova casa, quella di famiglia che il grande Furio Bertoni aveva commissionato a suo fratello ingegnere dopo i primi successi.
Quella dove eravamo rimasti io e Viola, dopo che per poco c’era stata anche sua madre.
Il piccolo Andrea provava a spingersi con lo sguardo dentro le finestre, che erano buchi rettangolari ritagliati nella balsa. Intravedeva piani vuoti, senza mobili né persone, come se tutto fosse già finito ancor prima di iniziare.
“Ero io” dissi a Viola. “Quel bambino ero io.”
Rimase ancora un po’ incantata, col dito che seguiva il mio profilo smorto da cherubino sulla carta lucida.
Anche io non riuscivo a staccarmene. Guardavo gli occhi del bimbo alla ricerca di un segno, una prima avvisaglia dell’uomo che trent’anni dopo avrebbe lanciato nell’acqua di un torrente un grosso arnese di alluminio sporco di sangue e materia cerebrale, convinto di aver appena preparato il miglior futuro possibile per la propria figlia. Ma non sembravano essercene, non ancora. Chissà quando succede, pensai.
Quando si diventa quel tipo di persona? Una che sa distinguere il male, ma a un certo punto della propria esistenza può ritenerlo indispensabile.
“Eri bello da piccolo, papi” disse Viola dopo un po’.
“Mica come adesso.”
(Continua in libreria…)