“Per me la lettura è tutto, o quasi tutto, o comunque tantissimo”. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, “Dono di saper vivere”, Tommaso Pincio si racconta con ilLibraio.it: “La letteratura trae forza e ragione di esistere proprio dalla sua marginalità, dalla minaccia dell’estinzione”. E ancora: “Odio il consenso. Le più grandi scoperte dell’umanità non sono state raggiunte perseguendo il consenso, ma andando contro il senso comune…” – L’intervista
Torna in libreria Tommaso Pincio e lo fa con un romanzo composito e raffinatissimo, che affonda tanto nel mondo dell’arte quanto nei dilemmi esistenziali di un carcerato, io-narrante che conduce una narrazione imprevedibile, tra flashback sulla sua carriera di aspirante artista, nonché sul suo fallimento come venditore porta a porta prima e mercante d’arte poi.
Accanto alla storia principale, troviamo stralci del libro dedicato a Caravaggio: il protagonista ha più volte pensato di scrivere un suo studio, ma solo nel silenzio della cella questo trova forma o, perlomeno, abbozzo. E non mancano ora punti di contatto ora violente prese di distanza dall’artista: forse in comune i due hanno la maledizione di non saper vivere… Per approfondire i tanti temi presenti nel Dono di saper vivere (Einaudi Stile Libero), ilLibraio.it ha intervistato Pincio sulle sue abitudini di scrittura e lettura, su alcune scelte nel romanzo e sul ruolo dell’arte nella sua vita.
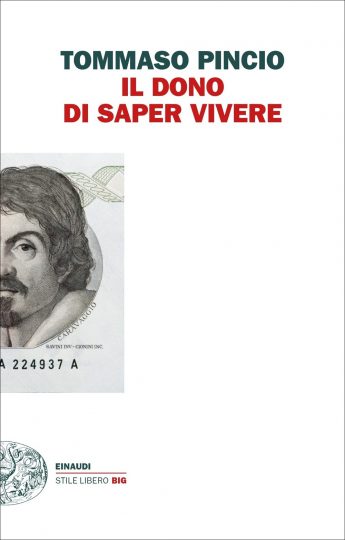
Per l’avvocato del protagonista la lettura ha un ruolo catartico e consolatorio, mentre l’io narrante è indispettito dalla quantità di libri che affollano la sua strettissima cella e restano in un angolo a prendere umidità. Anche nel suo precedente romanzo, Panorama, la lettura non sembra avere futuro e viene sostituita dall’ossessione dello sguardo, per cui un lettore che legge è addirittura una performance artistica. E per lei, che ruolo ha la lettura?
“Personalmente, intende? Per me la lettura è tutto, o quasi tutto, o comunque tantissimo. Il giorno, spero lontano, in cui saprò di essere sul punto di morire, semmai arriverò consapevole a quel momento, credo che il mio più grande rimpianto saranno i libri che ancora non avrò letto. La vita andrà come andrà e me la ricorderò per quella che sarà stata senza rammaricarmi più di tanto. Quanto ai libri non letti invece, dubito che avrò lo stesso sentimento. In questo, sia Panorama sia il carcerato sono mie proiezioni invertite”.
E quale destino attende la lettura?
“Mi pare evidente che il lettore di libri come lo abbiamo inteso fino a oggi è una creatura a rischio di estinzione, se non un fantasma. Non so dire se questo processo di scomparsa arriverà a un compimento definitivo e non mi interessa neanche. Sarebbe come chiedersi se il mondo finirà o no. Ovvio che finirà, ma io non sarò lì a vedere il sipario che cala, a meno che un meteorite centri la Terra o un esaltato schiacci il bottone sbagliato, eventualità che tendo a considerare romanzesche più che reali. Va poi ricordato che la lettura è sempre stata un paradiso per pochi, spesso sbeffeggiato da tanti anche quando i libri erano in sostanza l’unico mezzo di informazione e intrattenimento”.
Cosa ne pensa della lettura “paradiso per pochi”?
“Vi è della giustizia in questo. Un mondo di tutti lettori sarebbe invivibile o comunque assai peggiore di quello che ci ritroviamo. In realtà, la letteratura trae forza e ragione di esistere proprio dalla sua marginalità, dalla minaccia dell’estinzione. Sembra un paradosso, ma non lo è: i libri non avrebbero l’importanza che hanno senza le biblioteche andate distrutte dagli incendi, i libri messi all’indice, la gente che non ha tempo o voglia di leggere.”
Passiamo ora al mondo dell’arte, che nel suo romanzo è spesso legato alla finzione, alla capacità di vendere non solo una tela, ma anche una storia, sufficientemente affascinante da irretire il potenziale compratore. Della sua esperienza decennale come direttore di una galleria d’arte internazionale e della sua conoscenza diretta del mondo della pittura, cosa ricorda invece con maggior piacere?
“Tutto, benché allora odiassi il mio lavoro. Lo vedevo come un fallimento, anche se di lusso. In gioventù aspiravo a diventare anch’io un artista, ma per ragioni che non sto qui a ricordare, ho dismesso sogni e ambizioni, e sono finito a fare il mercante in una galleria. Il fatto che questa galleria fosse tra le più importanti sulla scena internazionale di allora non faceva che acuire il dolore, la rabbia, la frustrazione per non essere diventato quel che speravo. D’altro canto, ho avuto il privilegio di conoscere dall’interno un mondo straordinario, abitato da persone uniche, in una fase storica interessante, anche se terminale. Nel libro non lo racconto per quel che in effetti era. Ne do un’idea parziale. Per ragioni narrative, assimilo la galleria in cui lavoravo alla Fortezza Bastiani, ma era un luogo assai più movimentato”.
Caravaggio, chiamato dal protagonista “Gran Balordo” per motivi che si chiariscono via via, è un vero e proprio co-protagonista…
“A dirla tutta non so se il vero motivo per cui il protagonista del libro – faccio fatica a chiamarlo romanzo – ricorre a questo appellativo sia davvero così chiaro. Se lo è, non viene comunque esplicitato. Gran Balordo discende da Gran Lombardo, che come tutti sanno è il modo in cui Dante allude a Bartolomeo della Scala nel Paradiso. È però anche il titolo del ritratto del Gadda ormai avanti con gli anni che Giulio Cattaneo fa in suo gustoso libro, il Gadda che lavorò in Rai, il milanese trapiantato a Roma. Ed è appunto questa schiatta di milanesi di cui Caravaggio fa parte che avevo in mente. Balordo è l’anagramma mancato di Lombardo, gli manca una emme per esserlo fino in fondo, ovvero l’iniziale tanto del nome quanto del cognome di Caravaggio. In un primo momento avevo pensato di dedicare un capitolo proprio a questa particolare specie di milanesi trapiantati, visti ovviamente attraverso la specola deformante di un romano de Roma quale, ahimè, sono. In tal modo sarebbe stato più chiaro il senso di quel Balordo, ma non si può metter tutto nei libri, raccontare la rava e la fava, così ho rinunciato”.
Come nota nel libro, se per lungo tempo al sentire il nome di Michelangelo tutti pensavano subito a Buonarroti, ora questo è stato soppiantato da Merisi… Che cosa di Caravaggio affascina tanto l’uomo moderno?
“È vero che oggi le masse sembrano più affascinate da Caravaggio, ma il Gran Balordo non è comunque riuscito a imporsi del tutto sul Buonarroti. Michelangelo resta ancora il pittore della Cappella Sistina e quando si pensa a Merisi, l’altro Michelangelo, lo si fa sempre con il soprannome, mai con il nome. Per tutti Merisi è Caravaggio, non Michelangelo, e Caravaggio è sì oggi più amato di moltissimi altri artisti, amato spesso fino all’eccesso e al fraintendimento, come è anche giusto che sia, ma non è riuscito a imporre il suo vero nome. Si è dovuto accontentare di una nomea che seppur grande resta comunque una nomea, e questa è per certi versi una sconfitta, se considerata con la mentalità del suo tempo, e forse pure del nostro. Tra i tanti motivi di fascino che esercita la figura di Caravaggio metterei quindi anche quella di uno sconfitto vittorioso o un vittorioso sconfitto, a seconda di come si preferisce leggerne la storia”.
“Una y, sarebbe questo il tempo? A dire il vero, preferirei vedervi una lingua biforcuta, ma per cominciare, per intenderci e semplificare va benissimo anche la y. Ogni attimo, ogni singolo istante della vostra esistenza ha questa forma, che è poi la forma di un bivio, di una via che si divide in due, simile alla via che poteva percorrersi nell’Ade, se provvisti di un ramo d’oro. Uno dei due bracci, non importa quale, tende al buio, a ciò che in un dato momento non è. L’altro conduce all’Eliso del tempo, dove lo stesso momento di cui sopra si distende per rischiararsi di luce propria […]. Il tempo non è che l’eterno perpetuarsi di un bivio”. Nel romanzo leggiamo un’affascinante teoria sul tempo della vita, che è un procedere per continui bivi, come se tante y si succedessero fino a formare una sorta di filo spinato, dove ogni decisione presa apre un’ulteriore alternativa per il futuro. Come rappresenterebbe il tempo della scrittura?
“Se per scrittura intendiamo racconto, la scrittura narrativa propria dei romanzi, il suo tempo è spesso molto simile, ma spuntato delle spine, salvo quelle essenziali ovviamente, quelle che si impongono sulle altre col senno di poi diventando aculei simbolici, fitte croniche del ricordo, atti mancati, rimpianti. Poi c’è il tempo dello scrivere, che è cosa diversa da quello della scrittura. Qui mi sento più in imbarazzo, perché il tempo dello scrivere muta con il tempo del vivere. Per quanto certe ossessioni, certi temi siano ricorrenti; per quanto ci si scopra, negli anni si torna anche non volendo sugli stessi tasti, ci si torna sempre in modo diverso e questa diversità consiste soprattutto nel rapporto che si ha con lo scrivere, con i suoi tempi”.
In un presente che ha perlopiù declassato il ruolo della metafisica, capita spesso di essere ossessionati dai “segni”. Il protagonista stesso, per quanto cerchi di resistere, cade spesso nella ricerca di un significato di questo o quel segno. Lei ha dei “segni” a cui presta particolare attenzione?
“I segni sono un’inclinazione dello spirito, un mezzo per costruirci una visione del mondo o anche più semplicemente di noi stessi. Che esistano davvero è in fondo assai relativo, per non dire irrilevante. Ciò che conta è l’effetto che producono in noi. A volte il pensiero intuitivo è più veloce e centra meglio il bersaglio di quello razionale. E comunque, per quanto scettici si possa essere, è pressoché impossibile resistere alla tentazione di credere che il mondo ci parli, che si preoccupi di dispensarci moniti o consigli o anticipazioni di quel che ci attende. Non credo tuttavia di avere segni che ascolto più di altri. Dipende dall’umore, dalla fase che attraverso, più che dai segni in sé”.
Per quale ragione ha scelto di aprire tanti capitoli con una citazione tratta dai diari di Andy Warhol?
“I diari sono un libro di estremo interesse e a tratti anche spassoso, dove emerge al meglio la personalità di Warhol, molto più complessa dell’idea che ci si può fare di lui attraverso una conoscenza superficiale della sua opera e della New York festaiola che gravitava attorno alla Factory. Le frasi sono state scelte con metodo, in alcuni casi cercate più che trovate, e servono ad anticipare e far da controcanto ai temi che affronto nei vari capitoli della seconda parte del libro. Per come lo intendo io, inoltre, Warhol sta a Caravaggio un po’ come il «falso specchio» del libro sta a me stesso. I due si somigliano pur non essendo identici. Per dirne una, la popolana umanità che Caravaggio dipingeva nei suoi quadri è per molti versi antenata dell’immaginario pop di Warhol, vuoi per la brutalità di alcune scene, vuoi per la fotografica immediatezza. Un’altra ragione è il fatto che il personaggio di Caravaggio e di conseguenza anche la sua opera sono diventati un’icona pop, onnipresente e ‘onniamata’, se mi passa il termine. C’è poi lo sguardo sardonico e al contempo tetro con cui Warhol osserva le cose, uno sguardo affine a quello di Caravaggio, non a caso definito dai suoi contemporanei un uomo «satirico», sebbene questo tratto della sua personalità venga spesso ignorato o non considerato con il giusto peso”.
L’io-narrante, nella letteratura moderna, può essere sufficientemente capriccioso da sorprendere il lettore con cambi di scena improvvisi, ripensamenti, contraddizioni,… Cosa la affascina maggiormente, o per lo meno, quali sono le potenzialità della scrittura in prima persona?
“All’inizio del mio percorso di narratore, parliamo una ventina di anni fa, mi diedi come regola quella di non usare mai la prima persona, di servirmi sempre della terza, il cosiddetto narratore onnisciente. L’ho rispettata a lungo, per quattro romanzi, finché al quinto, Cinacittà, ho trasgredito. Anche quel romanzo avevo cominciato a scriverlo in terza, a dire il vero, finché non ho capito, o almeno creduto di capire, che stavo sbagliando ed era giunto il momento di ignorare la regola che mi ero imposto. Il protagonista era una versione alterata di me stesso e inizialmente pensavo proprio di giocare su questo stridore: uno scrittore che parla di sé in terza persona, come i matti, come i dittatori che perdono contatto con la realtà. Alla lunga mi sono dovuto arrendere, un simile pasticcio era troppo perfino per me. Senza contare che sarebbe stato assai più interessante lavorare nella direzione opposta, fingere cioè di dare al personaggio la mia voce, suggerire il sospetto che il suo pensiero era anche il mio”.
Non teme che i lettori la sovrappongano al suo protagonista?
“È un’ambiguità rischiosa, perché oggi, più che in passato, i lettori tendono a sovrapporre autore e personaggio anche quando il romanzo è scritto in terza persona. Raccontava recentemente Walter Siti di esser stato invitato a una cena dove il gatto è stato preventivamente chiuso in un’altra stanza dai padroni di casa perché in un suo romanzo c’è un personaggio che uccide un gatto. Insomma, credo che, considerati i tempi in cui viviamo, più che di potenzialità, l’uso della prima persona espone lo scrittore a delle insidie, ed è questo che la rende allettante, almeno ai miei occhi”.
Più volte, nel corso del romanzo ma anche a partire dalla copertina, la questione economica affiora: la capacità di “vendere”, anzi di “vendere bene” è fondamentale per un gallerista e il protagonista ne è del tutto privo. Ritiene che la figura dell’inetto moderno sia legata all’incapacità di guadagnare quanto vorrebbe?
“Il denaro è centrale, sì. Lo troviamo nell’immagine di copertina, come lei giustamente rileva, dove il volto di Caravaggio si fa banconota. Lo troviamo nell’esergo carpito alle Confessioni di Rousseau e poi a più riprese nel libro. A volte chiamato in causa direttamente, altre volte evocato per vie più laterali. E come giustamente anche lei rileva, questa sua grande presenza non va intesa come un elogio della ricchezza in sé, né come il desiderio di conseguirla o di affrancarsi dai disagi della povertà. Il denaro è visto come un’attestazione, la conferma di quanto siamo accettati, una quantificazione precisa e concreta del consenso raggiunto presso i nostri simili”.
E lei cosa ne pensa?
“Personalmente odio il consenso. Le più grandi scoperte dell’umanità non sono state raggiunte perseguendo il consenso, ma andando contro il senso comune. In politica, c’è chi fa del buon senso una piattaforma programmatica, un modo di progettare del futuro. Ma può venirne soltanto un futuro miope, perché quello del «con» e del «buon» senso è un futuro che non guarda lontano, è il futuro che abbiamo alle nostre spalle, come diceva qualcuno”.
Un’intera sezione del testo è intitolata “La maledizione di dover raccontare”. Per lei esiste un “dover raccontare” o si può scegliere?
“Nel libro quella maledizione ha un duplice e preciso significato. Da un lato è contrapposta al maledettismo che ammanta il mito di Caravaggio, un mito costruito in buona parte sull’opinione di alcuni biografi malevoli, stando ai quali se l’artista aveva talento in abbondanza, all’uomo mancava il dono di saper vivere. Dall’altro è la condizione in cui si sente costretta la versione che di me stesso offro nel libro, ovvero il dover ricorrere al fascino delle vite altrui per incantare il prossimo, e visto che la vita altrui in questione è appunto quella di Caravaggio i due lati si sovrappongono. Va però considerato un aspetto tutt’altro che secondario, anzi diciamo pure essenziale. La narrazione di cui si parla nel libro è di ordine puramente strumentale. A venire discusso è il racconto usato come strumento di persuasione più o meno occulta: ti racconto una storia per convincerti di qualcosa”.
Già, troviamo esempi di questo ogni giorno…
“Questa sottospecie di narrazione è effettivamente una maledizione e ne patiamo le conseguenze ogni giorno, nei campi più disparati. È comunque un falso modo di raccontare, che non ha nulla da spartire con il racconto autentico, cioè con la vera letteratura o con chi racconta al puro scopo di esporre un fatto. Il vero racconto non punta mai alla persuasione, non ha certezze o verità o promesse da vendere, semmai il contrario, solleva dubbi, pone domande, spunti di riflessione sulla condizione umana. Se si può scegliere? Credo proprio di sì, basta volerlo e rinunciare ai vantaggi più facili e immediati che offre il racconto falso”.
Per concludere, ricolleghiamoci al titolo: pensa che saper vivere sia solo un dono, o che si possa in qualche modo imparare a vivere meglio?
“Alcune persone danno l’impressione di saper vivere grazie a un dono, sembrano stare al mondo per istinto, e non credo sia soltanto apparenza. E alcuni ci nascono veramente, con quel dono. Mi rifiuto però di credere che non si possa anche imparare. Migliorare certamente si può e si deve. Il punto del libro è però un altro, anche se non troppo esplicitato. È la noncuranza che quel dono comporta. Chi lo ha può muoversi tra le cose senza pensarci e sarà sempre e comunque aggraziato. Noialtri siamo come elefanti nella proverbiale cristalleria; forse impareremo a muoverci senza fare danni, ma resteremo comunque elefanti. Non che ai pachidermi sia precluso il raggiungimento di una grazia. È però una grazia costruita, che aspira alla naturalezza ma che non sarà mai veramente naturale, proprio perché imitata, recitata, se vogliamo. Non a caso nel libro si parla parecchio anche di attori, figure care a Caravaggio, che infatti secondo i suoi detrattori non sapeva vivere”.



