“È un segreto della letteratura, nella percezione che forse si sta affermando in questi anni: quando, sospendendo alcuni paradigmi, smette di dichiararsi come tale e prende la strada solo apparentemente più semplice, dove chi affronta la realtà, il ricercatore, lo scrittore, sa di doverlo fare nel modo più onesto possibile ma sa che questo processo modifica anche lui…”. Su ilLibraio.it la riflessione di Mario Baudino, che parte da “L’arte della fuga” di Fredrik Sjöberg, passa per “La città interiore” di Mauro Covacich, e arriva ai libri di Massimo Onofri
Confesso che il dubbio se Gunnar Widdfors sia veramente esistito mi è venuto, più o meno dopo una cinquantina di pagine dell’Arte della fuga (Iperborea), nonostante se ne fossero subito fornite le date di nascita e di morte, e di volta in volta, sul filo di una ricerca da parte dell’autore – o del personaggio che dice io in nome e per conto dello scrittore svedese Fredrik Sjöberg -, si accumulassero i particolari biografici a proposito di un pittore, anzi meglio di un acquarellista, divenuto famoso in America negli Anni Venti ma largamente sconosciuto in patria: “un pittore che nessuno ricorda”.
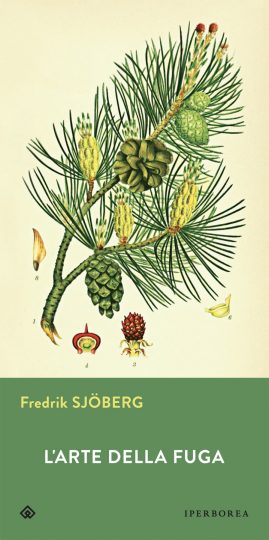
Il libro, viaggio sulle tracce di qualcuno vissuto in passato, sui luoghi che sono stati suoi e tra le persone che ne hanno serbato qualche memoria, è infatti nello stesso tempo anche un “altro” viaggio, quello che lo scrittore compie intorno non alla propria stanza, ma alla propria caccia – il che non è molto differente: per chiedersi infine se si possa e si debba raccontare “tutto” della vita d’un uomo. La risposta è incerta, ma intanto Sjöberg (autore, non dimentichiamolo, del sorprendente L’arte di collezionare mosche) lo fa, senza arretrare né davanti ai propri dubbi né tantomeno di fronte alle proprie scoperte.
Intanto, come in un romanzo, ci racconta la sua, di vita: che si incrocia neanche troppo paradossalmente, attraverso antenati, omonimie, analogie e distanze, a quella del “suo” pittore, del suo «amico» pittore; a quella esistenza in fuga, perennemente in giro per il mondo senza una ragione apparente se non trovare bei paesaggi da riprodurre. Mai una casa, sempre stanze d’albergo ed eventualmente una tenda o anche la sola automobile: mai un gesto clamoroso, una svolta radicale. Eppure questa esistenza in tono minore diventa, proprio per il fatto di essere inseguita appassionatamente, una grande avventura a due, irresistibile, tra umorismo e commozione, dove nulla è davvero “piccolo” e tutto è significativo.
E’ un segreto della letteratura, nella percezione che forse si sta affermando in questi anni: quando, sospendendo alcuni paradigmi, smette di dichiararsi come tale e prende la strada solo apparentemente più semplice, dove chi affronta la realtà, il ricercatore, lo scrittore, sa di doverlo fare nel modo più onesto possibile ma sa che questo processo modifica anche lui, l’osservatore sempre più coinvolto.
Qualcosa si sottrae, e quel qualcosa è il motore di tutto. In alte parole, vale un principio che viene enunciato non da Sjöberg, ma da Mauro Covacich, in La città interiore (La Nave di Teseo) quando parlando del padre e della madre scrive che “se la regina mi ha trasmesso la sua indole melanconica, è al re che devo la tendenza a mentire, ovvero a lavorare di immaginazione (mai di fantasia)”.

La citazione è irresistibile, come se L’arte della fuga chiedesse proprio di essere incrociato con questo (bel) libro italiano, dove una viaggio triestino, dunque un ritorno, incontra le molte figure e le infinite tragedie della città, Svevdao a Joyce ma anche Kafka, dalle foibe alle guerre balcaniche, risalendo fino al poeta “martire” – e quasi omonimo – Ivan Goran Kovačić che “testimone degli orrori dei nazionalisti croati, finiva ucciso per mano dei cetnici, ovvero dei nazionalisti serbi, in circostanze mai chiarite, il 13 luglio 1943”.
Mentire per affermare l’unica verità possibile. Per mettere la realtà – e noi stessi – con le spalle al muro. Mauro Covacich trova persino il suo Gunnar Widdfors, nella storia del pianista istriano Antonio Bibalo che, nell’immediato dopoguerra, esce di casa per comperare, dice, le sigarette, e fugge lontano, alla cieca. Dopo varie peregrinazioni diventerà in Norvegia un acclamato compositore, considerato dagli scandinavi un grande del Novecento, sconosciuto a Trieste e in Italia. Tornato, ultraottantenne, per un tardivo riconoscimento, finirà a ubriacarsi felicemente, in Istria, nella fattoria di un suo omonimo – ancora una volta, il gioco dei nomi – eletto a cugino; e dimenticando anche l’appuntamento per un’intervista con la Rai.
Che cosa si può dire di tutte queste vite, e soprattutto che cosa di se stessi, quando le si insegue con un’oltranza totale? La risposta sta forse in un terzo libro che sembrerebbe lontano da queste due straordinarie “invenzioni del vero” (appropriandoci del titolo di un saggio di Raffaello Palumbo Mosca, uscito qualche tempo fa dall’editore Gaffi) perché è all’apparenza un diario, un journal intime chiuso non nel perimetro di una stanza ma nottetempo, all’aperto, su una panchina di Viterbo o un balcone in Sardegna, o seduto alle verande di alberghi qui e là per l’Italia, dove un intellettuale vagante come sono gli intellettuali e gli scrittori fuma il suo toscano.
Si tratta di Massimo Onofri, critico letterario che ha da tempo rivelato almeno con Passaggio in Sardegna e Passaggio in Sicilia (entrambi usciti per Giunti), la sua vena narrativa. In Benedetti toscani (La Nave di Teseo) narra, tra ironia e passione, semplicemente se stesso, il suo “stilnovismo patologico”, le sue letture, gli amici (chiariamolo subito, per evitare conflitti di interessi: talvolta vi fa capolino anche il sottoscritto, convinto come Massimo – e soprattutto come Mario Soldati cui il titolo rende il dovuto omaggio -, che quantomeno per ciò che riguarda i sigari “a non fumare si rischia troppo”).
Il benedetto toscano resta un emblema stilistico – accanto a pochissimi altri, come una certa palma nana di Viterbo -, una cadenza anaforica, un elemento, se vogliamo, grammaticale. E’ il motore di un libro che spazia tra riflessioni saggistiche o introspettive a squarci di vera narrazione, diremmo con gusto distaccatamente fantasy, quando si rivolge a episodi molto privati e li trasfigura, trasfigurandosi. E’ un canzoniere d’amore (lo “stilnovismo” appunto) e una ricognizione post-arbasiana dello stato dell’arte in un Paese irritante e inevitabile. Un’invenzione del vero. Dopotutto, un romanzo.



