Una storia d’amore, ma anche il resoconto di quanto tale sentimento possa condurre alla distruzione di sé: su ilLibraio.it un capitolo dal nuovo romanzo di Giorgio Fontana, “Un solo paradiso”
Due vecchi amici si incontrano per caso nel bar che era stato un tempo il covo della loro tribù urbana. Si erano persi di vista e uno dei due, il protagonista, comincia a raccontare all’altro: che prima resta interlocutorio, poi stizzito, e infine folgorato dall’impeto inattuale della storia.
Alessio, sul finire dei vent’anni, un lavoro normale, originario di una famiglia delle montagne lombarde con un padre autoritario e un fratello sbandato, trombettista in una piccola jazz band, coltiva una mediocrità esistenziale: un “dolceamaro contentarsi”, lo chiama. Martina invece è magra e dal corpo agile e nervoso; viene da una famiglia di professionisti meridionali, non dice molto di se stessa, e i suoi gusti sono spesso poco originali. Due ragazzi qualunque: ma da questo “qualunque” si genera di colpo una strana forza tempestosa, una divina mania. Un fuoco breve che esplode per le strade di Milano – evocata limpidamente, quartiere dopo quartiere – e si consuma al suono di una musica febbrile…
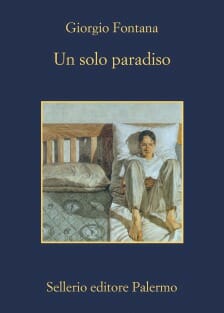
Torna in libreria per Sellerio il premio Campiello Giorgio Fontana, classe 1981, con Un solo paradiso, presentato come “una storia d’amore”, ma anche come “il resoconto di quanto tale sentimento possa condurre alla distruzione di sé”.
Su ilLibraio.it, per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un capitolo:
3
La sera in cui incontrò Martina, Alessio aveva camminato a lungo, alla ricerca di qualcosa che lo potesse ancora stupire. Viaggiando, aveva smesso di vivere le città come un turista o un avventore, eppure ancora non si era risolto alla condizione di semplice abitante di Milano. Evitava da sempre i luoghi più celebri, perché era come se fossero pervasi da una coltre di abitudini: lì era costretto ad ammirare a causa delle guide, dei consigli, e questo lo irritava. Aveva fede in altro: forme di bellezza minori, più vergini e solitarie, in grado di redimere perché nessuno ne aveva ancora saggiato il potere. Fu così che capitò al Cremisi, un bar abbastanza alla moda (avant-garde, si definiva) del quartiere Isola. Un posto che di solito non avrebbe mai frequentato. Entrò solo perché era stanco: quella passeggiata non aveva riservato illuminazione alcuna. Su uno schermo in fondo al locale veniva proiettato un film muto degli anni ’30. Dreyer? Forse. La musica era Motown di second’ordine; e il resto non migliorava le cose: tendine carta da zucchero, il bancone affollato da soprammobili e un proprietario inutilmente allegro.
Alessio ordinò un vodka tonic e sedette a due tavoli di distanza dagli unici altri avventori, tre ragazzi e due ragazze. Accarezzò il vetro spesso del bicchiere e si mise a guardare lo spazio che disegnavano le sue braccia chiuse.
Aveva lasciato da poco l’appartamento che condivideva con Luca in via Panfilo Castaldi, nella zona africana di Porta Venezia. Un trilocale piuttosto appassito con grandi infissi verdi, l’odore di cibi speziati che stagnava sulle scale, e un affitto ridicolo perché (stando al padrone di casa) era «pieno di negri e delinquenti, e chi mai vorrebbe abitarci se non due pirla come voi». Capitava spesso che ci fossero risse sul pianerottolo; ma a loro, e a tutti noi, piaceva. In fondo era un posto tranquillo, nonostante l’appartamento occupato al secondo piano dove si accumulavano sempre cugini e sorelle del presunto inquilino, e nonostante le grida del barbiere pazzo al pianterreno. Anche Luca era un tipo interessante: un gay maniaco di calcio – «Sono io il vero maschio della coppia», diceva sempre ad Alessio – che aveva fatto soldi vendendo su internet delle magliette storiche ma poco note, come quella dello Steaua Bucarest che perse la finale di coppa con il Milan nel 1989. La sua tesi era molto semplice: «Chi non vorrebbe una maglietta di quello Steaua? Una maglietta di Hagi? Dai!». E per quanto bislacca, l’idea aveva funzionato: proprio in quei mesi aveva ceduto il portale a una piccola azienda di software pavese, e nel contempo si era trasferito a Bologna per convivere con il suo nuovo fidanzato olandese, Pieter. Di conseguenza, Alessio aveva trovato un piccolo ma dignitoso monolocale in periferia nord-est, ai confini esterni di Lambrate. Da quanto ricordo e da quanto mi confermò, in quel periodo Alessio non era più triste e confuso come spesso gli era accaduto. Si trovava su un crinale piuttosto comune a quell’età: la linea che separa la disillusione dalla meraviglia residua; l’accettazione del presente dai sogni che ci sembravano promessi. Ma Alessio aveva un lavoro, cosa tutt’altro che scontata, e per di più un lavoro che non gli pesava troppo; e aveva degli amici che gli volevano bene. Cos’altro chiedere? Da qualche mese, dunque, aveva deciso di non chiedere più. Definì quel proposisto un «dolceamaro contentarsi»: una condizione tutt’altro che sgradevole, dopo anni passati a spiare la felicità altrui, senza capire in che modo edificare la propria. Quanto al tumulto che ancora gli si agitava dentro, lo metteva a tacere pianificando i soliti viaggi, e cercando di godere al massimo di questa o quella sensazione: una notte di sonno priva di incubi, una cena con gli amici, il suo amato girovagare da solo. Il resto era dedicato a minimizzare i fastidi. Non più febbre. Non più demoni. Viaggiare leggeri: era il solo modo per proteggersi dall’invadenza delle cose. Il piano suonava terribilmente artificiale, certo, e lui stesso lo ribadì durante la nostra conversazione al Ritornello. Ma funzionava. E del resto, che altro fare?
«Forse stavo già invecchiando», commentò. «Forse volevo invecchiare e basta». (Che verbo strano, per un uomo così giovane – eppure, allo stesso tempo, che verbo adatto. Forse le sue membra volevano reagire di colpo al caos, come a chiudere in fretta e per sempre le inquietudini dei vent’anni. Anch’io avevo provato qualcosa del genere: in certe albe particolarmente atroci, corrose dall’ansia, anch’io avevo desiderato una pace dei sensi. Alessio stava applicando alla lettera la lezione di quegli anni: abbandona ogni velleità, perché viviamo tempi miserabili e crudeli).
E del resto a volte bastava poco, davvero pochissimo; a volte era sufficiente prolungare il rientro a casa dall’ufficio e deviare verso il Parco Lambro, lasciarsi andare sull’erba per qualche istante: le rondini che si inseguivano nel cielo, l’odore di carne arrostita delle feste chiassose e colorate dei peruviani, le coppie di mezza età impegnate nel loro jogging serale. In altri casi aveva bisogno di passeggiate più lunghe: risaliva verso nord, superava la lunga e trafficata via Palmanova per poi perdersi nelle traverse di via Padova popolate di phone center, macellerie arabe e negozi di cianfrusaglie – gli archi del cavalcavia che la sera prendevano un’aria cupa e solenne insieme, il parco ex Trotter, i bar davanti a cui sostavano nervosi i ragazzi tunisini. Oppure scendeva a sud, dove piazza Leonardo da Vinci si allargava di colpo regalando uno scorcio quasi parigino alla città; e poi seguiva le vie ordinate e deserte di Città Studi, alberi e casette a due piani, il profilo del tram che tagliava una piazza. Amava il modo in cui Milano si lasciava plasmare dal percorso scelto, cambiando pelle dove tutti vedevano solo una coltre monotona di palazzi. Occorreva solo tenacia: quella città che tanto stancava i suoi amici (e che tanto aveva stancato me, al punto da averla abbandonata) per lui custodiva sempre un margine di incanto che gli apparteneva, persino una sorta di mistero. Noi non lo capivamo, eppure fu proprio al termine di una di quelle passeggiate che incontrò Martina al Cremisi. Era la metà di settembre, e lui aveva ventinove anni.
(continua in libreria…)


