Dalle pagine del commovente “Le stanze dell’addio” di Yari Selvetella affiora il volto di una giovane donna, Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si ammala e muore – Su ilLibraio.it un capitolo
“Io ho ricominciato a lavorare. In altri luoghi scrivo, succhio gamberi, respiro foglie balsamiche, faccio l’amore, ma una parte di me è qui, sempre qui, impigliata a un fil di ferro o a una paura mai vinta, inchiodata per sempre: il puzzo di brodaglia del carrello del vitto, quello pungente dei disinfettanti, il bip del segnalatore del fine-flebo, la porta che si chiude alle mie spalle quando termina l’ora della visita”.
Così si sente chi di noi vive l’esperienza di una perdita incolmabile: impigliato, inchiodato. Dalle pagine de Le stanze dell’addio (Bompiani) di Yari Selvetella affiora il volto di una giovane donna, Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si ammala e muore.
Il suo compagno la cerca, con la speranza irragionevole degli innamorati, attraverso le stanze – dell’ospedale, della casa, dei ricordi – fino a perdersi. Solo un ragazzo non si sottrae alla fratellanza profonda cui ogni dolore ci chiama e come un Caronte buono gli tende una mano verso la vita che continua a scorrere, che ci chiama in avanti, pronta a rinascere sul ciglio dell’assenza.
Selvetella nel libro dà voce a un addio che sembra continuamente sfuggire al tentativo di essere pronunciato.
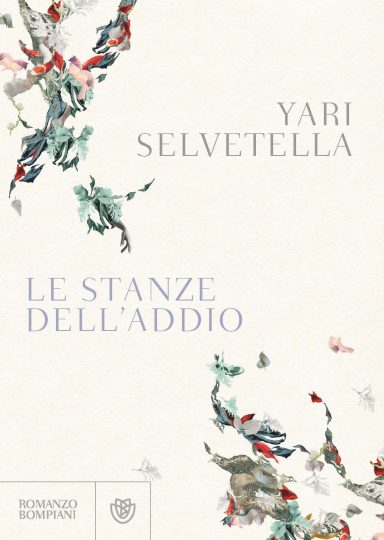
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un capitolo:
Il trolley
Vie tortuose regolano i passaggi da un settore all’altro dell’ospedale. Chissà per quale connessione, dalla porta del posto di polizia, superato il corridoio lungo le cui stanze è l’ora dell’aerosol, si accede a una delle numerose sale d’attesa, con tanto di display e indicatore acustico per il cambio d’utente. Che soddisfazione quando il bip scorre veloce e viene premiata la tenacia di chi ha resistito al suo posto, col numeretto in mano. Non è per mettermi in coda che sono qui, pensa l’uomo, non per godermi i vantaggi della rassegnazione, non per credere alle intermittenze della fortuna, riconoscendone in una fila snella la prova. Lei non c’è. Niente pasticcini al bar sulla via del ritorno,
niente premi, niente lampi di libertà sui lividi delle sue labbra, niente ginocchia sgranchite faticosamente negli scarsi metri quadri antistanti la pineta, che sovrasta la città intera. Anzi no, non intera. Nulla è intero o completo.
Riconosco questo posto. Ci siamo stati altre volte. Altre decine, altre migliaia e milioni di volte. Siamo stati qui tutti i giorni della nostra vita. Non abbiamo mai conosciuto altro. Non la luce del sole in un bosco, non l’umanità d’un campo arato. Siamo entrati una volta dalla porta principale, lì in fondo, dall’altro ingresso, quello da hall alberghiera del policlinico universitario. Tu avanti, io appena dietro col trolley, sulla fila di sedie in fondo, lontano dal chiacchiericcio, vicino alla finestra.
La mascherina. Non la vuoi la mascherina. Fa caldo con la mascherina. Non si respira bene con la mascherina, mettiti la mascherina. È nel trolley, dai, nella tasca esterna. Il solito trolley. Quello per compagnie low cost, appena fuori standard, quello per week end da genitori cocciuti, Roma Parigi Roma in trentasei ore, capito quale, quello sdrucito, cigolante, quello. Il trolley.
Ecco, il trolley.
C’è una sedia vuota, poi una sedia su cui dorme incastrata una giovane obesa e infine un’altra su cui è stato lasciato un trolley. Il mio, il nostro trolley. La tasca esterna è aperta. Bene, pensa l’uomo, vuol dire che indossa la mascherina, presa da lì. Non c’è lei, ma c’è il trolley. È piena di indizi, quella piccola valigia.
È colma di sollievo, eppure il cuore batte al solo toccarne la cerniera.
Gli oggetti autorizzano la speranza, basta toccarli. La zip scorre, si incastra per un dente mancante, niente di inatteso, anzi, un contrattempo noto, diciamo pure una tradizione di famiglia. Cosa contiene, cosa? Infine si apre. Guardare bene.
Un pigiama. Lo riconosce. Lo ha comprato lui a via Nazionale in offerta. Di flanella morbida, con minuscoli motivetti rosa. Erano i primi giorni di ricovero. La commessa, una ragazza dalle labbra spesse, tinte di amaranto lucido, sorrise molto e parlò con l’onesta crudeltà di chi non osserva bene gli altri.
Era convinta che fosse per una puerpera, il pigiama. Due, tre giorni al massimo di degenza e poi tutti a casa. Quanto male aveva fatto, senza volerlo. Dimostrava che al suo cliente e alla di lui consorte spettava figliare, non fuggire il peggio, dimostrava senz’altro che chi vive nel male è estraneo a tutti. Senza osare contraddirla, l’uomo aveva comprato il pigiama una taglia più grande e quindi lei, la malata, sembrava occuparne il volume quasi abusivamente, come un refolo vagamente e vanamente asseconda una bandiera, però aveva detto che era tutto a posto, dentro quel cencio che le cancellava il corpo.
Nel trolley non ci sono libri. Pessimo segno. Se si allontana porta senz’altro con sé il suo mondo di altri mondi. È alla ricerca perenne del paradigma perfetto. Quando legge un grande scrittore, ai suoi occhi si costruisce, vera e propria, un’altra realtà, non meno legittima della presente. È lì che sei? Lì dentro? Nei libri che hai portato via con te?
Ci sono le vecchie pantofole consumate. L’uomo ne prende una in mano e riesce a dirlo: le tue vecchie pantofole. Tu, migliaia di sigarette notturne al parapetto, nel silenzio bluastro della luna che ti illumina la pelle lucida di crema idratante. Quelle pantofole consumate, il malleolo, la caviglia, tutto così domestico e così sensuale. Su quel parapetto, luogo dei silenzi e delle ombre, il luogo in cui accanto al tuo riflesso, nella finestra, s’illuminano sbiechi certi ricordi scomodi: l’amore avvelenato di tua madre, l’immaturità colpevole e perenne di tuo padre. Infatti guardi altrove, per non ammettere quanto è doloroso non poterli perdonare e quanto è indigesto non ritenere che meritino una vendetta. Si potrebbe riparlarne, no? Se apparissi. Se, come niente sbucassi da una toilette, da una fumata proibita in un cortiletto. Il primo giorno che entrasti nel grande ospedale, ricordi?, avevi lividi sulla caviglia e uno sul braccio, lividi indolori e immotivati, ma volevi fumare a tutti i costi e quando svenisti io caddi insieme a te e il linoleum era liscio, senza un granello di polvere, e nel suo grigio ci specchiammo e già non eravamo più noi. Forse sarebbe una buona idea domandare, un po’ a tutti. Conoscete per caso una ragazza di Roma? È bionda no, mi scusi, era bionda. Ha gli occhi grandi, più grandi del normale, l’avete mica vista? Probabilmente fuma, o legge, o tormenta con l’indice il pollice. Quante decine di persone alle quali proporre sistematicamente lo stesso quesito, da stordire con l’insistenza, una fila indiana di
degenti, di pazienti capitati lì per controlli di routine e poi gli infermieri, tutti. Chiedere e non trovarti.
Copyright © Yari Selvetella
License agreement made through Laura Ceccacci Agency Srl
© 2018 Giunti Editore S.p.A./Bompiani
(continua in libreria…)


