Alberto Savinio (1891 – 1952), scrittore, pittore e compositore, sapeva di soffrire di allucinazioni. In questo breve saggio di Paolo Lanaro lo troviamo a Vicenza, complice il fantasma di Catrafossi…
FANTASMI IN CITTÀ*
Lasciata Padova dove, nella Cappella degli Scrovegni, aveva scoperto il segreto dell’arte di Giotto (una pittura-gioco, lineare e perfetta come una scatola di costruzioni colorate), Savinio riprese il suo viaggio. Appena il tempo di piangere il fiore prematuramente appassito di Angela Marcucci, che Savinio, complice il fantasma di Catrafossi, si ritrovò nell’elusiva Vicenza. Arrivato in Piazza dei Signori, cominciò a salire lo scalone della Basilica; a metà gli si parò davanti un mascherone con la bocca spalancata. «Ah, non è niente» esclamò Catrafossi «serviva per qualche denuncia anonima, ma ormai non se ne fanno più!». In cima, il grande salone vuoto, freddo, senza vita. Savinio grida il proprio nome e da tutti gli angoli la voce echeggia moltiplicata, fino a scemare nel nulla. «Ma questa è una nave!» sbotta, sicuro di vedere i crani pelati chini sui remi e di sentire perfino le grida ritmate del còmito: «Ma dove stiamo andando?». Ma ormai la nave era già salpata e, rischiarata dalla luna, correva veloce su un mare di pietra, zigzagando tra le insidie delle altane, delle torri, dei comignoli. Chissà dove puntava. Si stava tirando dietro come una rete a strascico i composti deliri di Savinio legati insieme a piccoli fasci di alghe morte, quando un’inattesa e provvidenziale cacca di colombo fece tornare le cose a posto.
Savinio sapeva di soffrire di allucinazioni. Fin da bambino sentiva pulsare nelle tempie qualcosa che scientificamente poteva essere definito emicrania ma che lui sapeva essere la rivelazione periodica di un formidabile potere immaginifico. Occhi vaganti nelle acque, fanciulle-galline con cresta e bargigli, torsi a forma di cetra, teste asinine, conchiglie volanti, quelle che più tardi gli amici parigini avrebbero considerato le creazioni di un’anima mitografica e irrazionale non erano che le visioni di un bambino geniale, oppresso da un fratello arrogante e dalla morte acerba di una sorellina. Savinio conosceva le fluttuazioni della coscienza, gli stati in cui questa cessava di essere un vizio legalizzato per diventare ciò che è davvero: uno scrigno stipato di ricordi, di illusioni, di presagi, di luci flebili e di suoni strimpellati. Di solito succedeva di sera. Nel chiarore fioco della camera cominciavano a danzare le figure, ombre tridimensionali, gocce che di colpo si trasformavano in oceani e oceani che diventavano pozzanghere luccicanti, colori che si liquefacevano e colori che ne sormontavano altri in un vertiginoso gioco caleidoscopico. E poi c’erano le voci, bocche che sussurravano tentazioni, digrignare di denti, labbra dischiuse in minuscoli gridi, mascelle gonfie che soffiavano. A volte Savinio credeva di ascoltare vere e proprie conversazioni, come se provenissero da una radio che trasmetteva da una lontana soffitta. Qualcuno gli parlava da tempo, di questo era certo; ma se fosse la voce suadente di Apollo, il fantasma di Catrafossi o la sua sorellina defunta non era chiaro. Il mondo dello spirito, pensava Savinio, assomiglia a una piazza affollata e vociante.
Senza sapere nemmeno lui in che modo, si ritrovò nel mezzo della scena del teatro Olimpico, nel punto in cui convergono le vie di Tebe. Lì nel cuore stesso della finzione e del trucco, i tempi si rovesciano, lo spazio si curva, la ragione rischia la catastrofe. Risuonavano nell’aria, fattasi greve, i pretestuosi versi di D’Annunzio: nel Teatro Olimpico, in coorti / i vasti versi astati e clipeati / del Tragedo cozzar contro le turbe. Volterra, Brescia, Ravenna, Vicenza: l’impareggiabile poeta aveva voluto onorare con un sonetto quelle che lui chiamava le «città del silenzio». Ma, come il custode raccontò all’esterrefatto visitatore, invece delle coorti e delle turbe nel settembre del 1882 arrivarono in teatro le acque del Bacchiglione in piena. Savinio rivide mentalmente la scena spaventosa del Titanic, solo che a essere squarciato dalle acque schiumanti non era la chiglia di un transatlantico, ma il proscenio del più incredibile teatro del mondo.
Il fantasma di Catrafossi, simile a un’immagine di vetro filato, sbucò all’improvviso da una delle vie scamozziane. Intimò a Savinio di tacere: sembrava un brusìo indistinto, ma poi, a poco a poco, il rumore si fece più nitido. Era Luigi Groto, il famoso «Cieco d’Adria», che stava recitando nel ruolo di Edipo. Un attimo dopo, appoggiato a un bastone, Groto si affacciò sul proscenio: le sclere annebbiate gli conferivano un carisma inesplicabile. Si muoveva con disinvoltura quasi conoscesse una per una le assi del pavimento. Savinio, paralizzato dalla sorpresa, ascoltava le parole di Sofocle pronunciate dalla voce grave del Cieco; assisteva alla nascita di un universo di dolore e di colpe, vedeva rivelarsi davanti ai suoi occhi le stanze più tenebrose dell’umano. Quella voce, sfuggita alla naftalina, faceva palpitare il pubblico che nel frattempo aveva invaso le gradinate, perforava l’aria come un assolo di violoncello, riportava da un passato chiuso a chiave la polvere turbinosa delle reminiscenze. Savinio svenne.
Era una bella giornata di sole. Savinio dimenticò in un attimo quel che era successo e si avviò verso il Campo Marzio. Lì lo aspettava il più autorevole e il più ingombrante dei fantasmi vicentini: quello di Antonio Fogazzaro. Quell’uomo fine e tormentato era nato con l’idea religiosa in testa e aveva speso quasi tutto il suo talento per dimostrare che scienza e religione non sono incompatibili. Nessun uomo di scienza ci aveva creduto, come non ci aveva creduto nessun uomo di chiesa e Fogazzaro era rimasto solo in mezzo al guado, attaccato alla fede e nello stesso tempo incapace di ignorare i richiami della ragione, come un San Tommaso in abiti moderni, fiero e disperato della propria sottigliezza.
Savinio si sedette al caffè Moresco e ordinò caffelatte e brioche. Catrafossi si era allontanato e questo, se si considera la petulanza di quel fantasma invadente, non poteva che essere un bene. Savinio non fece in tempo a sospirare di soddisfazione che si accorse che il tavolo accanto era stato prontamente occupato da Franco e Luisa Maironi, dal figlio Piero, dalla piccola Ombretta, da Jeanne Dessalle, da Daniele Cortis e da altri ancora. Fogazzaro li guardava con affetto. Quei personaggi avevano riempito le sue giornate, lo avevano vegliato durante le notti insonni, lo avevano divertito e fatto piangere. Savinio avrebbe voluto discutere con Fogazzaro di varie questioni, ma il susseguirsi durante la giornata di tutti quei colpi di scena gli aveva causato una perdurante smemoratezza dentro cui era affogato il ricordo, un tempo vivo, delle opere dello scrittore. Affioravano invece spezzoni casuali: una visita al convento di Praglia e l’immagine malinconica di un vecchio corvo a cui i frati avevano mozzato le ali, uno zio cattolico che combatteva il modernismo fogazzariano sostenendo che i romanzi erano pieni di idiotismi, un cognato che aveva adoperato intere frasi di Leila per dichiararsi alla sua futura moglie.
Tornò a galla anche il ricordo di un’antica gita in Valsolda, dove Fogazzaro aveva la sua villa e dove era ambientato Piccolo mondo antico. Quel giorno soffiava perfino la breva, come all’inizio del romanzo, e la piccola casa davanti a cui si era fermato sembrava tuffarsi nel lago coi suoi embrici avvizziti. Apparve il giardino pensile, poi l’olea fragrans, che venne addirittura portata a Vicenza per i funerali dello scrittore, e poi il cipressino e il parapetto, il carrubo e le rose. Qualcuno si mise a rievocare la tragica fine di Ombretta, una delle pagine più tristi della letteratura mondiale, mentre tutti guardavano commossi verso la darsena maledetta. Purtroppo, come fece notare un postino di passaggio, la casa di Fogazzaro non era lì: era un po’ più in basso. Savinio risalì in auto e diede l’addio definitivo a quel piccolo mondo antico che, convocato da Fogazzaro, adesso si era riunito ancora una volta al Caffè Moresco e andava lentamente scomparendo assieme agli ultimi raggi di sole.
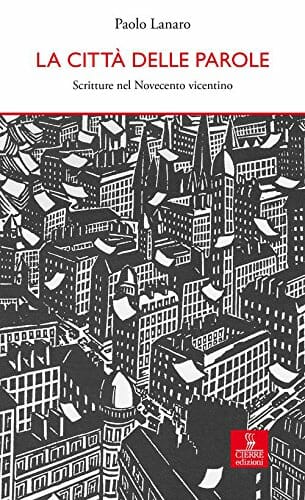
* Il brano che riproponiamo per gentile concessione dell’autore, è tratto dalla raccolta di saggi La città delle parole – Scritture nel Novecento vicentino (Cierre edizioni).
Paolo Lanaro, nato a Schio nel 1948, vive a Vicenza. Ha insegnato filosofia nei licei e ha pubblicato sei raccolte di versi: L’anno del secco (Savelli, 1981); Il lavoro della malinconia (La Locusta, 1989); Luce del pomeriggio e altre poesie (Scheiwiller, 1997); Giorni abitati (Ripostes, 2002); Diario con la lampada accesa (Edizioni del Bradipo, 2005). La sua penultima raccolta, Poesie dalla scala C (L’Obliquo, Brescia, 2011) è stata finalista al Premio Viareggio 2011, al Premio Diego Valeri 2012 e ha vinto il premio Contini Bonacossi 2012.
E’ da poco stata pubblicata da Marcos y Marcos la sua ultima raccolta di liriche, Rubrica degli inverni (qui i particolari e alcune poesie).
Lanaro ha inoltre curato l’antologia Forme del mistico (1988) e nel 2007 ha dato alle stampe In tondo e in corsivo, un’antologia di saggi e interventi critici su scrittori veneti del ‘900.


