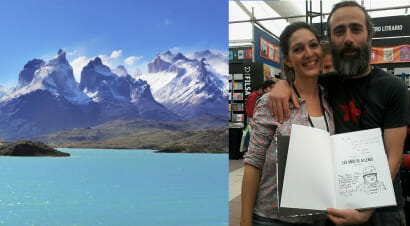Silvia Falorni, traduttrice e insegnante, parlando di “Di perle e cicatrici” dello scrittore Pedro Lemebel, ci racconta anche del Cile di ieri e di oggi, terra in cui vive: “Un libro che ho scelto di tradurre negli stessi luoghi in cui è stato scritto, in quella Santiago piena di contrasti e contraddizioni in cui mi sono trasferita per comprendere fino in fondo la scrittura e il pensiero di questo artista coraggioso, capace di osservare e raccontare il proprio paese dall’avamposto più estremo dell’esclusione sociale” – La sua riflessione per ilLibraio.it
Un linguaggio che richiama l’oralità e pensato per l’oralità, elementi barocchi, guglie letterarie costruite con un’ironia tagliente e allo stesso tempo con una tenerezza sconcertante; parole inventate, colorate, e metafore argute: sono solo alcuni degli elementi che compongono lo specchio narrativo racchiuso in Di perle e cicatrici (Edicola) dello scrittore cileno Pedro Lemebel (nella foto di © Alvaro Hoppe, ndr), una raccolta di settanta cronache scritte per il programma radiofonico Cancionero e andate in onda nel corso degli anni Novanta.
Un libro che ho scelto di tradurre negli stessi luoghi in cui è stato scritto, in quella Santiago piena di contrasti e contraddizioni in cui mi sono trasferita per comprendere fino in fondo la scrittura e il pensiero di questo artista coraggioso, capace di osservare e raccontare il proprio paese dall’avamposto più estremo dell’esclusione sociale.

Succedeva così che quando Lemebel citava Las Lanzas, ancora oggi ritrovo degli imborghesiti militanti di sinistra, che lui chiama whiskinistra, io mi sedevo ai tavolini dello storico locale per osservarli da vicino. Quando raccontava del movimento artistico e di protesta che si creò attorno al garage Matucana 19, con la metro raggiungevo la fermata Universidad de Santiago e cercavo il civico 19, per vedere il negozio di ricambi per auto in cui si era trasformato “il cuore duro di quella Santiago esasperata dal digrignare della protesta”. Quando descriveva il fiume Mapocho, quell’“innocente filo di fango”, che nel suo serpeggiare attraversa democraticamente tutte le classi sociali che compongono la città, o il Bellavista, “il quartiere culturale, la zona semituristica, semiartistica, semi-basso proletaria”, o gli enormi cartelli pubblicitari installati dalle imprese sui tetti dei casermoni in cambio della promessa dei vetri alle finestre, a me bastava uscire di casa e proiettarmi nelle parole che stavo traducendo.
Il libro mi circondava e allo stesso tempo si trovava fra le mie mani, apparendo piano piano nello schermo del computer in un’altra lingua. Era una sensazione euforica ed esaltante. E mentre vivevo completamente immersa nel carnevale di voci e colori disegnato da Lemebel, scoprivo la dolorosa storia del Cile, conoscevo i volti della dittatura, percepivo la paura senza fine di chi aspetta il rumore sordo degli stivali militari alla porta, scoprivo come la televisione, i festival della canzone e i concorsi di bellezza avevano distratto una nazione intera mentre centinaia di persone sparivano e morivano, in quella Santiago “imbavagliata dal coprifuoco”.
Lemebel sceglie di raccontare tutto questo attraverso la cronaca, sovvertendo e reinventando l’uso tradizionale di questo genere. Dal latino chronica e dal greco χρόνος chrónos, in passato la cronaca è stata usata per narrazioni storiche, scritte appunto secondo il criterio cronologico. Vicende importanti, quindi, imprese e spedizioni, con personaggi illustri come protagonisti. Lemebel sceglie invece di dedicare questo genere a chi ha vissuto ai margini, alle vittime, agli scomparsi, dando una voce a chi non l’ha mai avuta, a quelli che per lui sono i veri personaggi illustri della storia.
Le perle di cui Lemebel ci parla sono la ricchezza ostentata, l’eccesso decorativo, gli spazi e i corpi che rappresentano la superficialità, l’apparenza, quell’aristocrazia infiocchettata fedele a un’estetica che vorrebbe rimuovere il passato. Le cicatrici sono invece quelle ferite indelebili che non vogliono e non possono essere dimenticate, anche se cancellare il passato, o falsificarlo per farlo sembrare qualcos’altro, è proprio ciò che la maggior parte della società cilena ha desiderato durante gli anni della transizione. Da un lato quindi il richiamo della risata facile e della felicità a basso costo offerta dal neoliberalismo, dall’altro la necessità di proteggere la memoria storica; da un lato la manipolazione della verità (“sembra impensabile credere che con un armamento del genere, la sovversiva ribellione non avesse successo” commenta ironico Lemebel quando la televisione accusa ingiustamente la resistenza di essere in possesso di grandi arsenali di armi), dall’altro la cruda realtà, così come appare sul volto torturato e coperto dal trucco di Karin Eitel quando viene obbligata, in diretta TV, a prendere le distanze dal gruppo di protesta cui apparteneva, o su quello bruciato di Carmen Gloria Quintana, aggredita durante una manifestazione, la cui vicenda rappresenta una “fattura” molto amara sul conto della democrazia.
Per tradurre Di perle e cicatrici era necessario scendere nelle profondità della storia del Cile e nei labirinti del linguaggio unico di Lemebel; era necessario interiorizzare un contesto e percepirne le ferite, sintonizzandomi al tempo stesso sulla sottile ironia dell’autore, sul suo linguaggio popolare, sulla sua estetica rivoluzionaria; per dire quasi la stessa cosa, citando Eco, era necessario tradurre Lemebel là dove Lemebel ha vissuto, osservato, interpretato e denunciato. Alla fine tutte le parole sono andate al loro posto, anche quelle che sembravano intraducibili, unendosi a formare un testo che oggi, a distanza di vent’anni dalla sua pubblicazione in Cile, rivela la sua capacità di vincere la sfida del tempo: in quest’epoca di amnesia storica e di grandi contraddizioni, Di perle e cicatrici ci mostra quanto sia sottile il confine tra l’essere tacitamente complice e l’essere colpevole.
“Tutto il Cile sapeva e taceva, qualcosa avevano raccontato, qualcosa era stato detto, qualche pettegolezzo da cocktail, qualche chiacchiera da pittore censurato. Tutti vedevano e preferivano non guardare, non sapere, non sentire quegli orrori che filtravano dalla stampa straniera. Era troppo terribile per crederci. In questo paese così colto, di scrittori e poeti, non succedono queste cose, pura letteratura tremendista, pura propaganda marxista per screditare il governo, diceva la Mariana alzando il volume della musica per coprire i gemiti strozzati che trapelavano dal giardino.”
Tratto da Le orchidee nere di Mariana Callejas, in Di perle e cicatrici di Pedro Lemebel (Edicola, 2019 – trad. Silvia Falorni), la cui storia ha ispirato Notturno cileno, di Robeto Bolaño.
L’AUTRICE – Silvia Falorni è traduttrice e insegnante. Attualmente vive a Talca, in Cile.