Antonio Franchini è uno degli editor italiani più noti è anche un apprezzato autore. E ora torna in libreria con “Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani”, in cui rivela fragilità e paure dell’uomo contemporaneo. Ne scrive su ilLibraio.it (che pubblica uno dei racconti, “Il suicidio dell’indiano”) Mario Baudino – L’approfondimento
Antonio Franchini (direttore editoriale del gruppo Giunti, ndr) torna alla narrativa dopo una decina d’anni, col suo passo misurato e quasi guardingo, il suo gusto dello stile (nella scrittura e nella vita) che gli fa scegliere ogni volta una posizione, un punto di partenza quasi defilato. Lui che di mestiere è un celebre editor e ha lanciato una serie impressionante di best seller, quando si misura in prima persona con la letteratura diventa scrittore vagamente elusivo, come del resto i suoi personaggi, sempre in lotta con una leggera inquietudine, una sorta di perplessità metafisica.
Può succedergli, e accade al suo alter-ego di Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani (NN editore), di spingersi “come un giocatore”, a vedere anche “una puntata che non lo convince fino in fondo”: nel caso specifico, e siamo in Pesca alla trota in Carnia, per seguire un amico in Friuli che deve incontrare il padre (odiato) e pescare trote fario nel Tagliamento, fiume caro a Hemingway – dove l’autore americano incontrò il suo ultimo amore.
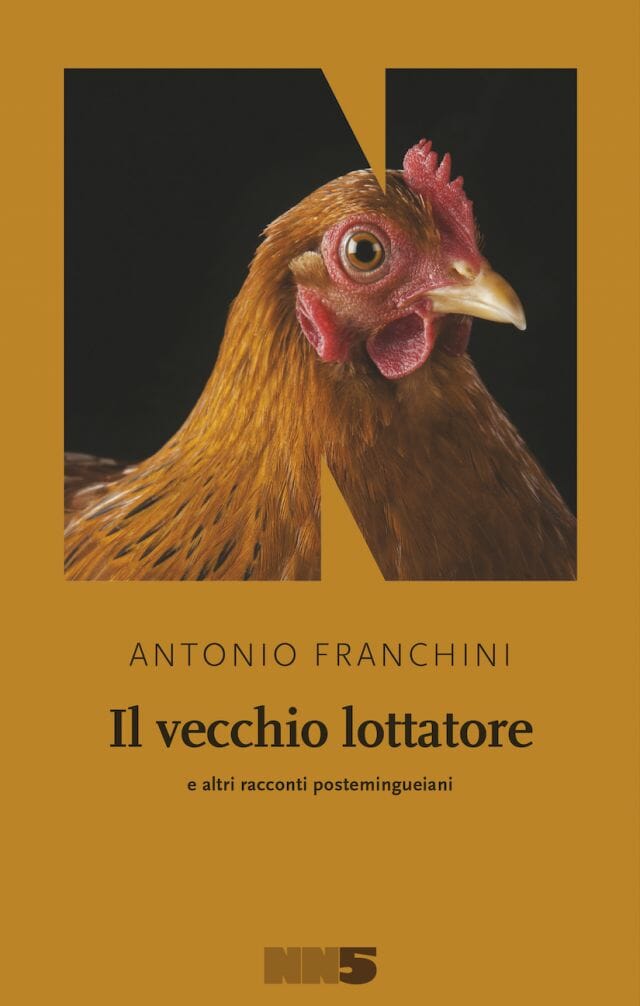
Questi racconti definiti “postemingueinai”, e il segno metaletterario è davvero forte, non sono tuttavia un particolare omaggio allo scrittore, né tantomeno un esercizio di mimesi: sono, verrebbe da dire semplicemente, scritti tenendo conto che, nei luoghi narrati, siano essi reali, geografici, o tematici, letterari, sentimentali, e quindi non del tutto reali, né del tutto immaginari, l’autore americano è pur passato.
Sette in tutto, ne percorrono una sorta di perimetro irregolare, dalle riflessioni di un padre durante una gara atletica della figlia bambina alla storia dei due ultimi italiani che rimasero, dopo la guerra e la grande fuga degli istriani, a Caporetto divenuta la slovena Kobarid, all’incontro rivelatore con un altro italiano, ossessionato dalla corrida, ossia “aficionado”; da una – riconoscibilissima – traduttrice che gli precisa di non aver mai scopato con Hemingway, come invece si ritiene comunemente nella società letteraria, al diario del “vecchio lottatore”: che è il culmine e il cuore dell’intero libro, quasi un romanzo breve a se stante, dagli evidenti risvolti autobiografici.
Franchini ha una misura assai particolare nell’essere al tempo stesso preciso e quasi infallibile quando descrive, senza mai ridurre la realtà al piano della semplice cronaca o del reportage ma in qualche modo osservandola dal punto di vista del proprio esserne investito e trasformato: è forse la stessa tecnica del lottatore, che sa arretrare o caricare quando serve, regolandosi sulla forza del rivale affratellato nel confronto. La troviamo ad esempio nel libro su Giancarlo Siani (L’abusivo) o in quel diario di un viaggio in India che è Signore delle lacrime, in perfetta specularità: da una parte l’evento ha una ricaduta immensa sull’autore, dall’altra proprio la sua distanza culturale da quanto accade apre un’interrogazione (su se stesso). Qui, nei racconti, il gioco di intimità ed estraneità ha tratti persino virtuosistici (ma sempre a favore del secondo elemento) a partire dal nome che l’autore sceglie per sé, Francesco Esente. E si palesa parlando per lo più di amici, di grandi amici scomparsi, dunque di lunghi percorsi di vita, conoscenze, sentimenti, avventure condivise.
A volte è sufficiente una parola, una frase. Quando narra di “Sergione” (Sergio Altieri, scrittore ed editor, 1952 – 2017) si scopre a concludere che forse “tutto è discutibile nella sua vita… ma qualche gesto esatto, pulito, gli è riuscito”. Ricorda la fine di Roberto Bonelli, scalatore sessantottino (il “Mucchio Selvaggio” si battezzarono lui e il suo gruppo, e invece delle solite vie inventarono l’arrampicata libera sulle falesie, un gioco dove la morte aveva ed ha un ruolo cospicuo e nello stesso tempo accettato) guardando il fiume stranamente “deserto, in un giorno meraviglioso d’estate” dopo una lunga e difficile discesa in canoa, e decide che dunque “i fantasmi s’erano dati convegno per scortarlo, eclissando i vivi in una parentesi di luce”. Come Henry Miller, può certamente affermare che tutti i suoi personaggi sono stati “vivi” e gli hanno parlato, ma qui si tratta di alpinisti, lottatori, canoisti, in altre parole di persone che hanno cercato il loro stile nella forza fisica e nell’esattezza dei gesti, non – salvo Hemingway beninteso – di scrittori del passato. Ma Hemingway è silenzioso, è un’ombra, uno spunto morale. Gli uomini evocati da Franchini sono presenti con lo spessore della loro vita – anche se ormai scomparsi – e, come dice nella nota finale, “anime grandi e inquiete”.

Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti (foto di Francesco Giusti)
Appartengono a quello che un filosofo come Peter Sloterdijk definisce il “mondo timotico”, ovvero relativo al thymòs greco, il mondo del coraggio, dell’”animo”, dell’orgoglio e del risentimento, della nobiltà e si potrebbe aggiungere dello stile come istanza etica: per esempio nell’accettare, come fanno i personaggi di questo libro, la difficile ritualizzazione del confronto fisico.
È anche un mondo che da Platone in poi ci si è chiesto come “addomesticare”, ovvero rendere non autodistruttivo, ed è questo, oggi, un tema certamente “postemingueiano”; che il vecchio lottatore, trasfigurazione ultima di Francesco Esente, affronta come interrogando un destino. A suo tempo Hemingway, alla fine, ne fu sconfitto. Per Franchini si è parlato invece – ad esempio da parte di Raffaello Palumbo Mosca – di “letteratura come epicedio, ossia come possibilità di replicare la concretezza della morte in altra forma, sublimata perché accertata, perché resa parte di altre vite”.
In questi racconti, soprattutto diremmo nell’ultimo, grandioso ed epico che dà il titolo al libro – ma anche nell’immagine scelta diremmo dall’autore per i risguardi della copertina, dove un torero famoso, che morirà nell’arena, fissa con quasi impersonale intensità il volto dell’amico, appena ucciso dal toro, e davvero non si sa quale dei due in quel momento sia vivo e quale morto -, in queste storie di uomini che affrontano il dolore, che conoscono la sensazione di pienezza donata dal fluire della forza quando il corpo la dispiega come liberandola, e conoscono altrettanto intimamente la paura, l’esaltazione, la malinconia, la risposta o meglio la proposta di Franchini si appella a una misura di stile come sentimento: sulla scena della vita così com’è, mai del tutto effabile, e della letteratura così come dovrebbe essere, mai del tutto definibile.
Può interessarti anche
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo uno dei racconti tratto da Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani:
IL SUICIDIO DELL’INDIANO
Nelle opere dei grandi americani non tutto mi tornava, il senso di alcune battute, la coerenza di qualche dialogo, il perché di certi gesti. A volte poteva essere un problema di traduzione, ma a volte no. Anche con Hemingway mi è capitato spesso.
Per esempio, nel racconto Campo indiano, uno di quelli più celebri con protagonista Nick Adams, il pellerossa che si taglia la gola perché non sopporta il dolore della moglie che partorisce è una delle cose che devo ancora capire.
È in corso un travaglio difficile al campo indiano e il padre di Nick Adams, che fa il medico, viene prelevato da un gruppo di pellerossa e condotto in barca all’altro lato del lago per aiutare la donna a partorire. Non è ancora l’alba e il padre porta Nick con sé.
La donna si lamenta da due giorni, ma il dottore è arrivato e le pratica un cesareo d’urgenza “con un coltello a serramanico e due metri e mezzo di filo da pesca”. Nasce un maschio, sano, e la donna sopravvive, ma il marito nella sua cuccetta si è ucciso tagliandosi la gola da un orecchio all’altro.
Ma perché? Perché si uccide l’indiano?
Perché, se non lo ha fatto prima che il dottore arrivasse, lo fa adesso, quando il dottore è sul posto e sta già operando la donna e probabilmente la salverà?
Hemingway non lo spiega.
Alla giusta domanda di Nick: “Perché si è ucciso, papà?” risponde soltanto: “Non so, Nick, non ha potuto resistere, immagino”.
La spiegazione non poteva convincermi anche perché nei libri di avventura che avevo letto e nei film che vedevo ci spiegavano che gli indiani sopportavano il dolore meglio di chiunque altro.
C’era un immaginario intero sul loro stoicismo: un film celebre in quegli anni, Un uomo chiamato cavallo, aveva reso noto il sanguinoso rito chiamato sun dance.
Era un sacrificio iniziatico nel quale il danzatore si per forava il petto con due ossa di bisonte legate a un albero sacro per mezzo di funi e girava in tondo per ore emettendo un suono lamentoso da un fischietto ricavato da un osso d’aquila, finché il petto non si lacerava.
Questo, ci raccontavano, sapevano sopportare gli indiani, ed ecco che uno di loro si tagliava la gola perché incapace di reggere una sofferenza neanche sua, ma della moglie che stava partorendo, un atto naturale che, rispetto alle donne dei paesi progrediti, le native sbrigavano – forse era un altro luogo comune – senza nessuna particolare ansia.
Non si spiegava. Soprattutto non si spiegava perché Nick non facesse al padre la domanda più ovvia: se quell’uomo ha sopportato i lamenti della donna per due giorni, perché si è ucciso proprio quando sei arrivato tu e la sua agonia stava per finire?
Quelle che venivano dopo, nella loro sconcertante semplicità, erano tra le battute di dialogo più belle che io conoscessi:
“Molti uomini si uccidono, papà?”. “Non moltissimi, Nick”.
E subito dopo:
“È difficile morire, papà?”.
“No, credo che sia piuttosto facile, Nick. Dipende”.
Questo dialogo era stato scritto da un uomo che si sarebbe ammazzato, a proposito di un genitore che si sarebbe ammazzato, perché il racconto è del 1924 e il dottor Clarence Hemingway si uccide quattro anni più tardi.
Le conferme biografiche conferivano al tutto un tono di autenticità che qualsiasi altro passo della letteratura che conoscevo avrebbe difficilmente eguagliato.
La bellezza e l’inspiegabilità qualche rara volta procedo no di pari passo; non sempre – la creazione dovrebbe essere plausibile per non trasformarsi in arbitrio – ma qualche volta succede.
L’esergo più bello e più famoso di Hemingway è quello delle Nevi del Kilimangiaro: “Il Kilimangiaro è un monte coperto di neve alto 5895 metri, e si dice che sia la più alta montagna africana. La sua vetta occidentale è chiamata, dai Masai, Ngàje Ngài, la Casa di Dio. Vicino alla vetta occidentale c’è la carcassa rinsecchita e congelata di un leopardo. Nessuno ha saputo spiegare cosa cercasse il leopardo a quell’altitudine”.
Seppi del mistero del leopardo sul Kilimangiaro molto presto, ero un bambino, non dal racconto, che non avrei ancora potuto leggere, ma da un film del 1952 con Gregory Peck e Ava Gardner che era passato in televisione e mi ave vano permesso di vedere.
La programmazione della Rai in quegli anni prevedeva film due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì. Cominciavano alle nove, quando i piccoli andavano a letto, e i geni tori di allora consentivano la visione solo in casi eccezionali: premi per successi scolastici, concessioni dietro promesse di miglioramento o scongiuri in ginocchio.
Io chiedevo la grazia in caso di western o di film africani.
Come ogni bambino avevo un animale prediletto, era il leopardo.
Lo era da quando avevo visto su Natura viva, l’enciclopedia degli animali che più di ogni altro libro sfogliavo e legge vo nei pomeriggi di un’infanzia solitaria, una pagina intera con l’incedere possente e flessuoso di un leopardo nell’atto di attraversare un sentiero. Sotto l’immagine era stampata una frase di un tale Brehm, evidentemente un illustre zoologo tedesco: il leopardo, o pantera, è il più bello fra tutti i felini della fauna terrestre.
Se lo dicevano l’enciclopedia degli animali e l’autorevole signor Brehm doveva essere vero, ma lo vedevo anche dalla foto, che mostrava un esemplare magnifico per eleganza e forme.
Allora non esistevano tante rappresentazioni della natura fatte apposta per piacere; scattate, ingrandite, evidenziate solo allo scopo di suscitare stupore o tenerezza. Non c’erano detta gli di paesaggi o di cuccioli, di delfini, di tigrotti, di orsi e orsetti, di cani e gatti in pose leziose. Era un mondo più asettico e oggettivo, con poche concessioni al sentimentalismo animale.
Da quanto si vedeva nelle pagine di Natura viva, il leopardo poteva davvero aspirare al titolo di felino più bello, però della bellezza facevano parte per noi bambini anche altri due attributi, la grandezza e la forza. Non esisteva tra quei ragazzi un’idea della bellezza di per sé, assoluta e pura.
E qui le cose si complicavano, perché il leopardo era oggettivamente più piccolo di leoni e tigri e, benché molti testi sottolineassero la straordinaria potenza delle mascelle e delle zampe che gli consentivano di trascinare le prede sugli alberi per divorarsele in pace, era evidente che in uno scontro diretto con la tigre o il leone nessun leopardo avrebbe avuto scampo.
Così l’idea della bellezza del leopardo mi cresceva dentro sminuita, minacciata da relativismo e dubbi.
Poi ci fu un altro fatto, più o meno contemporaneo e – mi rendo conto adesso – assai simile, anche se su un piano tutto diverso.
C’era un programma all’epoca – doveva essere il 1966 – che andava in onda, come tutti i varietà, il sabato sera, e lo presentava un giovane cantante confidenziale, un crooner italiano di formazione americana che si chiamava Johnny Dorelli. Come valletta aveva una ragazza inglese con un nome che si sarebbe marchiato a fuoco dentro di me: Margaret Lee.
Il varietà non mi interessava affatto, ma in casa tutti lo vedevano e nella sera prefestiva anche i piccoli potevano andare a letto più tardi, quindi era difficile sottrarsi al rito familiare della televisione al sabato.
Così il mio sguardo cadde su Margaret Lee, mi parve bellissima e me ne innamorai.
Se adesso mi domando perché, non posso pensare che all’incontro fortuito tra il sorgere del primo embrione di desiderio e l’immagine femminile più potente che il mezzo più forte di quel tempo, la televisione, potesse offrire: la soubrette dello spettacolo del sabato sera.
Aveva una bella bocca, ma questa non credo che a un bambino di quegli anni potesse evocare un desiderio preci so. Ricordo bene che mi colpì perché era morbida e incerta nell’articolare una lingua non sua. Parlava l’italiano come lo parlavano o lo avrebbero parlato Mal dei Primitives o Shel Shapiro e tutti gli inglesi che avevano successo in Italia mentre gli italiani sognavano l’Inghilterra.
Esserne innamorato significava che ne contemplavo a lungo le immagini quando compariva non solo sullo schermo ma sui rotocalchi che si leggevano in casa, senza avere però il coraggio di ritagliarle, e che andavo a cercare il suo nome sulle pagine degli spettacoli nel quotidiano, perché aveva anche girato qualche film.
Mi bastava identificare, nell’elenco della programmazione dei cinema, la sigla m. lee tra i protagonisti di un film per cadere in uno stato di deliquio, come se anche nelle lettere stampate del suo nome la mia immaginazione delirante ritrovasse un ulteriore riflesso del suo fascino.
In quella specie di tribunale sempre riunito che erano le famiglie, dove i componenti di generazioni diverse vedevano e commentavano le stesse cose nello stesso momento, Margaret Lee era considerata all’unanimità una bella ragazza.
Non credo proprio che il mio amore discendesse dall’approvazione familiare e per giunta si trattava di un segreto che avrei difeso con la vita, ma certo il fatto che anche gli altri la ammirassero e la trovassero bella mi confortava e mi faceva piacere.
Per questo posso ricostruire ancora con assoluta nitidezza l’angoscia che mi avrebbe colpito non molto tempo dopo. Forse era passato un anno, quando Margaret Lee riapparve sullo schermo, all’improvviso, in una pubblicità di Carosello.
Mi ricordo perfettamente di quel momento, perché avevo notato subito che c’era qualcosa che non andava. Aveva un taglio di capelli diverso, che metteva in risalto alcune irregolarità del volto che prima non si notavano, e si muoveva con impaccio facendo delle strane, incongrue mossette. Era come se quell’incertezza che prima era concentrata solo nelle sue labbra morbide si fosse estesa a tutto il corpo.
Subito sentii qualcuno di casa dire: «Ma è Margaret Lee, quella? Ma guarda come s’è fatta brutta!».
Io lo avevo capito subito – essere piccoli non confonde la sensibilità, ma la acuisce, la esaspera come una lama che incide, e la sensibilità dei bambini è sia quella lama sia quel taglio – ma, a differenza dei miei familiari, io ero colui che l’amava e non potevo rinnegarla con la stessa superficialità.
Anzi, era come se la disapprovazione generale mi facesse crescere dentro un senso di colpa e di vergogna, quasi che potessi essere ritenuto io stesso, per assurdo, responsabile di quel mutamento, come se fosse stato il mio amore a guasta re la bellezza di Margaret Lee.
Era una vergogna che però fortificava il mio sentimento: come l’anno precedente l’amavo di una passione segreta e felice, adesso le dedicavo una devozione addolorata, al punto che distinguevo un 1966 di gioia in cui facevo la terza elementare, portavo un luminoso fiocco verde, il mio rendi mento scolastico era buono e Margaret Lee era bella, da un 1967 in cui al cupo fiocco di colore blu notte che nella mia scuola indicava l’appartenenza alle quarte si accompagna vano un esito negli studi assai più incerto e lo sfiorire della persona amata, tutti segni che le età dell’oro non appartengono a un generico destino dell’umanità e non si misurano su cicli di millenni, ma stanno dentro la vita di ciascuno, si possono conteggiare in mesi e giorni e quando finiscono lasciano il posto non a una decadenza condivisa e vaga, ma a una desolazione acuta, personale, che non si può spartire con nessun altro.
La fragilità della bellezza minacciava dunque tanto il leopardo quanto Margaret Lee, ma mentre l’attrice si avviava a un destino di oblio tanto nel mondo dello spettacolo quanto in quello dei miei sogni, ecco che scoprivo come al leopardo, al mio animale prediletto, Hemingway avesse offerto una grande opportunità.
Non c’era la carcassa di un leone sulla giogaia del Kili mangiaro, ma quella di un leopardo, che quindi non era solo un animale bello, ma avventuroso, irrequieto, caratteristiche in massimo grado umane e desiderabili.
E andando verso l’adolescenza, un’età meno poetica, meno immaginativa dell’infanzia nelle sue fantasiose associazioni e più prevedibile nelle sue ossessioni, Margaret Lee mi abbandonava, sostituita da altre creature forse non meno immaginarie ma certo meno distanti, mentre il leopardo di Hemingway stava ancora al mio fianco e, anzi, le risonanze della sua fine inverosimile vibravano ancora più profondamente dentro di me.
No one has explained what the leopard was seeking at that altitude. Il leopardo va cercando.
Andare cercando.
Libertà vo cercando…
Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone… Che cosa vai cercando nella città dei morti…
Chi va cercando, vive. E chi cercando muore è come se, nel mistero della sua ricerca, continuasse a vivere. Hemingway sapeva che a certe domande non bisogna dare risposta e certi misteri non vanno spiegati o tutto svanisce.
Se il suicidio dell’indiano era illogico, così doveva rimanere. Se fosse stato lì da solo, sarebbe stato un’incongruenza del racconto e basta, ma siccome era accompagnato dal la conversazione tra padre e figlio più bella e più radicale dell’intera sua opera, era bene che restasse inspiegato.
La cittadina dove ci fermammo, in un viaggio americano, si chiamava Alamosa e vi facemmo tappa per una sosta in motel sulla via di altre destinazioni più celebri in Colorado.
Il motel dava sullo spiazzo di cemento di un centro commerciale. All’ingresso, attorno a un tavolino e sulle poltrone di plastica, ciondolava un gruppo di lavoratori messicani fumando e bevendo birra.
La pila di giornali che stava nella lobby era tutta di co pie di The Gator Magazine, l’organo ufficiale – avremmo scoperto – di uno zooparco con alligatori, caimani e serpenti, vanto della contea assieme a uno stabilimento con sorgenti termali d’acqua calda situato lungo il fiume.
Dietro alla reception, ritagliata da un finestrone, appariva una piscina poco più grande di una vasca da bagno e di un verdastro squallore, evidentemente ricavata in quello spazio minimo perché ritenuta dai clienti un elemento irrinunciabile dell’arredo di un albergo, fosse pure nella forma degradata di un acquario più adatto all’habitat di un rettile che al relax di un umano. E questo nonostante appartenesse a una donna il corpo arrossato e intontito dal vapore che dormicchiava sulla sdraio avvolto da un telo bianco.
Il tempo di portare su le valigie e di prendere possesso delle camere, e io e il mio amico scendemmo per vedere se in città trovavamo ancora aperto un posto decente che ci desse da mangiare.
Fu uscendo dal parcheggio che li vedemmo. Inquadrati dai fari delle auto, sotto un alberello che sbucava dal cemento, i due grossi cervi rimasero per un attimo immobili prima di scattare all’unisono in direzioni opposte. Tutt’intorno, solo costruzioni e asfalto.
Da dove venivano? Perché erano là?
Non si spiegava che cosa cercassero i cervi nel parcheggio di un centro commerciale.
«L’America è questa» dicevo «tu sei in un mall, ma sei anche in mezzo a un nulla di cieli e praterie e fuori dal supermercato arriva un cervo, il parco lo attraversa un leone di montagna, in giardino trovi un serpente a sonagli… non c’è civiltà che tenga, l’America selvaggia non la puoi confinare…».
«Può darsi» disse il mio amico «ma secondo me sono venuti perché speravano di trovare qualcosa nell’immondizia».
No, non bisogna interrogarsi troppo su coloro che cerca no presenze incoerenti in luoghi inverosimili, esseri umani o animali che siano. Passano nella tua vita belve e showgirl tra le quali puoi scoprire affinità impossibili e nelle quali andrai a cercare la tua idea di bellezza, di forza, di desiderio.
È nell’incertezza e nell’impermanenza di queste qualità che avrei scoperto come niente dura. Ed è nella stranezza incondivisibile delle associazioni suggeritegli dalla fantasia che ognuno misura la propria solitudine.
(continua in libreria…)
Fotografia header: Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti (foto di Francesco Giusti)



