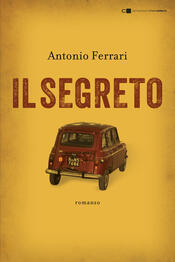Antonio Ferrari, a lungo inviato del “Corriere della Sera”, lo scrisse nel 1981, ma qualcuno ne impedì la pubblicazione perché, spiega, “metteva in discussione quello che si doveva credere”. Ora esce per Chiarelettere. Ed è destinato a far discutere. L’intervista a tutto campo al grande giornalista, che ai giovani aspiranti tali consiglia di “crederci. Questo resta il mestiere più bello del mondo. Se cerchi soldi, meglio lasciar perdere. Se cerchi le emozioni, allora devi insistere…”
Questa è la storia di un libro che doveva uscire trentacinque anni fa, ma qualcuno lo impedì. È la storia, ancora senza finale, del mistero dei misteri d’Italia: il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. È la storia di un romanzo-inchiesta, Il Segreto, scritto da un cronista di razza, Antonio Ferrari, per trent’anni inviato speciale del Corriere della Sera, che ama sentire l’odore delle cose, vedere di persona e sa coniugare quello che ha visto con il ragionamento e l’analisi.
Negli anni Settanta e Ottanta Ferrari si è occupato di terrorismo rosso e nero, dello scandalo della P2, che travolse anche il Corriere, e per due anni ha avuto pure la scorta. Poi, dal 1982, da inviato in Medio Oriente, ha intervistato i principali leader dell’area: Arafat, Sharon, il presidente libico Gheddafi, l’ex re di Giordania Hussein e l’attuale Abdullah, il presidente siriano Bashar el Assad e l’egiziano Mubarak. Fino alla principessa Rania di Giordania di cui è amico personale. Ha raccontato la guerra in Libano, che l’ha particolarmente segnato, tanto da conservare un cimelio che, rivela, “porto sempre sul cuore”.
L’intervista si svolge al Rigolo, il ristorante a due passi da via Solferino, storico ritrovo dei giornalisti del Corriere come ricorda Ferrari con aria compiaciuta. È un attimo. Poi l’espressione del volto si fa di nuovo seria ed emerge l’istinto dell’intervistatore: “Ha letto la postfazione? Non le sono venuti i brividi?”. Il Segreto, pubblicato da Chiarelettere, si legge tutto d’un fiato, ha il ritmo incalzante di un thriller ma vale un’inchiesta.
Non rischia di alimentare la dietrologia sul caso Moro?
“Io non sono un fanatico della dietrologia, ma non mi sono mai accontentato delle veline e delle dichiarazioni ufficiali. Sono abituato, grazie al più grande direttore che ho avuto, Piero Ottone, ad andare e cercare di scavare anche l’impossibile pur di tentare di scrostare le bugie attorno alla verità. Non sono un ingenuo, so che arrivare alla verità pura è una chimera. Eliminare le bugie, però, è un primo passo verso la verità”.
Nel romanzo, Aldo Moro viene liberato dai brigatisti e ucciso subito dopo. È questa la verità?
“Io continuo a pensare che il presidente della Democrazia Cristiana sia stato liberato e ucciso successivamente. Due mesi, dal rapimento al ritrovamento del cadavere, sono tanti. La maggioranza delle Brigate rosse voleva liberare Moro, una minoranza, inquinata dalla scuola francese Hyperion (Kyrie nel libro, ndr) no. Sono convinto di questo e alcuni magistrati me l’hanno confermato”.
Perché Moro doveva morire?
“Il leader democristiano, insieme ad Enrico Berlinguer, stava lottando per far uscire l’Italia da un’impasse politica e istituzionale. Due uomini diversi, un cattolico e un comunista, entrambi concentrati sul progetto di rompere il ‘fattore K’ e tirare dentro nella maggioranza di governo anche il Partito comunista italiano. Un progetto che faceva paura a molti”.
A chi?
“In America c’era il presidente Jimmy Carter e in Russia Leonid Breznev. L’accordo tra Moro e Berlinguer metteva in crisi gli uni e gli altri: gli americani perché vedevano un partito comunista entrare nell’area di governo e i russi perché un partito comunista si permetteva di entrare in una maggioranza di governo sia pure con la formula dell’astensione. In tutti i Paesi ci sono sempre poteri paralleli agli Stati che si muovono e tramano nell’ombra. Nel caso Moro ci fu una convergenza tra questi poteri”
A muovere i fili di questa trama, nel romanzo, è il dottor Alfred Greninger.
“Un personaggio di fantasia. Nella realtà, esponente di un’organizzazione nazionalista e intransigente americana che aveva l’equivalente in Russia. Anche l’Italia giocò una partita poco limpida. La mia impressione è che non sia stato fatto tutto il possibile per liberare Moro. Cossiga (all’epoca ministro dell’Interno, ndr) giocò un ruolo ambiguo”.
Poi c’è Ron J. Stewart, un agente segreto americano facilmente identificabile…
“È Ronald Stark, un americano infiltrato che entrò in contatto con i vertici delle Brigate Rosse. Poi si scoprì che morì in circostanze poco chiare nelle Antille. Fu una cosa tacitata dai giornali e ancora oggi mi chiedo perché”.
Chi voleva che il suo libro non fosse pubblicato?
“Molti, perché metteva in discussione quello che si doveva credere, cioè che le Br erano pure e rosse, che non c’erano possibilità d’infiltrazioni e che tutto il resto era dietrologia spicciola di serie B. Quello che ho raccontato nella postfazione è tutto vero. Il Corriere, tramite il manager Salvatore Di Paola, sopravvissuto allo scandalo P2, voleva che scrivessi un saggio. Proposi di raccontare in chiave romanzata quello che non ho mai potuto provare. Credevo che fosse il momento di denunciare tutto. Mi sbagliavo. Forse ero presuntuoso. Però i giochi di potere erano molto forti e quegli erano difficili. Ricevevo continuamente minacce, più o meno velate. Il libro nacque così. Dopo averlo scritto, cominciò un calvario di rimpalli, rinvii, ‘vediamo, stiamo valutando’. Alla fine capii che la Rizzoli non l’avrebbe mai pubblicato”.
Se fosse uscito prima sarebbe stato un riacquisto di credibilità per il Corriere che usciva con le ossa rotte dallo scandalo della loggia P2?
“Ci ho pensato più volte. Mi sono risposto di sì, però forse è la mia presunzione. Certo, ho avuto coraggio a dire, da dentro, che alcune cose le avevo capite e non ero uno sciocco. Proprio in questo ristorante ebbi un incontro con una grande regista tedesca, Margarethe von Trotta, la quale mi chiese se il giornale mi avesse mai condizionato. Le dissi di no. Lei voleva fare un film e propose di far interpretare il mio ruolo da Gian Maria Volontè. La ringraziai ma le dissi di non poter accusare nessuno, neanche il direttore Franco Di Bella che non mi ha mai censurato un pezzo quando scrivevo della P2 nonostante lui stesso fosse tra gli iscritti”.
La verità sul caso Moro oggi fa meno paura?
“Forse sì perché la mia è una verità romanzata ma che si raccorda con le ultime scoperte della seconda Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro voluta da Renzi che su questo, va detto, ha avuto un grande coraggio nel voler tirar fuori le porcherie di regime”.
Nella sua carriera ha seguito il terrorismo, ha vissuto sotto scorta per alcuni anni, poi è andato in Medio Oriente a raccontare la guerra. Che differenza c’è?
“Enorme. Io non ho mai avuto paura in Medio Oriente ma l’ho avuta, e tanta, in Italia. Il terrorismo era cieco, poteva colpirti senza darti alcun segnale. La guerra è palese, tu sai che ogni giorno corri il pericolo di morire. Sul cuore porto sempre questo (lo estrae dalla tasca del gilet, ndr): è un frammento del Corano dove si riconosce la verginità di Maria. Me lo regalò il mio autista Sami. Un giorno a Beirut a metà degli anni Ottanta mi ha salvato da un sequestro perché avevo visto e fotografato cose che non avrei dovuto vedere e fotografare. C’era appena stata una strage di palestinesi uccisi dagli sciiti a Shatila. La religione non è violenza, porta sempre un messaggio di pace, lo dico da laico”.
Lei crede?
“Non lo so. Il cuore dice sì, la ragione dice no. Sento però che c’è qualcosa che mi guida e mi aiuta. Che sia il caso, lo Spirito, Dio, non lo so. Aver vissuto a lungo a Gerusalemme mi ha molto colpito e cambiato. Nel 1999, alla vigilia del Giubileo, feci un reportage sulle orme di Gesù Cristo”.
Che giudizio ne ha tratto?
“Non so se è il figlio di Dio. Era un profugo, veniva da Nazareth, considerata dai dottori della Legge di Gerusalemme la feccia come i luoghi d’origine dei profughi di oggi. Gesù era un rivoluzionario e anche un gran rompiballe: caccia i mercanti dal Tempio, predica contro i dottori della Legge. Un po’ come papa Francesco oggi, mi arrabbio molto quando lo attaccano”.
L’ha conosciuto?
“L’anno scorso ad Assisi. Il mio sogno è passare una giornata con lui e poi raccontarla in un libro”.
Che consigli vorrebbe dare ai giovani che si affacciano a questa professione?
“Crederci. Questo resta il mestiere più bello del mondo. Se cerchi soldi, meglio lasciar perdere. Se cerchi le emozioni, allora devi insistere. Noi siamo collezionisti di emozioni, questa è la nostra forza. Quando non riesco a dormire la sera penso a tutto quello che mi ha regalato questo mestiere: ho incontrato le persone più incredibili, ho vissuto le situazioni più strane, ho visto gente piangere e ridere, ho conosciuto leader e gente comune, poveri e ricchi, re e regine. Però ciascuno mi ha lasciato qualcosa, nel bene e nel male. Questo lo ritengo un dono che mi è stato fatto. Sono molto grato. Quest’anno ho guardato Sanremo e mi sono innamorato della canzone di Fiorella Mannoia. Sì, davvero la vita è perfetta. Le sono grato, anche se alla fine, tra gioie e sofferenze, il conto è pari. Ho avuto un’infanzia disperata, ho vissuto la tragedia di restare orfano di padre a 9 anni. Poi mi sono rialzato e sono andato avanti”.
Il suo prossimo libro?
“Un romanzo su Auschwitz e sulla controversa figura del prete slovacco Josef Tiso, che voleva vendere gli ebrei ai nazisti e fu fermato da Pio XII”.