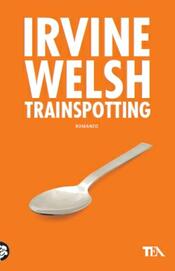“Per scoprire che cos’è e come si scrive un romanzo, non c’è niente di meglio che interrogare uno scrittore”. Enrico Franceschini ha mantenuto fede al suo proposito e ha interrogato numerosi grandi autori, nel libro “Vivere per scrivere. 40 scrittori si raccontano”. Su ilLibraio.it l’incontro con Ian McEwan, in cui l’autore inglese ha parlato di temi come la Brexit, l’estremismo e la letteratura russa
“Per scoprire che cos’è e come si scrive un romanzo, non c’è niente di meglio che interrogare uno scrittore”. Enrico Franceschini, corrispondente da Londra per La Repubblica, traduttore di alcuni libri di Bukowski e autore per Feltrinelli, Bompiani, Sperling & Kupfer, ha mantenuto fede al suo proposito e ha intervistato qualche scrittore sull’arte del romanzo, nel libro Vivere per scrivere (Laterza).
Beh, non proprio qualche, diciamo quaranta: Charles Bukowski, Nick Hornby, Martin Amis, Ian McEwan, Frederick Forsyth, Zadie Smith, James G. Ballard, J.K. Rowling, Hilary Mantel, Michel Faber, Sophie Kinsella, William Boyd, Hanif Kureishi, Alan Bennett, Peter James, Paula Hawkins, Jonathan Coe, Irvine Welsh, John Banville, Roddy Doyle, Catherine Dunne, Bret Easton Ellis, J.J. Abrams, Nathan Englander, Amos Oz, David Grossman, Abraham B. Yehoshua, Aleksandr Solgenitsyn, Evgenij Evtushenko – tanto per fare qualche nome.
Quaranta narratori, dunque, parlano dei libri che scrivono, di quelli che amano, nel proprio metodo narrativo. Di come nasce una storia, di dove arrivano le idee, dei propri maestri. Ognuno, poi, usa mezzi differenti: “C’è chi scrive ancora a mano e chi è stregato dal computer, chi programma ogni pagina dall’inizio alla fine e chi avanza di getto senza sapere dove lo porterà la trama, chi frequenta i corsi di scrittura creativa e chi esce dalla scuola della vita, chi si fa ispirare dalla realtà e chi la deforma, chi lavora esclusivamente di fantasia e chi studia, imita o perlomeno usa come modello i grandi autori del passato”.
Un bel modo per conoscere meglio alcuni dei migliori scrittori, e magari una palestra per gli autori in erba.

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo l’intervista a Ian McEwan:
«Qualche volta, alla presentazione di un mio libro, temo che si faccia avanti uno sconosciuto e mi spari», confessa Ian McEwan. È un incubo che nasce in parte dalle coraggiose e controverse posizioni pubbliche assunte da uno scrittore che è fra gli intellettuali più ascoltati d’Inghilterra: i suoi attacchi al fondamentalismo islamico – «creatore di una società che aborrisco» –, all’estremismo religioso in senso più ampio – «non mi piacciono le visioni medievali in cui Dio salva i suoi seguaci e condanna gli altri» – o alla Brexit – «dobbiamo aspettare che muoiano un milione e mezzo di anziani, poi torneremo a votare e vinceranno i sì all’Europa». Ma l’autore di romanzi best seller tradotti in decine di lingue come Espiazione, Sabato, Amsterdam, vincitore del Booker Prize in Gran Bretagna e di premi altrettanto prestigiosi all’estero, suscita polemiche anche con i suoi libri. L’ultimo, Nel guscio, è raccontato da un punto di vista insolito, improbabile, decisamente surreale: quello di un feto dentro la pancia della madre, un bambino non ancora nato, ma che già ascolta e comprende tutto come farebbe un adulto.
Non pensa che, in un mondo che negli ultimi mesi ha visto la Brexit, Trump, il terrorismo, ora anche un terribile incendio in un grattacielo di povera gente a Londra, quel feto potrebbe avere la tentazione di non uscire dal ventre materno?
«Senta, la vita deve andare avanti. Quindi contiamo che continuino a nascere bambini, in modo che il progetto umano possa proseguire, giusto? Tuttavia ha dannatamente ragione, sono tempi difficili questi. Il mio paese è in uno stato di confusione e di depressione. Ciò che riempie le nostre menti, e ancora non ci siamo ripresi, è naturalmente il grande incendio della torre di Notting Hill, che riporta alla mente orrendi ricordi dell’11 settembre 2001, però con una differenza. Naturalmente questo è stato un incendio e non un attentato terroristico, però l’11 settembre le Torri Gemelle erano luoghi di lavoro e dentro c’erano soprattutto adulti. Invece il grattacielo di Londra era pieno di famiglie, di bambini con i loro genitori. Sono state scene che mi hanno straziato il cuore, ma che hanno suscitato anche importantissimi interrogativi riguardanti il divario della nostra società: come trattiamo chi non ha nulla? Come si è allargato il divario tra ricchi e poveri? E quindi eccoci in preda a degli esami di coscienza molto approfonditi, indipendentemente dalla Brexit».
Ecco, la Brexit: che cosa ne pensa? È una cosa che ha scioccato gli inglesi, ma anche noi italiani, noi europei continentali, che pensavamo: gli inglesi sono il popolo che ci ha salvati dal nazismo, il popolo che ha liberato l’Europa, sono parte della nostra storia, ci dispiace perdervi.
«Beh, se vi abbiamo salvato dai nazisti, adesso tocca a voi salvare noi dalla Brexit. Siamo in una situazione di confusione incredibile. Ci sono fazioni opposte in parlamento. C’è chi vuole una Brexit molto dura: uscire dall’unione politica ma anche dal mercato comune e dall’unione doganale; altri preferiscono una Brexit più morbida. Altri ancora, ringalluzziti dal risultato delle recenti elezioni britanniche e dall’ascesa del laburista Jeremy Corbyn, vorrebbero restare nell’Unione in tutto e per tutto. Ma nessuna di queste fazioni ha la maggioranza in parlamento. Quindi siamo di fronte a un futuro di grandissima incertezza. Non sappiamo quanto a lungo potrà sopravvivere la premier Theresa May. Nessuno può fare previsioni, ma a mio modo di vedere la Brexit è stata un errore mostruoso, non avremmo mai dovuto indire un referendum, è stato indetto soltanto per una resa dei conti all’interno del partito conservatore. Molti che hanno votato per uscire dalla UE non hanno capito quale fosse davvero la posta in gioco. Io spero che Italia, Francia e Germania, come ha già detto il presidente francese Macron, ci invitino a rimanere. Che ci diciate: ripensateci, guardate che le porte sono ancora aperte, vi faremo un paio di concessioni extra ma voi, please, tornate indietro. Altrimenti, se ciò non accadrà, vedo la Brexit come una forma di idiozia collettiva. Forse il più grande errore di politica estera del Regno Unito dalla guerra in Iraq e come politica interna credo che non abbiamo mai fatto un errore del genere. E vorrei aggiungere che secondo me l’Unione Europea, con tutti i suoi difetti, sia uno dei progetti più nobili nella storia dell’umanità. Paesi che un tempo si facevano la guerra si uniscono: non ha precedenti. Mi addolora enormemente che abbiamo preso questa decisione».
Si sente uno scrittore inglese o europeo o entrambe le cose?
«Come tutti penso che la mia identità sia fatta di cerchi concentrici: la mia famiglia, la mia città, Londra, l’Inghilterra, la Gran Bretagna, l’Europa, il mondo. Il cambiamento climatico ci lega tutti, siamo parte dello stesso pianeta, è sempre utile ricordarcelo. Non molto tempo fa, in macchina con un amico in Slovenia, abbiamo preso la svolta sbagliata e a un certo punto siamo finiti in Austria: e io ho sentito un senso di euforia. Siamo finiti in un altro paese senza nemmeno rendercene conto! E ho provato orgoglio per il fatto che nei paesi del gruppo di Schengen non ci sono frontiere. Io mi sento profondamente europeo. Mi piace arrivare in un aeroporto ed entrare dalla parte che dice: cittadini dell’Unione Europea».
Lasciamo la politica e occupiamoci di letteratura.
«Ne sono sollevato».
Da dove le è venuta l’idea di scrivere un romanzo dal punto di vista di un feto?
«Un giorno ero seduto con mia nuora, che era incinta di otto mesi, e parlavamo del bambino che doveva arrivare, come se lui ancora non ci fosse. Più tardi, quella notte, scrivendo sul quaderno su cui prendo i miei appunti, mi sono detto: ma quell’essere ha già tutte le qualità di un bambino, eppure è ancora dentro la sua mamma. Parlavamo della sua identità – ‘che bambino sarà questo qui?’ –, non sapevamo nemmeno se sarebbe stato un maschietto o una femminuccia, e così ho pensato: forse qui c’è un’ideuzza per me. Il giorno dopo, a una riunione noiosissima, di colpo una frase mi ha attraversato la mente, come un dono. La frase era questa: eccomi qui, a testa in giù, dentro una donna. E ho capito che era l’incipit, la prima riga di un nuovo romanzo. Chi era la madre, quali erano le circostanze, non ne avevo la minima idea, però ho sentito di avere la premessa di una storia da narrare. Al tempo stesso stavo preparando una lezione su Amleto e mi sono detto che quel bambino avrebbe potuto anche essere Amleto sul punto di rinascere, o Shakespeare sul punto di rinascere. E quindi i primi tentativi di scrivere questo romanzo sono stati di cercare di rendere il linguaggio del feto/bambino un po’ anacronistico, con qualcosa di poetico, il ritmo dei versi di Shakespeare. Scrivere un romanzo secondo me è sempre un atto di scoperta. Ti viene una specie di idea, e da quella te ne viene un’altra, e sono finito con un libro che non potevo assolutamente prevedere».
Si è preparato scientificamente su cosa è un feto, quando nasce l’intelligenza, e così via, oppure no?
«Assolutamente no. Di solito mi piace studiare e documentarmi, scrivere romanzi è come farsi un’istruzione permanente, ma per una volta mi sono preso una vacanza, non c’era nulla da studiare perché la mia storia non era radicata nella realtà. Ero tornato nel mondo surreale dei miei primi racconti brevi e mi sono perfino sentito un po’ più giovane. Magari non un feto, ma un ventiduenne, che so. Quanto a esperienza sull’argomento, a parte che io stesso sono stato un feto, è stato quando ho aiutato mia moglie a partorire il nostro secondo figlio, che si è presentato sulla scena molto rapidamente, in un momento in cui non c’erano levatrici nelle vicinanze, e credo che quello sia stato uno degli eventi più straordinari della mia vita. L’ho preso, l’ho sollevato, l’ho messo sulla pancia della sua mamma, e mi sono reso conto, cosa che poi è rimasta in me durante la stesura del romanzo, di che miracolo al tempo stesso straordinario e ordinario accade quando una persona viene fuori da un’altra persona, come nelle matrioske, le bamboline russe infilate una dentro l’altra. In quell’attimo non ci sono religioni, fedi, convinzioni, c’è una pura identità. Il feto è come una voce senza bagaglio che esce dalle tenebre. Tutto il resto gli arriverà addosso dopo, mentre al momento della nascita c’è una purezza assoluta, come un libro bianco».
Che tipo è il feto del suo romanzo?
«Uno molto informato e curioso, che sa più o meno tutto quello che so io, che si interroga sul significato dell’esistenza e che, a dispetto dei molti problemi che abbiamo citato prima, preferisce nascere che non nascere. La sua conclusione è che la vita è la ricerca di un senso, e se lo cerchiamo, il senso della vita, meritiamo quella coscienza di cui ci ha dotati l’evoluzione della nostra specie».
I libri, i romanzi, ci salvano la vita, ci aiutano a vivere?
«È difficile avere le prove che sia così. Ma esistono dati scientifici secondo cui coloro che leggono romanzi sono molto più sensibili alle emozioni altrui rispetto alle persone che non lo fanno. Il problema è che questo ragionamento si può rovesciare: chi legge romanzi è sensibile o chi è sensibile legge romanzi, come la questione dell’uovo e della gallina? Scrivere e leggere romanzi, per me, fa parte della nostra ricerca su cosa significhi essere umani. Perché nel romanzo c’è tutto ciò che significa vivere associati ad altri. Eppure Hitler adorava Wagner e le guardie dei lager ascoltavano Schubert, quando la Germania è scesa alla suprema barbarie della civiltà umana, pur essendo la società forse più colta e raffinata della terra. Quindi può esserci qualche dubbio sulla capacità dell’arte di renderci sensibili. Un poeta ha detto che la poesia non fa succedere proprio niente. Io credo invece che la poesia faccia succedere qualcosa. Ma occorre più di un romanzo per riscattarci».
Quali sono i romanzi e gli autori che ama di più?
«All’inizio c’era un manipolo di scrittori che per così dire mi hanno svegliato. Come se mi avessero infilato un dito fra le costole e mi avessero detto: su, hai vent’anni, è ora che cominci a pensare. Uno di questi era Franz Kafka. Un altro è stato Italo Calvino. Un altro Thomas Mann. Un altro ancora è stato uno scrittore inglese che non credo sia molto letto in Italia, William Golding. Sono tutti autori che contrastavano l’idea del realismo che distingueva all’epoca il romanzo britannico. Per esempio quando ho letto La metamorfosi di Kafka, che comincia come tutti sanno con ‘Gregor Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, in un enorme insetto’, mi è piaciuta da morire l’audacia di questa prima frase e di come prosegue, con Gregor Samsa scarafaggio, con tutte le otto zampine, che pensa: oddio sono in ritardo per andare al lavoro. Distruzione di tutto ciò che è reale o realistico, gioco di prestigio e ritorno completo nel mondo della realtà. Questo è stato ciò che mi ha risvegliato. La stessa cosa ho ritrovato poi nelle opere di Calvino, come Le cosmicomiche o Il barone rampante. Che giocosità quando Palomar sta nel suo giardino e mentre la moglie gli parla lui pensa: ‘È un pezzo che siamo sposati, è come il canto degli uccelli, non occorre neanche che io ascolti’, e diventa, quel parlare, il canto degli uccelli».
Misto di surreale e reale, diceva a proposito di Kafka: come in questo suo ultimo romanzo, Nel guscio?
«Esattamente. Sono partito da una surreale metamorfosi, l’idea di un feto che ragiona come un adulto, sperando poi, con un mio gioco di prestigio, di poterlo portare in una situazione reale. È il campo dei miei primi racconti, come ho ricordato prima, ma poi, negli ultimi vent’anni, mi sono sentito attirato dall’esigenza di raccontare il reale, una sorta di lealtà verso un certo tipo di verità, non la mia verità, bensì la verità condivisa. Ho pensato che raccontare una vita, nel nostro tempo, nel nostro mondo, in uno stato di modernità, per citare Saul Bellow, mi è sembrato che fosse il mio dovere».
E che cosa c’era dietro questo senso del dovere?
«Interesse per la scienza, la musica, la storia, la politica. Ho cominciato a pensare che il mondo reale, fatto di queste cose, fosse più straordinario di qualsiasi cosa io potessi inventare. Nel 1963 Philip Roth disse che il romanziere non aveva più bisogno di inventare niente, perché la realtà prevaricava la fantasia. E vale anche oggi: può un romanziere competere con le invenzioni di Trump?».
Ha parlato di Kafka, Calvino, Mann, Golding. Posso chiederle che cosa pensa di qualche altro romanziere?
«Purché non siano amici miei».
Non credo, sono tutti morti.
«Allora va bene».
Robert Louis Stevenson?
«A casa parliamo della Scozia, mia moglie è per l’indipendenza, io no, il matrimonio è sopravvissuto. In Gran Bretagna non ci sono scrittori ‘britannici’: ci sono scrittori inglesi, gallesi, scozzesi. Eppure quando chiedo a mia moglie di nominarmi uno scrittore britannico, invariabilmente risponde: Stevenson. Che era scozzese. In fondo ha ragione lei: lui scrive in rappresentanza della Gran Bretagna, non della sola Scozia. È uno scrittore che dobbiamo tutti invidiare perché ha ideato situazioni immaginarie che sono entrate nella cultura condivisa. Tutti parlano dell’Isola del tesoro anche senza averlo letto. Quando un romanziere si è insinuato nella nostra vita al punto che ci pare di conoscere le sue opere anche se non le abbiamo lette, siamo di fronte a un caso di grandezza storica».
Dickens?
«Lui pure ha riorganizzato l’arredo della nostra mente, anche per chi non ha letto nulla di suo. E ha fatto ancora di più: ha inventato il Natale, perlomeno per noi inglesi. Natale non c’era da noi, non in quella forma, finché Dickens non ne ha scritto. I miei preferiti, tra i suoi libri, sono Il nostro comune amico, Tempi difficili. Ecco, se avessi una riserva nei confronti di Dickens, sarebbe che l’elemento farsesco è un po’ sovraccarico, indigesto. Mi strema con la sua energia verbale. Ogni tanto vorrei dirgli: calmati, rilassati, bevi un bicchier d’acqua anziché fare i fuochi d’artificio di continuo».
Tolstoj o Dostoevskij? Qual è il suo preferito?
«Devo per forza scegliere?».
Sono diversi.
«Sì, sono diversi. Anche il formaggio e la carta sono diversi e a me piacciono tutti e due, che devo fare? Quello che mi ha colpito per primo è stato Dostoevskij. Memorie dal sottosuolo è formidabile. Ma se mi metti una pistola alla tempia e mi chiedi qual è il mio romanzo preferito in assoluto, rispondo: Anna Karenina. La vita non è perfetta e nemmeno Anna Karenina lo è, ma è un libro così spazioso che ci entra tutto. E se mi chiedi qual è il secondo, dico Madame Bovary. Ma torniamo ad Anna Karenina. Ai romanzieri piace l’infelicità, pensano che la felicità sia una gran noia dal punto di vista letterario. E Tolstoj invece riesce a darci la felicità di una giovane coppia nei primi mesi di matrimonio per quasi centocinquanta pagine! È un pezzo di una bravura straordinaria. E che cosa mette fine a questa felicità? Un vecchio amico di lui va a stare da loro, il marito comincia ad essere geloso, teme che fra la moglie e l’amico nasca qualcosa, e scoppia la prima, grande lite. I preparativi delle nozze, il ricevimento in campagna, l’arrivo dell’amico. È una delle cose più perfette che ho mai letto».
È così bello ascoltarla parlare di letteratura che vorrei chiedere il suo parere su tutti gli scrittori del mondo. Ma siccome non c’è tempo, mi limito a due. Hemingway?
«Adoro i suoi racconti. Tutti sanno che per i giovani scrittori Hemingway è un modello disastroso perché pensi che tutte quelle frasi congiunte da una serie di ‘e’ siano facili da scrivere, e invece sono di una difficoltà pazzesca. Lui fa una cosa che fanno tutti i grandi scrittori: non è importante solo la frase, contano anche i buchi, gli spazi vuoti fra una frase e l’altra, quelli sono come la scatola del cambio di un’automobile. C’è per esempio un racconto di poche pagine, Gatto sotto la pioggia, che per me è uno dei più bei racconti mai scritti. Ti ruba il cuore. Una coppia di sposi. La donna si annoia. Guarda fuori dalla finestra. Vede un micetto, che si ripara sotto un tavolino, e la donna convince un cameriere ad andare a salvare il gattino. E la storia finisce con il cameriere che bussa alla porta, con il gattino fra le braccia, ma già si capisce che non è lo stesso gatto. Probabilmente il racconto tratta del desiderio di un figlio, o di qualcosa di irrisolto fra i due sposi. Ma lo scrittore non lo dice, ci lascia in sospeso. Questo è Hemingway al suo meglio. Con quelle semplicissime frasi legate fra loro dalla congiunzione ‘e’ lui riesce a fare questo miracolo».
Infine, invece del nome di uno scrittore, le dico il nome di un libro: l’Ulisse.
«Beh, è come la vita. Ha pagine di bellezza sublime, e altre di una noia abissale. Tutta la parte sulla grammatica, per esempio. Io adoro l’Ulisse, però penso che la cosa migliore che Joyce abbia mai scritto sia un racconto lungo, o romanzo breve, pubblicato in una raccolta di racconti e per questo motivo non ha mai avuto un’esistenza indipendente. Parlo di I morti…».
Che è diventato anche un film di John Huston.
«Sì, l’ultimo film diretto da Huston, una bellissima trasposizione cinematografica, molto fedele al testo. Infatti se mi chiedi quale sia la mia trasposizione cinematografica preferita di un lavoro letterario direi proprio The Dead di John Huston. Il racconto di Joyce contiene, nelle ultime cinquanta pagine, a mio modo di vedere, forse la prosa più sublime mai scritta. Gabriel e sua moglie tornano da una festa; lì la moglie ha sentito una canzone che le fa tornare in mente un ragazzino di cui era innamorata quando era giovane, cinquant’anni prima. Quel ragazzo ormai è morto, era già malato di tubercolosi quando le cantò quella canzone, una specie di serenata. Lei dice: ‘Credo che sia morto per amor mio’. Gabriel deve cercare di tenere a bada la sua gelosia. La donna si addormenta, lui guarda il suo volto e pensa: ‘non è più il volto della donna che ho sposato tanto tempo fa e presto sarà anche morta’. E comincia a pensare ai morti, sente un rumore alla finestra, del tutto improbabile perché secondo Joyce sarebbe provocato da un fiocco di neve. Lui guarda la neve, che cade a terra lentamente e si scioglie. Questa immagine rappresenta tutti noi, che cadiamo, uno dopo l’altro, come fiocchi di neve, perché moriamo».
Che poetica, straordinaria lezione di letteratura. Ma lei come scrive, in che modo nasce un suo libro?
«Eh, questo è un segreto. È difficile dirlo, perché non succede sempre nello stesso modo. Ho già detto come è nato nella mia mente Nel guscio, ma è stato molto diverso dalla genesi del libro precedente, La ballata di Adam Henry: una donna giudice mi ha raccontato una storia. Era talmente gravida di senso che ancora prima che lei avesse terminato di raccontare avevo capito che mi aveva regalato il mio nuovo romanzo. A volte si tratta di una passione, qualcosa nella scienza, o nella storia, o qualcosa che riguarda la musica. Chesil Beach è nato perché mi sono chiesto come sarebbero le prime sei ore di un matrimonio se la coppia fosse fatta di due vergini, molto timidi, che però amassero tipi di musica completamente diversi. E quindi la musica diventerebbe la rappresentazione di tutto ciò che uno non comprende dell’altra. A lui piace il rock, lei è una violinista, suona in un quartetto d’archi, non capisce le canzoni che invece lui ama. Altre volte entro in uno stato di stupore utile, proficuo. E mi metto in attesa che capiti qualche cosa. Ecco, questo è il modo più difficile di cominciare un libro, perché ci possono volere settimane. Altre volte ancora l’ingrediente della creatività è proprio la pazienza. E poi c’è un altro elemento, che è l’esitazione. Quando hai una buona idea, esita, esita sempre, perché l’idea che ti sembra buona magari a due mesi di distanza non è più così buona. All’inizio, preso dall’euforia, forse fai uno sprint e parti nella direzione sbagliata. Quindi cerco di fare virtù dell’esitazione e dico con orgoglio che sono bravissimo a non scrivere. Probabilmente sono più bravo a non scrivere che a scrivere».
Però sono curioso di entrare un po’ di più nel suo laboratorio. Come scrive? A penna o col computer?
«Come quasi ogni scrittore, sono molto superstizioso, nonostante la mia passione per la scienza. Tengo in modo particolare ai ferri del mestiere, quindi uso sempre un taccuino formato A4 di colore verde, le pagine devono essere rigate ma senza margini e scrivo soltanto con una penna nera. E lì lascio libertà alla mia mano. A me piacciono moltissimo i computer, però non c’è nulla di così libero come una mano e una penna, è come se il cervello pensasse direttamente sulla pagina, come se il cervello avesse una mano. Un mio amico, un neuroscienziato, ha detto che una cosa magnifica della mente è che ha… una mente. Non puoi controllare tutto ciò che pensi. Ci sono associazioni di pensiero che non puoi prevedere. Quindi il viaggio della mano è come un viaggio a piedi, per me. E delle volte capita che ti torna alla mente qualcosa che hai pensato un sacco di tempo prima, è rimasta nella tua memoria ma non nella tua coscienza. Tante volte ho pensato di avere avuto una buona idea ma sono stato troppo pigro per scriverla. Che cosa posso dire: tutto quello che mi è rimasto è l’idea di avere avuto una buona idea, ma è un guscio vuoto, perché non me la ricordo più. Quindi bisogna sempre scrivere, questo è il mio punto di partenza. All’eroina di Espiazione ho attribuito una riflessione sulla scrittura che è mia: ci sono persone che parlano di telepatia, eppure attraverso delle linee, dei tratti su una pagina, riusciamo effettivamente a trasferire i nostri pensieri nella mente di un’altra persona. È un miracolo, come la nascita dei figli: il miracolo della scrittura. Spremendoti le meningi, puoi trasmettere quello che c’è nella tua mente dentro la mente di un altro: non è straordinario? Anche questa è telepatia. E parte tutto dalle libere associazioni che si creano fra la mano e la penna».
Qualcuno ha detto che il piacere, nello scrivere, sta nella preparazione, non nell’esecuzione: è d’accordo?
«C’è qualcosa di vero in questo. Io ho due fonti di piacere quando scrivo. Una è la sorpresa: ti siedi alle dieci di mattina e due ore dopo hai fra le mani qualcosa che non avresti mai previsto, un personaggio, o anche solo un aggettivo. È la scoperta di qualcosa che non sapevi, fino al momento in cui l’hai scritto. L’altro piacere è molto più difficile e più raro. Scrivi un passo e sei talmente assorbito che cessi di esistere, non hai più identità, scompari. Questo stato può durare dieci minuti, un’ora, ma non per sempre. È qualcosa che si avvicina molto al sesso. Una delle vette del piacere. Un momento in cui dimentichi te stesso, chi sei. Mi capita due o tre volte l’anno: ah, già, chi c’è, sono qui, io? Mi piacerebbe che succedesse tutti i giorni ma è molto difficile».
L’ultima domanda: che consiglio darebbe a chi vuole scrivere un romanzo?
«Di non scrivere un romanzo. Di non cominciare da quello. È una perdita di tempo. Partite da un racconto. Leggete Gatto sotto la pioggia di Hemingway, che vi ho raccontato prima. La cosa migliore di un racconto è che può fare schifo ma ci sprechi qualche giorno o al massimo una settimana. Invece se scrivi un romanzo magari ci metti anni e poi scopri che fa schifo, ed è tempo sprecato. Toglietevi di mente tutte le voci degli altri scrittori che vi impediscono di essere voi stessi. Oppure scrivete delle imitazioni dei vostri scrittori preferiti. Ma usate il racconto per trovare voi stessi. E quando vi siete trovati scrivete un romanzo, ma un romanzo breve, 130 pagine, non una di più. Poi sedetevi. E aspettate».
(Continua in libreria…)