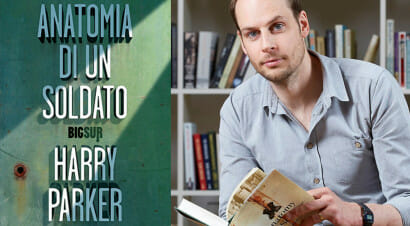Da anni Francesca Borri racconta da vicino alcune tra le aree più difficili del pianeta. Intervista da ilLibraio.it parla del suo ultimo libro, il reportage “Ma quale paradiso? Tra i jihadisti delle Maldive”, e del giornalismo al tempo di internet: “Il problema non è Facebook. Il problema è il giornalista che sta tutto il giorno sui social. Tutto il giorno in redazione. Mi colpisce sempre quando dicono che sono ‘una giornalista sul campo’. E perché, dove dovrei stare?”. L’autrice poi sottolinea: “L’informazione in questi anni non è aumentata, è diminuita: perché il giornalismo esclude moltissimi punti di vista. Nel giro che conta, non c’è un nero. Non c’è un africano. Non c’è un giornalista dell’est dell’Europa. Dominano gli inglesi e gli americani: sia economicamente sia culturalmente…”
Da anni Francesca Borri racconta da vicino, con coraggio, alcune tra le aree più difficili del pianeta. Classe ’80, la giornalista freelance, con alle spalle studi in relazioni internazionali, nel corso della sua carriera ha viaggiato molto, occupandosi di Balcani, Medio Oriente e, in particolare, di Israele e Palestina. Da alcuni anni vive tra Siria e Iraq, e i suoi reportage sono tradotti in tutto il mondo. Il suo nuovo libro, Ma quale paradiso? Tra i jihadisti delle Maldive (Einaudi) è un testo sorprendente. Per parlare del libro, ma anche del presente e futuro della sua professione, l’abbiamo intervistata.
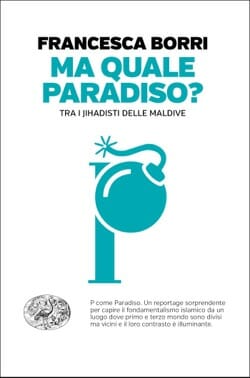
Pochi sanno che, come lei racconta in Ma quale paradiso – Tra i jihadisti delle Maldive, le isole a sud-ovest dell’India, non sono solo un paradiso turistico, ma anche il Paese con il più alto numero pro capite di foreign fighters. È questo che l’ha spinta a iniziare il reportage?
“L’idea, onestamente, più che mia è stata di Francesco Zizola, uno dei nostri migliori fotografi. Aveva vinto l’ennesimo premio, e mentre scrivevo un pezzo sulle sue foto, mi sono imbattuta in un’immagine che pensavo provenisse dall’Africa: e invece ho letto la didascalia, ed erano le Maldive. È iniziata così”.
Per caso.
“Perché poi, sì, le Maldive suonano familiari, ma alla fine quanti di noi sarebbero capaci di individuarle su una mappa? Entrate in libreria: l’unico libro sulle Maldive è la Lonely Planet. Attraverso le Maldive, volevo in realtà raccontare tutto un mondo che crediamo di conoscere, e che invece non conosciamo affatto. E che ora, all’improvviso, ci esplode per strada. In un caffè, a un concerto”.
Come lei scrive all’inizio del libro, in genere i turisti occidentali neppure notano che le Maldive sono un paese musulmano, oltre che molto povero (nella scelta di “arruolarsi”, tra l’altro, l’emarginazione spesso gioca un ruolo superiore a quello della “religione”): quali sono stati i momenti più difficili nel corso del suo viaggio, in un Paese in cui la repressione governativa è molto forte?
“Da veterana di guerra, confesso che non è stato semplice. Non sei sotto bombardamento: ma è come stare a Scampia, in una certa Scampia, è come stare dentro Gomorra. E in più, con la polizia che non è lì per proteggerti, è una banda come le altre. Sei completamente solo. Completamente vulnerabile”.
Si ha paura.
“Sempre. Però il momento più difficile, in realtà, è stato dopo. Dopo che il mio reportage è stato pubblicato. E io ormai ero andata via, ero al sicuro”.
Perché?
“È iniziata la caccia a tutti quelli con cui avevo parlato. Tutti quelli senza cui il mio libro non sarebbe mai stato possibile. Il 23 aprile Yameen Rasheed, uno dei dissidenti più noti, è stato ucciso. Probabilmente sarebbe stato ucciso comunque: ma non posso non pensare che, in parte, abbia pagato un prezzo che avrei dovuto pagare io. Mi sento… Mi sento ingiustamente viva”.

Parliamo di giornalismo. Come giudica il modo in cui i giornali italiani stanno raccontando il fondamentalismo islamico?
“Non è solo un problema dei giornali italiani, e non è solo un problema dei giornalisti – ci decapitano: è un po’ complicato, così, raccontare i jihadisti. Però, premesso questo, direi che siamo soprattutto parziali. Il nostro vero limite, per me, è questo”.
Faccia un esempio.
“Pensate alla battaglia per Mosul. Per noi è stata dall’inizio ‘la liberazione di Mosul’. Ma sono più di vent’anni, ormai, che in Iraq nessuno usa più la parola liberazione, perché chiunque vince, in Iraq, non cambia niente: è sempre un disastro. Non sto con l’Isis, ovviamente. Ma il problema è che raccontiamo in bianco e nero paesi che non hanno eroi. Paesi in cui puoi scegliere solo il male minore – o più spesso, non puoi scegliere affatto. Se vivi in Siria, tutto è meglio dei barili esplosivi, dei gas, anche i jihadisti. Ma se abiti dall’altro lato del fronte, tutto è meglio dei jihadisti: persino Assad. Non c’è più nessuna vittoria possibile”.
Internet e i mezzi digitali hanno cambiato il giornalismo di guerra…
“Internet secondo me non ha cambiato il giornalismo. Cioè, ha cambiato la cronaca. Le notizie: perché chi lavora sulle notizie, ora lavora in tempo reale. Ma per il resto, è tutto ancora come ai tempi di Hemingway. Di Martha Gellhorn. E non solo perché questo è un mestiere che è il contrario della velocità, della programmazione, è un mestiere in cui parti per le Maldive per una foto vista per caso, e forse trovi la storia, forse no – ma perché non avrebbe senso stare in Siria e rischiare otto vite al giorno per raccontarvi che i ribelli sono avanzati dieci metri a sud-est e arretrati dieci metri a nord-ovest. Una guerra è molto più che il fronte, è molto più che i sunniti e gli sciiti, i serbi e i croati. Non credo di avere mai scritto un libro sulla Siria, come in fondo ora non ho scritto un libro sulle Maldive. Ho sempre scritto di noi. Come tutti quelli che hanno scritto prima di me. Perché un reportage è sempre insieme una finestra e uno specchio”.

A questo proposito, (anche) quando si parla di guerre e terrorismo i social sono spesso la prima fonte per i media. È un rischio di cui siamo consapevoli, visto che non sempre le informazioni che circolano su Twitter o Facebook si rivelano attendibili?
“Negli ultimi anni, sì, si è diffusa questa idea del citizen journalist… Ma non ha senso. Chi di noi si affiderebbe mai a un citizen dentist? La definizione è nuova: ma sono testimoni o attivisti, niente di più. Sono quello di sempre. Fonti. Possono fornire delle informazioni, ma il giornalismo è un’altra cosa: è quello che si costruisce a partire dalle informazioni. E però il problema non è Facebook. Il problema è il giornalista che sta tutto il giorno su Facebook. Tutto il giorno in redazione. Mi colpisce sempre quando dicono che sono ‘una giornalista sul campo’. E perché, dove dovrei stare?”.
Sono pochi i (giovani) giornalisti freelance italiani che, alla lunga, possono permettersi di fare questo costoso e delicato lavoro. Lo spazio sui giornali è limitato, i compensi spesso insufficienti: ci sono alternative, o è un mestiere destinato a pochissimi?
“È un mestiere destinato a pochissimi. Come, d’altra parte, molti altri mestieri, ormai. E la conseguenza è che, contrariamente a quello che sembra, l’informazione in questi anni non è aumentata, è diminuita: perché il giornalismo esclude moltissimi punti di vista. Nel giro che conta, non c’è un nero. Non c’è un africano. Non c’è un giornalista dell’est dell’Europa. Dominano gli inglesi e gli americani: sia economicamente sia culturalmente. Ho avuto il privilegio di scrivere per Stanley Greene, uno dei più grandi fotografi di guerra di sempre. Ovunque andassimo, era ogni volta l’unico nero. Ed era grave in sé: ma ancora più grave era che noi altri non notassimo mai di essere tutti bianchi. Tutti uguali”.
Può interessarti anche
Come immagina il suo futuro professionale? Sempre da freelance in contesti difficili?
“In realtà non mi sento una giornalista di guerra. Cioè, in genere, è vero, qualcosa, intorno, esplode, qualcuno muore: però alla fine il mio primo pezzo non è stato su Aleppo, è stato sull’Ilva di Taranto. Perché le guerre non sono solo quelle con i missili e i carrarmati – quelle sono solo le guerre che è più facile vedere”.
Qual è la giornalista o il giornalista, di ieri o di oggi, a cui si ispira nel suo lavoro quotidiano?
“Tutto quello che sono, l’ho imparato da Stanley Greene. Che in mezzo a tanti fotografi che non hanno paura del fronte, e però poi hanno paura di se stessi, era uno invece che non aveva paura di essere fragile. Di esporsi. Di ferirsi”.
Cosa le ha insegnato?
“Delle mille cose che mi ha insegnato, penso prima di tutto al fatto che una storia si segue fino in fondo. E cioè non solo fino al suo ultimo giorno: fino al fondo di se stessi. Perché ogni storia deve essere anche un po’ la tua storia. Devi esserci dentro. Dentro non nel senso di essere di parte, ma di esserne parte: perché se una storia non ti smuove, non ti cambia, se una storia non dice niente a te, come può dire qualcosa a chi legge?”.