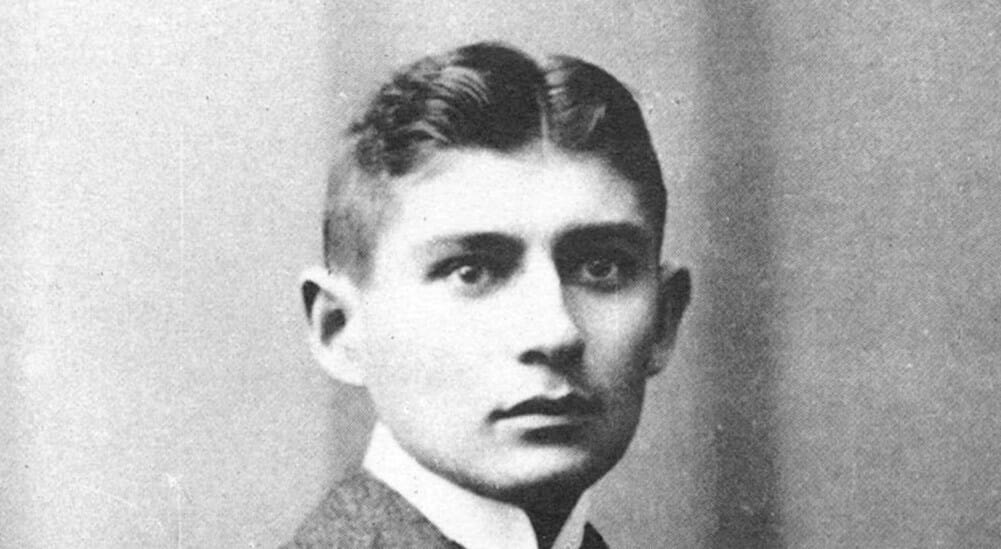Per quanto ancorato alla sua epoca, Franz Kafka testimonia, in modo originale e irripetibile, inquietudini, dubbi e angosce ataviche, che travalicano i decenni. Ma a poco più di cent’anni dalla sua scomparsa, quali opere del grande autore boemo possiamo proporre in classe in una scuola superiore? In questo articolo troverete alcune suggestioni per affrontare tre libri di diversa complessità, che hanno il potere di parlare ancora ai giovani lettori e alle giovani lettrici (come tutti i grandi classici, del resto): “Le metamorfosi”, “Lettera al padre” e “Il processo” – In più, iscrivendovi alla newsletter del progetto “Il Libraio Scuola”, c’è in regalo un ebook a tema…
Tra i grandi autori che colgono la complessità e la mutevolezza del passaggio dall’Ottocento al Novecento c’è senza dubbio Franz Kafka (1883-1924): a poco più di cent’anni dalla sua scomparsa, perché portare le sue opere a scuola?
Ecco tre proposte di opere di Kafka da (ri)leggere e su cui lavorare in classe.
LA METAMORFOSI: UN SENTIMENTO DI EMARGINAZIONE PIÙ CHE REALISTICO
Tra i tre libri che proponiamo in questo articolo, La metamorfosi è forse l’opera di Kafka che si intravede più di frequente sui banchi di scuola. Uscita per la prima volta nel 1915 col titolo originale Die Verwandlung, tratta di una storia sorprendente: Gregor Samsa, un uomo come tanti altri, di professione commesso viaggiatore, una mattina si sveglia e si ritrova trasformato in uno scarafaggio.
Tutti gli studenti restano inizialmente sconvolti (e un po’ disgustati) dalla scoperta e la prima reazione è immancabilmente un moto di ribrezzo. A questa segue una domanda: perché si è trasformato? Non lo sapremo mai, dal momento che subito dopo questa scoperta il narratore si concentra sulle azioni e sui pensieri di Gregor: sì, perché La metamorfosi può essere letta come un esempio efficacissimo di racconto fantastico in cui l’elemento soprannaturale non viene mai giustificato né si risolve nel corso della narrazione.
Questo può essere un primo spunto su cui lavorare con la classe: infatti, durante lo studio dei generi letterari, dopo essersi soffermati sulle categorie del fantastico teorizzate da Tzvetan Todorov (a partire dal celebre saggio La letteratura fantastica) e da Italo Calvino (di cui si consiglia almeno la lettura dell’introduzione ai Racconti fantastici dell’Ottocento), si può decidere insieme ai ragazzi quali definizioni sembrino più appropriate per descrivere La metamorfosi.
Può interessarti anche
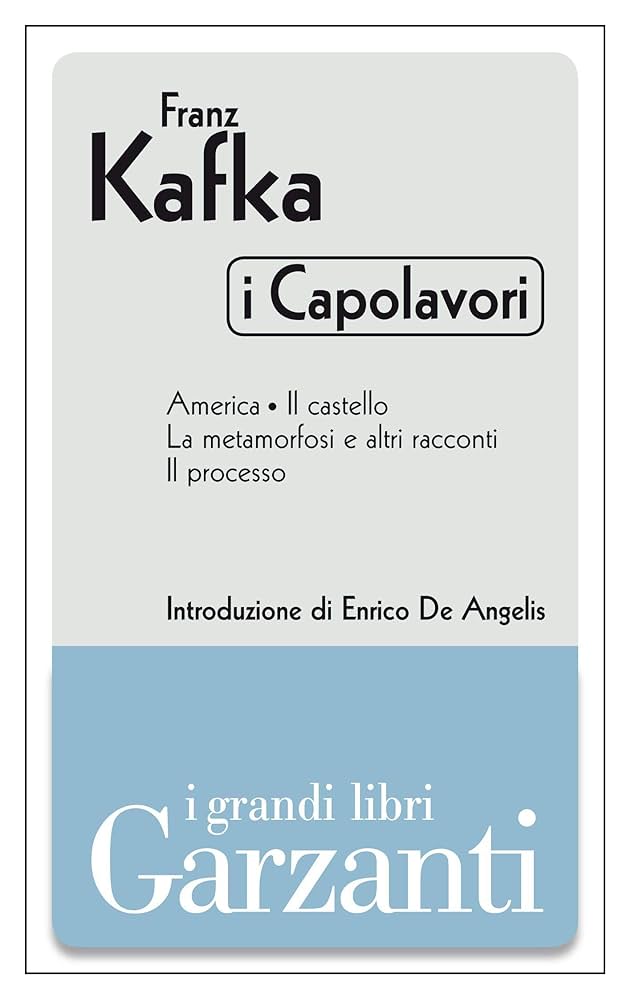
L’EBOOK IN REGALO CON L’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DEL PROGETTO IL LIBRAIO SCUOLA – Lavori nel mondo della scuola superiore e sei sempre alla ricerca di libri da proporre in classe? Scopri il progetto Il Libraio Scuola e scarica Leggere il mondo, la guida gratuita – giunta alla quarta edizione – dedicata alla promozione della lettura tra gli adolescenti. In regalo alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti alla newsletter del progetto l’ebook dei Capolavori di Kafka (Garzanti, introduzione di Enrico De Angelis)
La seconda prospettiva (assolutamente complementare) con cui si può leggere il testo ha molto a che fare con la nuova vita di Gregor Samsa: la mancanza di comunicazione tra il protagonista e i familiari, le difficoltà nel compiere azioni quotidiane, nonché il suo aspetto disgustoso suscitano una profonda frattura tra la sua vita precedente e quella post-trasformazione.
Una progressiva emarginazione all’interno della casa porta Gregor a sentirsi non solo inutile, ma anche indesiderato, nonostante il suo animo sia ancora quello di un uomo. Non riuscire a esprimersi, non avere rapporti autentici con le persone che dovrebbero in teoria rappresentare un punto di riferimento, essere denigrato e isolato sono solo alcuni degli aspetti che spingono solitamente gli studenti a rivedere la propria posizione iniziale.
Gregor, alla fine della lettura, non è più uno scarafaggio ributtante; è solo il “diverso”, che la famiglia esclude senza alcuna ragione.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
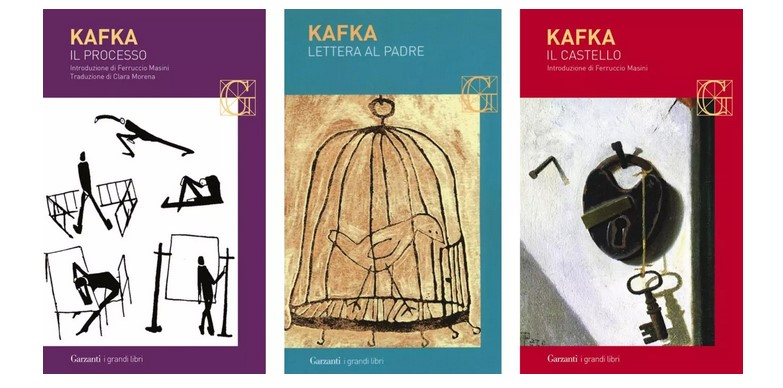
LA CONFESSIONE ACCORATA DI LETTERA AL PADRE
Benché Lettera al padre sia uscita solamente postuma nel 1952 (col titolo Brief an den Vater), sappiamo che è stata composta nel 1919, a pochi anni dalla morte di Franz Kafka, in un momento della vita in cui, ormai adulto, lo scrittore boemo si confronta con una figura che lo ha profondamente influenzato.
Il rapporto col padre viene qui affrontato senza alcuna edulcorazione: cogliamo la frustrazione provocata da una comunicazione più volte difficile, se non impossibile; la durezza del genitore, che non crede nelle potenzialità del figlio, è un enorme motivo di dolore. L’incomprensione è profonda, ed è proprio questo punto a rappresentare un Leitmotiv costante nell’opera. Colpisce la trasparenza con cui Kafka, con razionalità ma non senza trasporto emotivo, enuclea i punti problematici del suo rapporto col genitore. Rievoca inoltre episodi che possono fungere da argomentazioni ed esempi chiarificatori di quanto viene sostenuto.
Dal momento che tra le varie forme di scrittura affrontate a scuola figura anche la lettera, proporre in classe alcuni stralci di Lettera al padre può rappresentare l’occasione per parlare delle missive non spedite ugualmente rivolte a un destinatario reale. Inoltre, se pensiamo ai conflitti che animano i rapporti tra genitori e figli adolescenti, la lettera di Kafka può essere un esempio di come, mantenendo grande rispetto verso l’altro, si possa ugualmente portare avanti le proprie riflessioni.
In più, se si lavora in una scuola in cui si studiano materie psico-pedagogiche, Lettera al padre costituisce una critica accesa ai metodi educativi ancora in voga all’epoca dell’infanzia di Kafka.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
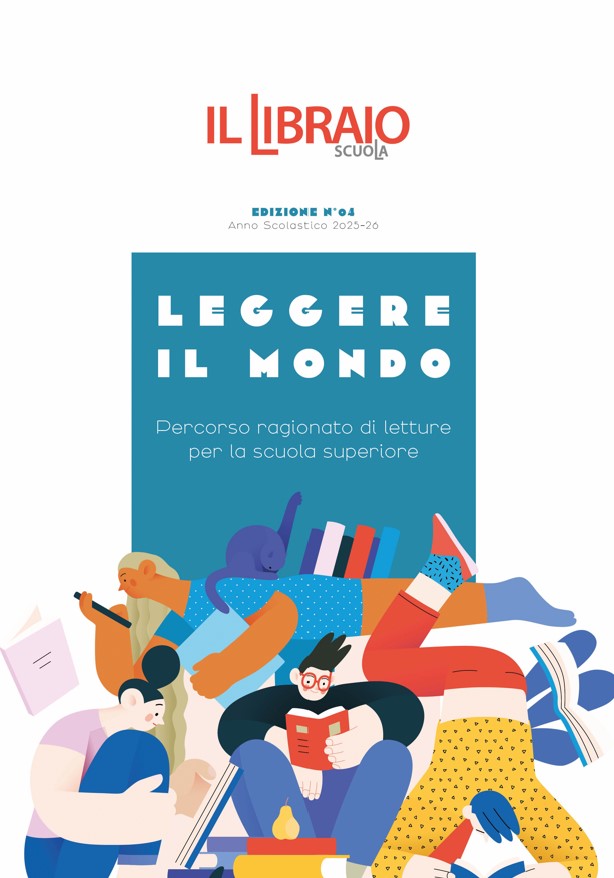
IL PROCESSO E L’INELUTTABILE CORSO DELLA GIUSTIZIA
Se La metamorfosi sorprende perché, partendo da un elemento fantastico vi si costruisce attorno un mondo sorprendentemente verosimile, nel Processo avviene quasi l’inverso. Nelle prime pagine, conosciamo il signor Josef K., procuratore in un istituto bancario: pochissimi sono i dati su di lui, perché vige su tutto l’indeterminatezza, già a partire dal cognome puntato, simbolo di un’identità presente solo a metà. Così sembriamo quasi non sorprenderci quando scopriamo che il signor K. dovrà presentarsi in tribunale e affrontare un processo. Eppure, proprio come avveniva per La metamorfosi, di solito gli studenti si chiedono subito: perché? Quale colpa ha commesso?
Non lo sapremo mai: assisteremo invece a una profonda mutazione del protagonista, che, all’inizio, crede di trovarsi davanti allo scherzo e in seguito prova a comprendere il meccanismo invece oscuro della giustizia. Noi lettori percepiamo che Josef K. si va a infilare sempre più in un tunnel da quale non è possibile uscire, benché in più punti della narrazione gli si lasci credere il contrario.
Come in un incubo sempre più angosciante, assistiamo a incontri con persone che forniscono scampoli di spiegazioni al signor K., senza però dissipare la sensazione di essere ormai in trappola. Più tanti sconosciuti rassicurano il protagonista e più si comprende l’arbitrarietà del tribunale davanti al quale K. si dovrà presentare.
Il processo, pubblicato per la prima volta postumo nel 1925, è un’opera incompiuta di Kafka, e infatti alcuni passi appaiono abbozzati e in parte frammentari, ma il finale c’è, ed è a dir poco annichilente. Oltre a offrire riflessioni sul diritto in quegli istituti dove viene studiata questa disciplina, Il processo permette di ragionare a più ampio spettro sulla giustizia. Può essere stimolante nel triennio soffermarsi sul confronto tra l’opera letteraria e il film omonimo che Orson Welles ha creato nel 1962.
Per quanto ancorato alla sua epoca, Franz Kafka testimonia in modo originale e irripetibile inquietudini, dubbi e angosce ataviche, che travalicano i decenni. La scelta di uno stile accessibile e solo sintatticamente essenziale – ma denso nelle scelte lessicali – rende le opere di Kafka un patrimonio letterario a cui ci si può accostare già negli anni delle scuole superiori. Se ne resta sorpresi o addirittura sconvolti.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it