“Mare mosso”, il nuovo romanzo dello scrittore messinese Francesco Musolino, è ambientato nel 1981 e ha il mare in tempesta come suo grande protagonista: la storia è infatti quella di un arduo salvataggio tratto da un episodio reale, che si è verificato a largo del mar di Sardegna nella seconda metà del XX secolo – Su ilLibraio.it un estratto
La notte del 24 dicembre 1981 Radio Cagliari intercetta l’SOS di un cargo turco alla deriva, la Izmir. Nella pancia della nave, in balia del vento di maestrale forza sette, ci sono seicento tonnellate di pesce surgelato.
Potrebbe affondare da un momento all’altro. Quella notte, quando il telefono squilla, Achille Vitale sale a bordo della Renault R4 e chiama a raccolta la sua piccola ciurma, organizzando i soccorsi.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
Si apre così Mare mosso, il nuovo libro di Francesco Musolino pubblicato dalla casa editrice e/o, che arriva in libreria dopo il romanzo d’esordio L’attimo prima (Rizzoli, 2019) e il saggio Le incredibili curiosità della Sicilia (Newton Compton, 2019).
Autore messinese classe 1981, giornalista culturale, conduttore televisivo e docente di scrittura creativa, Musolino mette al centro della narrazione il mare in tempesta, raccontando la storia di un arduo salvataggio ispirato a un episodio reale, che si è verificato al largo del mar di Sardegna nella seconda metà del XX secolo.

Lo scrittore Francesco Musolino
La vicenda viene raccontata dal punto di vista di Achille, che ha trent’anni, è un ingegnere navale e dirige per conto del Cavaliere – un facoltoso armatore napoletano – una flotta di rimorchiatori a Cagliari.
Il suo mestiere è quello di uscire in mare – di giorno o di notte, con qualsiasi tempo – in soccorso di yacht, motoscafi, navi cargo e petroliere in difficoltà, rischiando la vita senza paura.
In quella medesima e fredda notte della vigilia del 1981, però, ad Atene c’è un uomo molto interessato a recuperare il carico della Izmir. Qualcosa di illegale e di gran valore. Riuscirà Achille Vitale a condurla in porto, affrontando la potenza feroce del mare in tempesta, i ripetuti guasti allo scafo e le spericolate contromosse attuate da quel misterioso uomo di Atene? Ma soprattutto: riuscirà a capire cosa nasconde davvero la pancia d’acciaio della nave cargo?
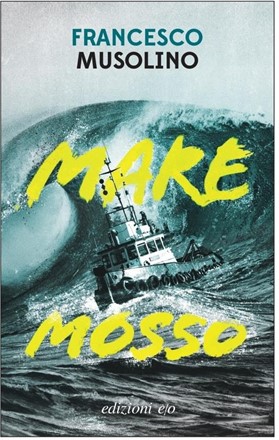
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un estratto tratto dal romanzo:
Io sono il Pacifico. E sono il più grande.
HUGO PRATT
Dopo averla inseguita con gli occhi, curva dopo curva, finalmente ce la troviamo davanti. Freno e già Carmine ha lo sportello aperto e un piede a terra. Corre sulla spiaggia, è basso e chiatto ma ha il piede lesto il ragazzo e noi ci affrettiamo dietro lui. La borsa Spalding mi sbatte sul fianco, il tintinnio metallico e inconfondibile dei gettoni e il tonfo del VHF che rimbalza mentre i piedi affondano nella sabbia umida. Grande come un walkie-talkie, il VHF ha un display LCD giallo ambra su cui spiccano, nere, le cifre della frequenza radio, la potenza del segnale e il volume di ricezione. Sulla sommità c’è una manopola per accenderlo o spegnerlo e ovviamente l’antenna, nera spessa e flessibile perché fatta di gomma. VHF sta per Very High Frequency, frequenza molto elevata, a indicare una comunicazione che avviene su onde radio ultracorte. Le trasmissioni in VHF sono dirette e devono fare i conti con gli ostacoli e la curvatura terrestre, non essendo abbastanza potenti per propagarsi negli strati più alti dell’atmosfera e poi ripiombare giù.
Può interessarti anche
Eccolo il mercantile, si alza sopra le nostre teste. Lo guardiamo, baciato dalla luna che gli dona una sfumatura metallica. Maestoso. Lo scafo è dipinto di nero e sul bordo superiore c’è una fascia rosso cadmio ormai stinta, tirata via dal vento, dalla mancanza di cura. Il cassero a poppa e due stive refrigerate, le fiancate grattate dal tempo inclemente hanno grosse macchie di ossidazione e ruggine. La poppa fortunatamente è ancora immersa in acqua, l’elica a prima vista sembra pescare bene e il nome della barca, dipinto a grandi lettere d’acciaio sporgenti di una ventina di centimetri, è stato cancellato dal tempo e dall’incuria. La vernice è scrostata ma si legge ancora qualcosa. Izmir. E poco sotto: La Paz.
Ecco il nome e la città di registrazione del cargo nel registro navale internazionale.
«La Paz. Ma dove cavolo sta La Paz?» dice Carmine. «Pensavo che ci saremmo trovati per le mani un cargo greco, francese o magari turco. Ma La Paz, che è? Dove si trova?». E dicendo così indica la poppa. Arrampicata sul pennone, afflosciato su se stesso, c’è un drappo tricolore. Rosso, giallo e verde.
«Camerun?» dice Georgos.
«Boh» replica Efisio. «Che ci fa qua una nave battente bandiera camerunense?».
«Forse Ghana o magari Libia?» ipotizza Carmine.
«No, no. Liberia? O Egitto. Oppure, Irlanda?!» spara a caso Georgos.
«Sì vabbè, ci manca solo la Svizzera. Ragazzi, c’è scritto La Paz, non Ginevra o Il Cairo. La Paz è la capitale della Bolivia» dico serafico, chiudendo la questione e facendo tornare il silenzio nella caletta. Come se fosse la cosa più normale al mondo trovare un cargo alla deriva nella notte di Natale in una golfatina fuori Oristano. E per di più, con la bandiera di uno stato semisconosciuto dell’America del Sud. Argentina o Brasile d’accordo, ma la Bolivia?
Mentre sento i loro sguardi perplessi puntati addosso mi concentro sul nome. Izmir, il nome turco di Smirne, uno dei maggiori porti sulla costa. Vuoi vedere che questo è un cargo turco, rivenduto al miglior offerente?
«Scusa, Achille» Carmine torna a farsi sotto. «La Paz? Bolivia? Ma sei proprio sicuro?».
Abbiamo una nave da salvare ma se continua così, non la finiamo più. Gli poggio una mano sulla spalla.
«Fìdati Carmine. Pagando, l’armatore si prende la bandiera che gli piace di più e buonanotte ai suonatori. Poteva andare peggio, poteva capitarci una nave battente bandiera mongola».
«Ma sei sicuro? O ti atteggi perché vuoi chiudere la discussione? Onestamente, Achì… ma quando mai hai visto la bandiera della Bolivia, tu?».
«Carmine» ora lo fisso dritto in faccia, «hai presente le Ande? La catena montuosa che attraversa tutta l’America Latina? Sì? Fai sì con la testa solo se ce l’hai presente».
Lui fa un debole cenno di assenso. Poco convinto, si vede che finge, malamente.
«Bene. La Paz si trova in Bolivia. È la sua capitale».
«Sicuro?».
«Sì, Carmine».
«Vabbuò».
«E non vi ho detto la parte più bella». Mi giro e li fisso uno per uno mentre mi accendo una sigaretta. «In Bolivia manco ci sta».
«Cosa?» replica Efisio.
«Il mare. La Bolivia è tutta montagna. Però, possono vendere la bandiera».
«Madonna mia…» commenta Carmine e scuote il capo, sinceramente sconsolato.
Può interessarti anche
Capisco il suo sconforto. Le navi, quelle belle, quando sono in rada, quando sfilano e tagliano la linea dell’orizzonte, ci appaiono immense, colossi d’acciaio, leviatani frutto dell’ingegno e della tecnica umana. Le navi, però, possono essere fragili e spezzarsi in due tronconi in mezzo alla tempesta ma in questo caso, davanti a questo esotico vessillo sudamericano, abbiamo la testimonianza di quanto sia libero e incontrollabile il mare e, con esso, i suoi alfieri. E noi siamo come pedine in questo grande gioco. Un tempo, prima della Seconda guerra mondiale, la questione era semplice: la nave veniva costruita in un bacino di carenaggio, era il risultato della progettazione di un cantiere e sulla poppa, a grandi lettere, veniva citata la città di provenienza, orgoglio nazionale che avrebbe solcato i mari portando gloria alla propria fucina. Ma con il libero mercato le cose sono cambiate velocemente, la gente si è fatta furba, pure troppo, e oggi questi scafi d’acciaio possono cambiare identità e prendere una nuova bandiera in un batter d’occhio, rivolgendosi al paese che fa meno domande. Volendo, basta il lavoro di un giorno per ridipingere un intero scafo di una nave cisterna o di un cargo come questo, cambiando interamente la livrea, persino nome e bandiera.
Per me si tratta di una reazione fisica. Se un veliero a cinque alberi naviga davanti alle isole Eolie battendo bandiera inglese o, ancora meglio, il glorioso tricolore italiano, mi batte forte il cuore e mi ricordo i momenti belli all’Accademia Navale di Livorno, quando noi cadetti marciavamo tutti insieme nelle nostre divise tirate a lucido. Ma quando mi capita di andare a raccattare mezzi relitti che issano bandiere di comodo, mi incazzo forte. Eppure, queste cosiddette bandiere di comodo erano nate all’inizio del secondo conflitto mondiale con un fine decisamente più nobile, quello di consentire alle navi americane di trasportare merci in Gran Bretagna. In tal modo non si voltavano le spalle all’alleato europeo ma, nel malaugurato caso di un loro affondamento, non avrebbero dovuto trascinare gli Stati Uniti nel bel mezzo del conflitto. Ci pensarono i tedeschi a far precipitare la situazione. Oggi è un proliferare di bandiere a scacchi rosse, bianche e blu – Panama – o di croci bianche su sfondo rosso – Malta –, fino alle strisce rosse e bianche con stella su fondo blu – Liberia. Da qui a giungere alla Mongolia o alla Bolivia è solo questione di fantasia. Ma soprattutto, a cosa serve tanta libertà, in alto mare? Ecco qual è la vera domanda.
Può interessarti anche
«Ora che abbiamo finito la lezione di geografia, ci mettiamo a lavorare o no?» sbotto, poi mi accendo l’ennesima sigaretta e alzo lo sguardo sullo scafo.
La Izmir è una nave di discrete dimensioni. È lunga, a occhio, una sessantina abbondante di metri, larga circa dodici. Da terra saranno oltre dieci metri e incombe su di noi. Ma il fatto che sia turca fa scattare tutti gli allarmi possibili nella mia testa. Da quando sono il direttore tecnico della Siresa Mare Spa abbiamo salvato rimorchiatori, yacht e pescherecci in panne ma le navi turche erano sempre quelle combinate peggio, bagnarole galleggianti. Stavolta spero di sbagliarmi.
In ogni caso, finalmente è giunto il momento della verità. Le ore d’attesa al tavolaccio di fòrmica, i caffè bruciati, le carte che non vengono, i giornali spiegazzati, le avventure di Corto Maltese nel Pacifico, le notti che diventano giorno invano mentre il vento soffia, urla e strepita, aspettando che qualcuno venga sopraffatto dal panico fra le onde. Mors tua, vita mea. Va bene tutto pur di non restare in balìa dei pensieri mentre il tempo non passa. Tutti noi, due volte al giorno, mattina e sera, sereno o bufera, abbiamo un appuntamento fisso. Accendiamo la radiolina e ci sintonizziamo su RadioUno per ascoltare il bollettino nautico e renderci conto della situazione là fuori. E questa sera, la sera della vigilia di Natale, mentre sono ancora a casa e sto fumando l’ennesima sigaretta prima di dare il cambio a Carmine, ascolto la voce calma e posata dell’annunciatore radio che fa il giro di tutti i mari della nostra penisola e infine, quando giunge al Mar di Sardegna, dipinge uno scenario pessimo: “Mar di Sardegna: visibilità discreta, vento da Nord Ovest forza 7, tempo nuvoloso, mare agitato”.
Non solo, le previsioni a ventiquattro ore annunciano bufera con vento da nord-ovest forza 8 e con mare molto agitato. Ma del resto, se fai questo mestiere, se il tuo compito è quello di andare a recuperare le navi alla deriva, se hai scelto di fare questo per guadagnare, devi avere la calma dalla tua parte e, come sempre, anche la fortuna. All’improvviso, con i piedi piantati nella sabbia, mi torna in mente quel salvataggio in cui proprio la Dea bendata giocò un ruolo fondamentale. Era notte, e avevamo raccolto un SOS lanciato da uno yacht francese, Galatea, una barca della stazza di venti tonnellate, appartenente al dipartimento di Nizza. Quella volta era di turno Carmine. Dopo il solito giro di telefonate ci siamo imbarcati a bordo del rimorchiatore Varazze. Avevano il motore principale in avaria e intanto il mare era montato all’improvviso. Ecco, dire “mare forza 10” non significa un bel nulla, suona bene ma tecnicamente non esiste. Il mare non possiede forza, i bollettini meteo si riferiscono a quella del vento, misurata dalla scala di Beaufort, composta da ben diciassette gradi – da “calma” a “bava di vento, circa tre nodi”, fino a “uragano”, con un vento maggiore di sessantaquattro nodi – mentre per misurare lo stato del mare si tiene conto dell’altezza media delle onde. E solo per comodità le due scale possono essere unite. Quella notte, quando siamo arrivati nel punto delle ultime coordinate a bordo del Varazze, non c’era nessuna traccia del Galatea ma le onde erano alte circa quattro metri, il vento aveva superato i venti nodi e il fatto che non ci fosse nemmeno un pizzico di luna non migliorava il quadro complessivo. Il radar taceva, non c’era più segnale radio e sul panfilo era rimasto solo un misero cavo sbattuto dal vento. Dopo un’ora trascorsa a muoverci facendo cerchi concentrici, finalmente a bordo dello yacht si sono decisi a lanciare un razzo d’emergenza. La rossa scia luminosa saliva in cielo, tracciando un arco. Non eravamo lontani, circa una trentina di miglia. Ho abbassato la manetta, «Motori avanti tutta!», e con la potenza dei duemila cavalli del motore diesel del Varazze li abbiamo accostati proprio nel cuore del Mar Tirreno. I cinque, ormai in preda al panico, avevano cercato di abbandonare la nave a bordo del tender, la cima si era già mollata da un pezzo ed erano rimasti senza motori, senza radio e senza canotto di salvataggio. Niente male come vacanza. Efisio e Georgos avevano lanciato la cima d’ormeggio e finalmente lo skipper era riuscito ad annodarla alla bitta di poppa con una gassa d’amante, quel nodo semplice e salvavita. Li abbiamo fatti sbarcare uno alla volta sul Varazze e li abbiamo rifocillati con del tè caldo e molto zuccherato. Erano due giovani coppie francesi e visto che il loro skipper di fiducia non c’era, si erano affidati all’ultimo momento a questo ragazzo smilzo che veniva da Bodrum. Abbiamo dato cavo di rimorchio e iniziato il traino dello yacht a quattro-sei nodi, ci avremmo messo tutta la notte ma erano sani e salvi. A quel punto, anche se il mio francese non era ottimo, avendo speso un’ora intera senza sapere dove andarli a recuperare, li ho ammoniti malamente.
Può interessarti anche
«Mai uscire in mare senza… come si dice… sans gilet di… salvataggio… de sauvetage, e senza razzi di segnalazione! Never. Jamais! Tu, voi, comprendes?».
Il proprietario, un certo Renée, era un ragazzo con i capelli biondi bagnati come un pulcino, mi guardava con gli occhi stravolti, le labbra livide, quasi nere per il freddo e il viso arrossato dal vento. Aveva una coperta sulle spalle, tremava per lo spavento mentre la sua fidanzata gli teneva forte la mano. Si erano già immaginati naufraghi in una notte senza luna e con il mare in burrasca, praticamente morte certa. Efisio è andato verso uno stipetto e, dopo aver sganciato il fermo per evitare che si aprisse in navigazione, ha preso un razzo: un cilindro marrone che somiglia ai candelotti di dinamite che si vedono nei film western, munito di una spoletta alla base che, una volta tirata, lascia partire un bengala di segnalazione. Gliel’ha messo proprio sotto il naso.
«Razzo! Come lo chiamate voi? Rocket, no… fusée!».
Il tizio francese si è alzato in piedi, si è messo a urlare contro il loro skipper e poi gli si è lanciato contro ma quello, nel frattempo, aveva fatto in tempo a ripararsi dietro un tavolo. Insomma, i razzi a bordo c’erano eccome ma li aveva sequestrati quello stronzo. Roba da matti.
«Appena vi sbarco» ho detto allo skipper, sempre con l’occhio alla strumentazione, «fai meglio a tornartene a Bodrum…». Georgos aveva afferrato a uno a uno i passeggeri e li aveva consegnati alle cure di Carmine e poi, durante quel teatrino, era rimasto in silenzio, fumando una delle sue puzzolenti sigarette senza filtro, accucciato sul ponte di poppa. Ma appena ho pronunciato il nome del grande porto turco, Bodrum, Georgos è scattato su, ha affrontato a muso duro lo skipper e gli ha mollato un cazzottone in faccia mandandolo steso lungo a terra. Poi ha frugato nella giacca del tizio e dalla tasca interna ha preso cinque razzi. Cinque. Li ha stretti in mano e li ha sollevati in alto, a beneficio di tutti. A quel punto i quattro francesi sono balzati in piedi, caracollando uno addosso all’altro per via del rollio del mare, applaudendo e urlando, liberandosi d’un colpo di tutto il terrore di quella notte in alto mare fra risate e le prime lacrime.
(continua in libreria…)







