Sebastiano Nata, scrittore ed ex nuotatore professionista, in “Tenera è l’acqua”, ambientato in una Roma intima e attraversata dalla crisi e dai rivolgimenti epocali, parla di solitudine, libertà e coraggio – Su ilLibraio.it l’autore ricorda le Olimpiadi di Monaco 1972, a cui ha preso parte da protagonista
Lo abbiamo sentito alla radio, io e i miei genitori. Avevamo lasciato Monaco la mattina presto e in macchina, una Alfa Giulia, noi tre andavamo verso Roma quando diedero la notizia: un commando di terroristi, entrato nel villaggio olimpico, aveva preso in ostaggio alcuni membri della squadra israeliana. Alla fine morirono 11 atleti, 5 fedayyin di Settembre Nero e un poliziotto tedesco.
Per me, che nel 1972 ero un ragazzino, fu un capovolgimento di prospettiva inconcepibile. Dopo tanti sacrifici avevo appena coronato il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Sentivo ancora addosso la frenesia di essere riuscito a far parte della ristretta schiera dei giovani che rappresentavano l’eccellenza dello sport mondiale. Ero stato protagonista, sebbene secondario, di un evento che mi appariva come l’idea platonica della perfezione, per il quale nell’antica Grecia si interrompevano persino le guerre. E che era successo all’improvviso? Degli sconosciuti mi avevano sbattuto in faccia un episodio del conflitto israelo-palestinese, di cui poco sapevo e ancor meno mi iportava. Fatico pure adesso ad anteporre emotivamente alle mie questioni personali quelle, spesso più serie, che riguardano altri, ma all’epoca mi era proprio impossibile. Vivevo in un mondo di allenamenti e gare.
Così anche i ricordi di Monaco ’72 sono tutti dentro l’orizzonte del giovane atleta che ero.
Non ho dimenticato ad esempio la chiacchierata con il mio allenatore che suggeriva di tagliarmi i capelli a zero per guadagnere qualche decimo, mentre io resistevo perché c’era una ranista italiana che mi piaceva molto e con il ciuffo biondo, quasi bianco perché bruciato da cloro e sole, ero convinto di avere più probabilità di conquistarla. In quell’era remota del nuoto agonistico, quasi mezzo secolo fa, non si usavano né cuffie, né occhialini, né costumi idrorepellenti e tantomeno ci si depilava. Mark Spitz vinse 7 medaglie d’oro, stabilendo altrettanti record, con zazzera e baffi. Era bello come un dio pagano e faceva impazzire tutte le ragazze. Per anni ho dovuto sorbirmi la domanda di fanciulle in fiore e delle loro madri che trasognate chiedevano “hai nuotato con Spitz?” come se quello fosse il succo dell’impresa, non l’essere andato alle Olimpiadi.
In effetti ero capitato nella batteria dei 200 delfino di Spitz, ma non ce lo avevo avuto accanto, anche se alle ragazze mentivo buttando là che l’avevo perfino toccato, per sbaglio, mentre raggiungevamo insieme blocco di partenza. Quella leggenda vivente stava al centro della vasca in corsia 4, io in una corsia laterale, e al tuffo Spitz era schizzato subito avanti. A un certo punto io avevo pure bevuto, perché non ero abituato a stare dietro e a prendermi le onde degli altri, per qualche secondo l’acqua in gola mi aveva strozzato, non respiravo, però poi mi ero ripreso e avevo concluso con un tempo vicino al mio personale. Potevo ritenermi abbastanza soddisfatto, me l’ero cavata con dignità, invece mio padre era di un’opinione diversa. Quando, ancora bagnato e ansimante, sono salito sulle gradinate per abbracciarlo, mi ha detto: “Che ci sei venuto a fare alle olimpiadi se non hai battuto nemmeno il tuo record?”.
Una doccia fredda, ma presto non ci ho pensato più. In fondo l’importate era esserci a Monaco, classificarsi diciassettesimo o ventunesimo non mi pareva cambiasse granché.
Al villaggio olimpico tutto era speciale. Tanto per cominciare, qualsiasi cosa era gratis. Finite le gare, prima di tornarsene a casa, molti si davano alla pazza gioia, senza freni: ogni giorno ripetevano il pranzo varie volte in ristoranti diversi, la sera si abbandonavano a grandi bevute in bar e discoteche. Non sono sicuro che servissero alcolici, per me un tabù, ma tra i numerosi tentativi di rimorchio, spesso vani data la terribile concorrenza di tante divinità dello sport, noi comuni mortali non ci facevamo mancare niente. Lungo certi viali che portavano ai nostri appartamenti, c’erano addirittura delle fontanelle da dove, se abbassavi una levetta, usciva Coca-Cola a volontà. Si vociferava che alcuni pallanuotisti, nottetempo, avessero riempito dei secchi per svuotarli nelle vasche da bagno delle loro camere fino a riempirle e poi immergersi in quel liquido nero e frizzante. Non che fosse particolarmente piacevole, ma al villaggio, senza più impegni sportivi, era possibile realizzare qualsiasi cosa ci saltasse in testa, anche la più bizzarra. Eravamo i re del mondo.
Però anche tra i sovrani ci sono delle gerarchie. A me aveva sorpreso che, nella squadra italiana, da molti stranieri fosse posto in vetta Mennea, che a Monaco aveva vent’anni e non era la star che sarebbe diventata. Un pomeriggio mi ero ritrovato in mezzo a degli atleti di colore, dalle gambe lunghissime, che riconosciuta la mia divisa azzurra mi avevano detto: “Mennea good, very good!”. E la Freccia di Barletta non aveva ancora vinto il bronzo nei 200, con quella incredibile rimonta.
A quell’epoca non era facile vedere riunita insieme gente di tanti paesi e razze. Gli africani, gli asiatici, erano individui esotici. La globalizzazione non aveva raggiunto i livelli di oggi e le migrazioni bibliche di uomini e donne del sud del mondo non erano iniziate. In autobus eravamo tutti italiani.
Molti anni dopo, ci sono ritornato a Monaco. Ero di passaggio, per lavoro. I miei figli erano già adolescenti. Vincendo un’intima resistenza, sono entrato emozionato nella piscina delle mie olimpiadi. Mi è parsa più piccola. A bordo vasca, dietro una parete in fondo, c’erano delle panche e mi è tornato alla mente che disteso su una di esse attendeva la gara Nobutaka Taguchi. Era rimasto immobile, a occhi chiusi, dentro un sacco a pelo con cappuccio, per più di un’ora. Sembrava che nemmeno respirasse, che fosse morto. Lasciandosi alle spalle due statunitensi, si sarebbe poi preso l’oro nei 100 rana.
L’AUTORE – Sebastiano Nata è nato a Roma nel 1955. Il suo esordio, Il dipendente (Theoria 1995, Feltrinelli 1997), è stato un caso letterario. Ha poi pubblicato La resistenza del nuotatore (1999), Mentre ero via (2004), Il valore dei giorni (2010), tutti editi da Feltrinelli, e, con Barney Edizioni, La mutazione (2014). Appassionato da sempre di nuoto (ha partecipato anche alle Olimpiadi di Monaco nel 1972), è stato manager in varie società e con ruoli anche nel terzo settore. La sua opera è stata spesso accostata a quella di Paolo Volponi.
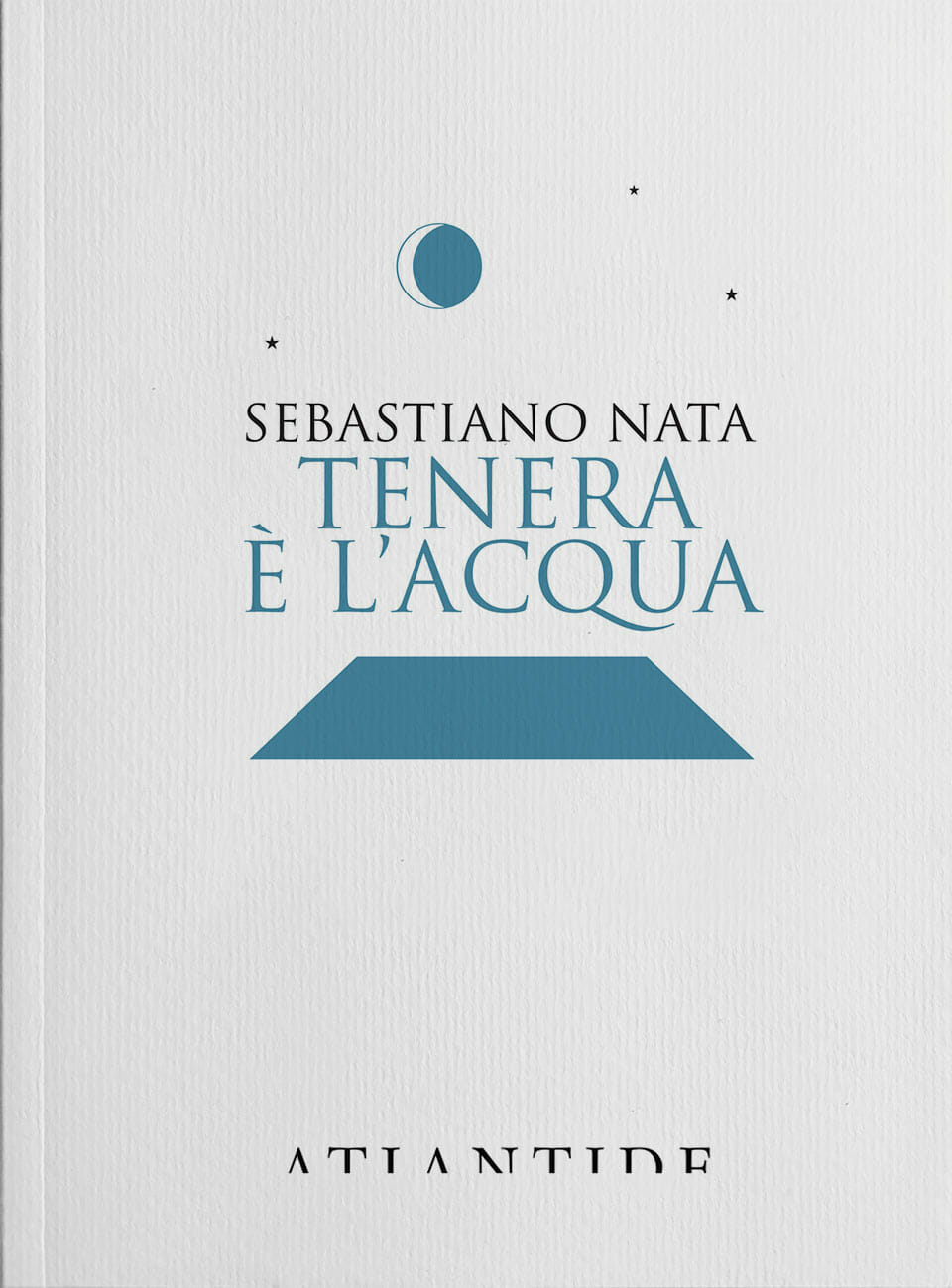
Ora Nata torna in libreria per Atlantide con Tenera è l’acqua, raccontando di solitudine, libertà e coraggio: in una Roma intima, attraversata dalla crisi e dai rivolgimenti epocali che sconvolgono il mondo, tre personaggi, due uomini e una donna, sono stretti in un rapporto di amicizia e amore. Condividono la medesima, scanzonata, passione per il nuoto ma hanno ferite profonde, dubbi sulla propria vita, si scoprono spaesati, a tratti perduti. Ognuno, a suo modo, pensa di aver fallito. Giacomo, Paola e Mattia non capiscono quello che succede a loro stessi e agli altri, l’indifferenza e l’ingiustizia che vedono ovunque attorno, hanno paura e sono quasi pronti ad arrendersi. Invece, malgrado perdite e tradimenti, si accorgono che, come per le gare in acqua nelle quali si cimentano nonostante l’età, quello che conta è resistere qualche metro in più, qualche attimo, continuando a credere che sia ancora possibile toccare il traguardo: volersi bene davvero.


