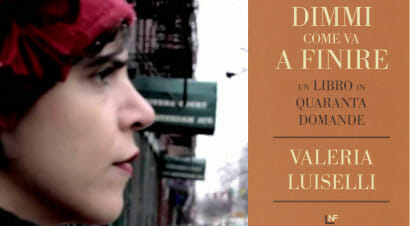“Archivio dei bambini perduti” di Valeria Luiselli è un tentativo di indagare e colmare una lacuna. Una dichiarazione di consapevolezza dei propri limiti documentaristici e narrativi, e al tempo stesso una denuncia dei limiti stessi. Quando viene concepito il romanzo è il 2014, e in lavorazione c’era un testo differente. Ma quell’anno radio, giornali e palinsesti televisivi americani parlano tutti della stessa cosa: Border Crisis. Ragazzi, bambini, “piccoli intrusi” che dal sud del continente tentano a migliaia di valicare il confine del Messico verso gli Stati Uniti, verso le loro famiglie, verso la sopravvivenza… – L’approfondimento
Tra i momenti più intensi de I Fratelli Karamozov di Dostoevskij, vi è il dialogo autenticamente, profondamente religioso che avranno Alëša e il fratello Ivan: in esso c’è una domanda su cui fa perno il dilemma di fondo, la possibilità stessa di credere, di dare un senso alla propria fede. La domanda è: “Come può Dio tollerare la sofferenza dei bambini?“.
Se dovessimo cercare un’analoga domanda fondativa di questo libro, sarebbe: “Chi sono io per raccontare questa storia?“.
Archivio dei bambini perduti (La nuova frontiera, traduzione di Tommaso Pincio) non è tanto un tentativo di legittimazione di questa domanda, ma piuttosto quello di indagare e colmare una lacuna narrativa – forse impropriamente, ma comunque colmarla. Una dichiarazione di consapevolezza dei propri limiti documentaristici e narrativi, e al tempo stesso una denuncia dei limiti stessi.
Luiselli non vuole raccontare “la storia dei bambini che ce l’hanno fatta”, che possono raccontarla (meglio) da soli, ma di quelli “che sono scomparsi, le cui voci non possono essere più udite perché sono andate perdute, forse per sempre”.

L’autrice, nata a Città del Messico, vive a New York e collabora da tempo con giornali e riviste spagnoli e inglesi. Quando viene concepito il romanzo è il 2014, e in lavorazione c’era un testo differente, che avrebbe parlato della sua infanzia in Sud Africa. Ma quell’anno radio, giornali e palinsesti televisivi americani parlano tutti della stessa cosa: Border Crisis. Ragazzi, bambini, “piccoli intrusi” che dal sud del continente tentano a migliaia di valicare il confine del Messico verso gli Stati Uniti, verso le loro famiglie, verso la sopravvivenza. Clandestinamente, in condizioni disperate, spesso soli o affidati a coyote, con cui dietro lauto compenso percorrono a piedi e di notte tratti di migliaia di chilometri. Rotte della morte nei territori dei narcotrafficanti, a cui si è costretti a pagare un’onerosa tangente.
L’autrice sa di cosa si sta parlando, come ha raccontato intervistata da Repubblica: “Quando lavoravo come interprete volontaria al tribunale di New York, incontrai due bimbe guatemalteche di cinque e sette anni: erano arrivate da sole alla frontiera col numero della mamma cucito nel colletto. Un caso debole, disse il loro avvocato. Di loro non seppi più nulla e credo che vennero rimpatriate. Da allora, la loro storia mi ossessiona. Ne avevo già scritto […] ma quella vicenda senza finale ha continuato a farsi strada dentro di me, trasformandosi […] in un romanzo tragicamente simile alla realtà“.
Come nota puntualmente Sara Marzullo su Il Tascabile, nell’Archivio la narrazione è quindi guidata da un’urgenza teorica. Lo scopo è quello di creare una conversazione (frammentaria) intorno al tema della migrazione, sondando al tempo stesso potenzialità e limiti delle modalità narrative adatte a dare più riverbero possibile non alla voce dei bambini migranti, ma a tale mancanza.
Può interessarti anche
“La storia che deve incidere non è la storia di bambini che arrivano […] la storia che voglio documentare non è quella dei bambini nei Tribunali per l’immigrazione come pensavo prima. […] Non so ancora bene come procederò, ma la storia che voglio raccontare è quella dei bambini che sono scomparsi. […] Forse. […] Vado anch’io a caccia di echi e di fantasmi”.
Come sceglie Luiselli di dare voce a questa mancanza? Non raccontandoci un viaggio finzionale di bambini migranti, ma quello di una coppia infelicemente sposata. All’inizio del libro incontriamo un marito, una moglie e due bambini che muovono verso sud. Tra i sedili della loro auto sbadigli, voci dai notiziari, giochi, silenzi. Nel baule, sette scatole.
Il viaggio dei quattro doveva essere quello di uno: il marito, “acustemologo”, dopo gli anni felici passati a New York a registrare voci e censire le lingue della città insieme alla moglie, insegue un nuovo, solitario, progetto: registrare, collezionare tutto quello che rimane dei popoli Apache del Sud. Catturare l’eco dell’ultimo indiano che si è arreso.
La moglie – prima di due voci narranti – in un tentativo di prolungare l’inevitabile addio, sceglie di seguirlo insieme al figlio di lui e alla figlia di lei. Sa comunque cosa fare: lavorare a un progetto sui minori che attraversano la frontiera. Un progetto nato forse come pretesto, ma a cui non riuscirà più a smettere di pensare.
Può interessarti anche
A rendere peculiare questo libro, oltre all’attualità delle tematiche, è la struttura: un metatesto fortemente stratificato, dove Luiselli si interroga continuamente sull’efficacia delle modalità con cui sta procedendo, stilistiche e contenutistiche, e lo fa tramite la voce dei suoi personaggi – la madre, il figlio e innumerevoli altre voci, più o meno flebili, come quelle delle scatole, ognuna assegnata a un capitolo della prima parte del testo; ognuna parte del “paesaggio sonoro famigliare“.
Cosa contengono? Quaderni, libri, album musicali, appunti, ritagli, fotografie… elementi che riecheggiano durante tutto il viaggio e che costituiscono, per citare la stessa autrice, “indicatori interlineari della moltitudine di voci presenti nel dialogo che il libro intrattiene con il passato”. Ogni scatola ha un proprietario, ma quelle dei bambini sono vuote: loro hanno ancora una vita da vivere e da scrivere per riempire le loro scatole. Persino il loro nome all’inizio del romanzo non è dato, ma viene conquistato dai bambini stessi tramite i frammenti di ciò che viene visto, letto, vissuto e digerito, fino ad assumere significato nella loro personale storia.
Un libro sui confini, fisici e linguistici – la lingua non è innocua, dirà l’autrice, tramite eufemismi ed espressioni improprie è in grado di escludere e disumanizzare. Un’opera che racconta il presente americano proponendosi come alternativa tra la dicotomia massmediatica tra catastrofe nazionale e vittimizzazione radicale.
“Mamma, che cosa vuol dire rifugiato?.
si è rifugiati quando si è già arrivati da qualche parte, in una terra straniera, ma bisogna attendere […] di essere arrivati davvero, a tutti gli effetti. I rifugiati attendono in centri di detenzione, ricoveri o Campi; sotto la custodia Federale e la sorveglianza di personale armato. Aspettano sempre, fanno lunghe code per mangiare per avere un letto in cui dormire, aspettano con le mani alzate quando chiedono di poter andare in bagno. Aspettano di essere rilasciati, aspettano una telefonata, qualcuno che li reclami o li venga a prendere. […]
Che vuol dire essere un rifugiato?
un bambino rifugiato è un bambino che aspetta”.