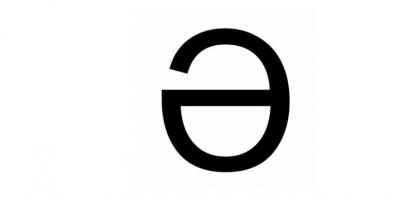“Esistono dei luoghi, al mondo, nei quali la membrana tra passato e presente, tra al di qua e aldilà, tra reale e inventato è più sottile”: su ilLibraio.it il racconto che Vera Gheno (sociolinguista, saggista e traduttrice) ha scritto per il festival “Gita al faro”
Esistono dei luoghi, al mondo, nei quali la membrana tra passato e presente, tra al di qua e aldilà, tra reale e inventato è più sottile. In questi luoghi, per una serie di motivi, può diventare più difficile distinguere tra questo e quello. Può capitare più facilmente di rivivere una scena accaduta in passato, oppure di incrociare una persona morta da tempo, o ancora, di vedere strane luci nel cielo notturno e rimanere a chiedersi se siano una meteora, i satelliti di Elon Musk o un UFO. O magari, un bicchiere di troppo.
Ventotene mi si è manifestata come uno di quei luoghi, dopo un’ora abbondante di aliscafo. Uno sperone di roccia incastonato nel mare, una luce tutta sua in qualsiasi momento della giornata, il profumo onnipresente di oleandri e gelsomini in fiore, l’aroma delle foglie dei fichi, gatti gattini gattoni impegnati un po’ ovunque nelle loro attività, relativamente indifferenti rispetto al corso delle vite umane, guardati a vista dai gabbiani più grossi che io abbia mai incontrato. Messo piede sull’isola, il controllo normalmente meticoloso che esercito sul mio tempo e sul mio spazio ha iniziato a vacillare. Dopo un iniziale momento di panico, ché mica è facile mollare la presa, quando ci si abitua a dormire con un occhio sempre aperto, sono stata al gioco. Va bene, isola: vuoi mettere alla prova la mia capacità di autocontrollo? Vediamo cosa riesci a fare.
Sono andata a letto, ho chiuso gli occhi e ho sognato. Forse, invece, mi sono seduta al buio, sulla sdraio accanto al dirupo, di fronte all’isola di Santo Stefano, ho tenuto gli occhi aperti e ho sognato lo stesso. No: mi sono buttata in mare e, cullata dalle onde, ho sognato ancora. O magari, ho camminato per le vie di una Ventotene ventosa, accarezzando ogni gatto che incontravo, e mi sono infilata in un giardino che, passo dopo passo, mi ha portata in un orto, in un altro luogo e tempo.
Fatto sta che mi sono ritrovata davanti una signora esile, vestita di bianco, con degli incongrui sabot di legno dalla zeppa altissima, accucciata a diserbare l’aiola delle fragole. O almeno così mi è sembrato. È la mia nonna ungherese, la mia nonna materna, Irén. Mi sono messa a strappare erbacce accanto a lei, in silenzio, dato che non ha mai amato sprecare le parole. Ogni tanto, i nostri sguardi si incrociano e lei fa la sua classica smorfia di approvazione: sto procedendo bene. “E con queste poi facciamo la marmellata”, mi dice. “Come stai?”, mi viene da chiederle. Nonna fa spallucce. Sono morta da vent’anni, come vuoi che stia, sembra dire.
Tutto questo mi pare del tutto normale.
Irén è alta un metro e cinquanta scarsi, non l’ho mai vista se non vestita di ampi immacolati camici da lavoro. Ha i capelli bianchissimi; quando la parrucchiera, una volta al mese, viene a sistemarglieli a domicilio, per un paio di giorni li avrà sul violetto: è l’effetto del trattamento antigiallo. Nonna Irén profuma sempre e da sempre di una sola colonia, Bien-être, che si fa portare da Occidente da mia madre; non sta mai ferma, cucina come uno stuolo di chef, si muove incessantemente sul pavimento a scacchi bianchi e neri della cucina. Oltre che preparare da mangiare, cuce, tesse, ritaglia, intreccia, ricama, sferruzza: ai miei occhi sa fare tutto. Sento ancora il rumore ritmato delle sue forbici da sarta, le stesse che, proprio in suo onore, mi sono tatuata sul braccio. Irén odia quando gli amici del nonno, alto dirigente comunista in pensione, vengono a trovarlo e le portano mazzi di fiori recisi. Fiori morti, li chiama lei. Mi ha passato la sua idiosincrasia per i fiori tagliati: per me, preferibilmente, solo piante in vaso. Mi ha passato anche scampoli della sua filosofia di vita: mai andare a letto con il muso, cercare di fare pace prima, e ricordarsi che a tutto c’è soluzione, tranne che alla morte.
Può interessarti anche
Nonna Irén non l’ho mai vista indossare un gioiello, se non la sua fede. Vedo che la indossa anche adesso, mentre strappa silenziosamente le erbacce dal letto di fragole. La veretta sta a segnalare il legame con quell’omone di mio nonno, Lajos, un marcantonio di quasi due metri, undici anni più giovane di lei, un signore statuario, compunto, amatissimo dalla sua gente. Nonno Lajos, nella sua vita di servizio, ha ricevuto molte medaglie, tutte dall’innegabile estetica comunista. Quando è morto, la famiglia voleva liberarsene, per una forma di pudore nei confronti del suo passato secondo certa gente un po’ ingombrante. Alcune le ho prese io, e oggi sono esposte in una bacheca nell’ingresso di casa mia, accanto alla medaglia al valore militare del mio nonno paterno, “nonno Berto”, che non ho mai conosciuto, essendo morto di tubercolosi a meno di trent’anni, di ritorno dalla campagna di Russia. Mia nonna Maria ha portato, per lui, il lutto tutta la vita. Ma questa è un’altra storia.
Quando ero piccola e andavo in giro con nonno Lajos per la città, per esempio per fare la spesa al mercato coperto, lo fermavano di continuo per stringergli la mano, parlargli dei loro problemi, ringraziarlo per la sua attenzione alle questioni della comunità. Al mercato, senza che lui dicesse nulla, gli mettevano da parte sempre la verdura migliore. Alla latteria, in tempi in cui il latte si comprava ancora in sacchetti di plastica termosaldati e c’era sempre la fila di persone a fare colazione con latte e caffè d’orzo – il caffè vero e proprio era un lusso – e una fetta di pandolce, le addette gli facevano sempre la cortesia di pescare i sacchetti dal profondo della cassa in cui erano conservati, per evitare che il ciclo del freddo potesse essere stato interrotto. Non era raro, altrimenti, ritrovarsi con un litro di inutilizzabile liquido rancido, soprattutto in estate.
Può interessarti anche
Per non parlare di quando il nonno prendeva in consegna me e mia cugina Kati, ci caricava sulla sua Lada bianca e ci portava a fare il giro dei suoi amici e conoscenti, nella campagna ungherese. Tornavamo con un’enorme forma da due chili di fragrante pane casereccio che ci aveva regalato il panettiere di quel villaggio, un cartoccio di salami appena prodotti dall’allevatore di maiali di quell’altro paesello, nella cui cucina eravamo state costrette a sedere compunte per mezz’ora ad ascoltare i suoi cahiers de doléances mentre, per sopravvivere alla noia di quei discorsi da grandi, osservavamo affascinate la distesa di mosche morte o morenti sulle numerose strisce di carta moschicida appese al soffitto. C’era chi ci regalava dei pasticcini freschi, o qualche bottiglia di distillato di frutta artigianale… Anche se in pensione, nonno continuava a essere benvoluto, e non tornavamo mai a casa a mani vuote.
La nonna accoglieva tutto, borbottando a volte di felicità, altre di disappunto, e sistemava le cose nella dispensa che dava sulla cucina, che per noi bambine era luogo di meraviglie: c’era sempre un dolcetto sfornato da poco, qualche biscotto, della frutta secca, un quadratino di cioccolato da sgranocchiare. Altre cose venivano portate nel deposito esterno, in fondo al cortile, che era pieno di barattoli di vetro di ogni sorta: marmellate, frutta sciroppata, sciroppi, sottaceti, passate di pomodoro, tutto ordinatamente in fila, con l’indicazione della data di produzione appiccicata sopra. E ancora, ghirlande di peperoncini messi a essiccare, mazzetti di aneto, altre erbe che nonna sapeva riconoscere e usare per preparare i suoi manicaretti. A vigilare sulle operazioni, Pompadour, il grosso, pigrissimo gatto rosso della vicina d’angolo, un felino poco incline alle affettuosità, dall’aria perennemente scocciata.
Può interessarti anche
Durante le lunghe, bollenti estati della mia infanzia, quando i miei genitori mi lasciavano dai nonni per interi mesi, vivevo in simbiosi con loro. La mattina, il rituale della spesa; dopo, c’era sempre qualche attività di supporto alla cucina che ricadeva sul nonno, per esempio tritare le noci. Questo comprendeva il montaggio del macinino a manovella e il suo fissaggio al bordo del tavolo di cucina, operazione che il nonno eseguiva con la solennità di un sacerdote intento a dire messa. La stessa con cui batteva la carne, o dadolava la verdura, o componeva i mazzetti di aromi per il brodo, seguendo le indicazioni di nonna. Alle dodici in punto, il pranzo, poi un momento di riposo per tutta la famiglia. E appena il caldo rovente lasciava spazio a una temperatura più mite, verso sera, ecco che si andava all’orto. Un piccolo appezzamento di terreno a pochi chilometri dalla città, nel quale i nonni erano riusciti a infilare una incredibile varietà di piante: amarene, albicocche, pesche, prugne, nespole, uva spina, ribes, lamponi e, per l’appunto, fragole; ma anche pomodori, carote, sedano, prezzemolo, cipolle, patate, rape, zucche, aglio. Ogni momento dell’anno aveva i suoi frutti, e ogni frutto aveva una sua finalità: i gherigli verdi delle noci venivano conservati nello zucchero, il ribes e i lamponi usati per fare sciroppi da allungare con l’acqua, le albicocche, le prugne, le amarene finivano in marmellata. E tutta la frutta ammaccata, caduta dagli alberi, troppo matura, difettata veniva raccolta e messa a fermentare in enormi bidoni, per ricavarne un distillato ad altissima gradazione alcolica, la pálinka, che gli ungheresi usano spesso come aperitivo, per preparare lo stomaco al pranzo. Tutto aveva dei profumi e dei sapori che non ho mai più ritrovato da nessuna parte del mondo.
Può interessarti anche
Nonno e nonna lavoravano instancabili come due api operaie, raccogliendo dissodando annaffiando diserbando; poi, a un certo momento, si sedevano su due ceppi di legno sotto la tettoia all’estremità inferiore del campo e si riposavano. Stavano lì, in silenzio, senza un gran bisogno di parlare per farsi compagnia: due di quelle anime accoppiate per l’eternità. Dopo un po’, tornavamo verso casa, e il momento clou del viaggio era quando il nonno lanciava il bolide – o meglio, il ferrovecchio bianco dall’innegabile estetica sovietica – in discesa, mettendo la folle e spegnendo il motore, in modo che potessimo rotolare per inerzia fino alle porte della cittadina, “per risparmiare benzina”. La gara era, ovviamente, ad arrivare il più avanti possibile senza riaccendere l’automobile.
Sento un colpo di clacson da lontano, mi volto di scatto a seguire il rumore improvviso. Quando mi rigiro, la signora vestita con il camice bianco se n’è andata, o forse non c’è mai stata. Però vedo una macchina bianca, un po’ scassata, allontanarsi lungo via Olivi, e mi piace pensare che siano loro, per un momento tornati a trovarmi qui, a Ventotene, dove la membrana che separa i mondi sembra più incerta.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
IL FESTIVAL – Dal 21 al 24 giugno la piazza, la libreria e i giardini di Ventotene hanno accolto la dodicesima edizione del festival Gita al faro: 6 ospiti (Donatella Di Pietrantonio, Federica Manzon, Monica Acito, Giosuè Calaciura, Chiara Gamberale e Vera Gheno) anche quest’anno hanno vissuto l’isola e in particolare Santo Stefano e il suo carcere borbonico, al fine di scrivere un racconto ispirato a questi luoghi cosi significativi per la storia del nostro Paese e dell’Europa.
Il festival Gita al faro è diretto da Loredana Lipperini ed è ideato e organizzato da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca. A promuovere la rassegna è l’ Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene. Partner del festival è Intesa Sanpaolo.