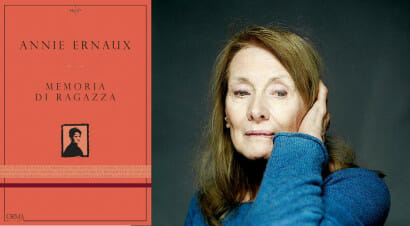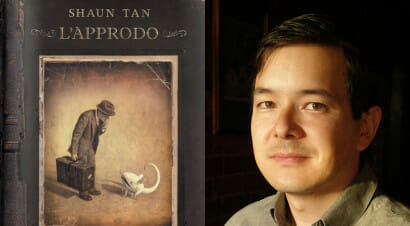“Non mi sento di appartenere a Seoul, ma neanche agli Usa. Il mio bagaglio culturale oscilla tra l’Occidente e l’Oriente”, spiega Krys Lee, coreana-americana, autrice del romanzo “Come siamo diventati nordcoreani”, in una lunga intervista a ilLibraio.it. La scrittrice, senza mai cedere agli stereotipi, tocca tante questioni delicate e attuali, racconta la sua esperienza diretta con i rifugiati della Corea del Nord e si confronta con il difficile problema dell’identità nazionale…
Come siamo diventati nordcoreani (Codice, traduzione di Stefania De Franco, Flavio Iannelli e Daria Restani) è il romanzo d’esordio di Krys Lee, scrittrice originaria della Corea del Sud e cresciuta negli Stati Uniti, già autrice della raccolta di racconti Drifting house (inedita in Italia).
Lee è nata a Seul in una tradizionale famiglia coreana. Aveva all’incirca quattro anni quando i suoi fuggirono negli Stati Uniti: il padre, autoritario e rigidamente cristiano, riteneva di essere sotto sorveglianza del governo per la sua attività a sostegno del movimento democratico e decise di abbandonare il Paese; si trasferirono negli Stati Uniti, e non fu una passeggiata crescere in una famiglia povera con un padre molto rigido.
Può interessarti anche
Grazie agli ottimi voti, Krys ottenne una borsa di studio per la facoltà di Lettere alla UCLA (University of California, Los Angeles) e poi a Londra con un programma di scambio; al termine degli studi andò in Corea del Sud per quello che doveva essere un breve viaggio ma, come rivela in un’intervista con il Guardian, “cominciavo a capire meglio me stessa e la mia famiglia, sentivo il bisogno di restare”, e si fermò, cominciando a costruire la propria vita in Corea.
Fu allora, intrecciando amicizie nel suo paese d’origine, che entrò in contatto con i primi rifugiati nordcoreani e cominciò a collaborare con le organizzazioni che aiutano i profughi a lasciare la Corea del Nord: li accolgono e li aiutano a inserirsi nella società. È da questa esperienza che nasce il suo nuovo libro, Come siamo diventati nordcoreani.

Il romanzo segue le vicende di più personaggi, diversi tra loro per personalità ed esperienze, ma accomunati da un bisogno impellente di fuggire dalla dittatura: ciascuno con il proprio bagaglio di esperienze e di dolore, di speranze e sbagli, scappano dalla tortura e dalla morte certa che li aspetta in patria, alla ricerca di una libertà che non sono sicuri di poter raggiungere. Si nascondono in un mondo di soldati e di spie, in una delle zone più calde al mondo, dove anche tra i missionari si annidano i nemici: l’autrice stessa è entrata in contatto con un missionario che, in un centro di accoglienza in Cina, teneva con sé un ragazzo nordcoreano e lo usava per ottenere donazioni, rifiutandosi di lasciarlo andare e facendone, a tutti gli effetti, un suo prigioniero. Quando Krys lo venne a sapere aiutò il ragazzo a fuggire e ricevette diverse minacce dal missionario, al quale poi si è ispirata per costruire uno dei personaggio del libro. ilLibraio.it ha intervistato l’autrice, per parlare dell’esperienza reale da cui ha tratto il libro.
Può interessarti anche
Krys Lee, cosa l’ha spinta a tornare in Corea dopo gli studi a Londra?
“Quella che doveva essere una borsa di studio di un anno in Inghilterra era diventata di tre anni, e io cominciavo a dare per scontato che mi sarei stabilita permanentemente a Londra; poi d’impulso decisi di posticipare il mio matrimonio con un inglese per passare un anno di ‘ozio’ a Seoul, prima di stabilirmi nel Regno Unito…”.
Cosa l’ha convinta a restare?
“La prima cosa che mi colpì a Seoul fu quanto mi sembrasse strano, ma allo stesso tempo familiare, il paese. Era anche una nazione che mi interessava e, da persona che ama imparare, mi piaceva vivere in un paese non anglofono, piantare radici in un luogo profondamente diverso dalle culture occidentali in cui ero cresciuta. Giorno dopo giorno, capivo che i grandi interrogativi della mia vita avevano origine in Corea del Sud. Alla fine restai lì, cercando di capire cosa fosse successo alla mia famiglia e alle generazioni di migranti che avevano deciso di partire”.
Come ha cominciato a lavorare nei centri di accoglienza e assistenza ai profughi nordcoreani?
“Durante il mio secondo anno a Seoul divenni amica di alcuni attivisti che lavoravano con i nordcoreani, venni a sapere della carestia in Corea del Nord e ne fui toccata, mi disturbava. Si può pensare che la Corea del Nord e quella del Sud siano nazioni diverse tra loro, popolazioni diverse, ma la divisione tra le due è storicamente recente e artificiale, tanto che la differenza tra le condizioni di vita nei due paesi fu fisicamente scioccante per me. Poco tempo dopo mi unii a una Ong e divenni cara amica di molti attivisti e disertori della Corea del Nord”.
Ed è così che ha cominciato.
“Esatto, da allora in poi finii col diventare, in modo del tutto naturale, una sorta di ‘attivista per caso’, aiutavo in qualunque modo mi fosse possibile. Non ho mai vissuto il mio coinvolgimento nell’organizzazione come un lavoro o una ‘causa’; si trattava di amici che avevano sofferto enormemente, perduto i propri familiari e le proprie case”.
Può interessarti anche
Qual è stata l’esperienza più difficile con i rifugiati?
“Lavorare al confine tra la Cina e la Corea del Nord per allestire un casa sicura per i rifugiati nordcoreani. Dovevo collaborare con i missionari cinesi-coreani locali, membri di bande organizzate e molto altro, fu la sfida più grande per il mio idealismo. Tendo a dare per scontato che garantire i diritti umani fondamentali a tutti sia più importante di qualunque dogma o tornaconto personale, soprattutto per gli attivisti che operano in Corea del Nord. Ma non è questo quello che ho visto succedere al confine con la Cina”.
E quella più soddisfacente?
“È difficile, ce ne sono tante, ma la più recente è stata l’anno scorso, quando ho cenato con un uomo nordcoreano che diversi anni fa avevo aiutato a fuggire. Ci siamo incontrati diverse volte negli anni, e ho potuto vedere enormi cambiamenti nella sua vita e nel suo comportamento. Mi ha regalato una collana d’oro e mi ha detto che non solo avevo salvato la sua vita – cosa che mi ricorda ogni volta che ci vediamo – ma anche che, per lui, è come se fossi la sua famiglia. La sua fiducia ha significato veramente molto per me”.
Le è capitato di riscontrare differenze nelle capacità di adattamento tra i rifugiati uomini e donne?
“Delle differenze vi sono certamente, ma qualunque generalizzazione riguardo le vite dei nordcoreani porta a inutili e fuorvianti stereotipi. Le reazioni e le capacità di adattamento variano a seconda dell’estrazione sociale, il livello di educazione, l’età e molto altro. Ma ogni atteggiamento ‘standard’ ha così tante eccezioni che sarebbe sbagliato, da parte mia, dare una risposta diretta alla domanda”.
Quindi non è possibile individuare un fattore discriminante?
“Se esiste, il fattore determinante è l’età: più il rifugiato è giovane più sono alte le sua possibilità di transitare in una società capitalista e adattarsi, ricevere un’educazione sudcoreana e trovare lavoro”.
I concetti di cittadinanza e identità sono fondamentali nel suo romanzo: è una problematica che ha riscontrato nei rifugiati con cui è entrata in contatto?
“Assolutamente: i rifugiati nordcoreani non hanno soltanto perso la loro casa, sono persone che non potranno mai tornare nel loro Paese, persone che hanno valori, ideologie e schemi storici di riferimento radicalmente diversi dal resto del mondo. Scoprire che così tanta parte di quello che ti è stato insegnato è una bugia è difficile da accettare”.
Toglie loro ogni certezza.
“Non solo: vedere il tuo paese, in cui hai vissuto, diffamato e deriso dal resto del mondo è ancora più difficile da accettare. Molti cominciano a vergognarsi delle loro origini eppure, allo stesso tempo, sono costantemente identificati come nordcoreani, non importa quale cittadinanza finiscono con l’adottare nel nuovo Paese”.
Un’identità di cui non si possono sbarazzare in un certo senso?
“Proprio così. Una nuova generazione di nordcoreani politicamente attivi sta lentamente cambiando questo meccanismo, e credo anche che un senso di identità e di orgoglio stia crescendo all’interno di una certa minoranza di rifugiati. Ma per la maggioranza di loro, essendo nordcoreani, in Corea del Sud vengono associati alla povertà, allo spionaggio e a un’educazione di basso livello. E questa è una tragedia per i rifugiati di tutto il mondo: agli occhi degli altri vengono ridotti alla loro condizione di profughi, pur avendo alle spalle una storia, una cultura, un’educazione che magari non riescono a dimostrare, proprio perché ‘sradicati’ dal proprio paese”.
Può interessarti anche
Da coreana-americana, qual è l’aspetto più difficile dell’avere una cittadinanza e un’identità doppie e miste?
“Essere una coreana-americana non è un particolare problema: la difficoltà sta nell’essere una persona che ha vissuto la prima parte della sua vita in Occidente e la seconda metà in Asia. Spesso mi riferisco a me stessa come a una ‘casa alla deriva’ (Drifting House, Casa alla deriva, è anche il titolo del primo libro di Krys Lee, una raccolta di racconti non ancora tradotta in Italia, ndr), come molti figli dell’immigrazione di ritorno”.
Cosa intende dire?
“Non mi sento di appartenere a Seoul, ma quando torno in America per una visita, non mi sento di appartenere neanche lì, perché il mio bagaglio culturale oscilla tra l’Occidente e l’Oriente. Ma ho imparato a convivere con questo disagio. Forse gli scrittori, ovunque siano, sono spesso persone che bramano di appartenere a una comunità, per questo scrivono e creano queste creature solitarie, emarginate e lontane dalla società, per poi unirle e farne delle comunità nei loro libri”.
I libri sono sempre stati per lei, fin dall’infanzia, una via di fuga: leggere le permetteva di fuggire da una situazione domestica e familiare difficile. Oggi nello scrivere trova la stessa possibilità di evasione?
“È molto più difficile ‘evadere’ oggi, di quanto non lo fosse in passato, bisogna fare i giocolieri tra il lavoro e le pulizie, la spesa, le tasse, le riunioni e centinaia di piccoli impegni quotidiani che rischiano sommergerci. E tutto questo rende più difficile scappare in altri mondi. Zadie Smith una volta disse che bisogna combattere per difendere dagli altri lo spazio che dedichiamo alla scrittura; credo che questo valga per tutte le arti o i passatempi che non hanno un tornaconto pratico immediato”.
Può interessarti anche
Quindi qualcosa è cambiato.
“Quando ero una bambina credevo che scrivere fosse una via di fuga dalla realtà, e ora sto cominciando a pensare che scrittura e lettura appartengano alla realtà. Entrambe offrono un modo di vedere e percepire esperienze, il che fa parte del mondo reale. Detto questo, preferisco di gran lunga la realtà dello scrivere, del leggere, dell’andare in kayak e in campeggio rispetto alla realtà dei piatti sporchi, che pure vanno lavati. Magari un giorno sarò una persona ‘illuminata’ e, come il monaco Buddista Beopjong, apprezzerò ogni momento, compresi i piatti sporchi”.