Andrea Salonia è al debutto nel romanzo con “Domani, chiameranno domani”, ambientato nella sua Puglia. Il protagonista è il direttore della fabbrica di acciaio più grande d’Italia, ora agli arresti domiciliari – Su ilLibraio.it un capitolo del libro
L’ingegnere Augusto C. è uomo metodico, rigoroso, arido di parole, e pugliese di Manduria, cittadina dai tetti piatti nel Salento meno noto, famosa per il suo vino rosso, il Primitivo, tramandato nei secoli a partire dagli antichi Messapi. Augusto C. è stato il direttore della fabbrica di acciaio più grande d’Italia; accusato di una continuativa e consapevole forma di disastro ambientale da sversamento di sostanze nocive nell’aria, adesso è agli arresti domiciliari.
Così, chiuso nei molti ma claustrofobici centotrentasette metri quadrati della sua casa, stagione dopo stagione, oggetto dell’opinione pubblica, Augusto C. perde i suoi sensi; prima l’olfatto, il gusto, quindi il tatto, poi l’udito e infine la vista. Accanto a lui c’è sempre Graziella, moglie, in primo luogo, ma donna forte, amante della cucina di quella loro terra, dove arriva anche il salmastro del mare. E cucinare insieme li salva; salva Augusto, che imparando a preparare le pietanze racconta la sua vicenda di uomo, dal padre contadino e infermiere, libero nell’animo in sella alla sua Bianchi azzurro del cielo; racconta del periodo di lavoro in Giappone, dei suoi figli Lorenzo e Gaetano, di quanto fossero diversi, della madre e della sua faccia da radice; racconta dell’acciaio e della gente della fabbrica che per tanti anni era stata la sua vita intera. Ecco – dice un Augusto senza (il) senso – questi sono gli arresti domiciliari, rallegrarsi che il proprio padre sia già morto.
Andrea Salonia, medico, è al debutto nel romanzo con Domani, chiameranno domani (Mondadori), libro in cui lo stile e il ritmo emotivo giocano un ruolo importante, e in cui non mancano i riferimenti alla realtà, ambientato nella sua terra.
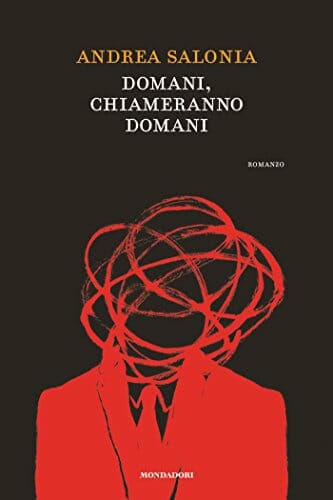
Su ilLibraio.it, per gentile concessione dell’editore, proponiamo un estratto:
Martedì, giovedì e sabato. Questi sono i miei tre giorni, e solo tre. Le docce sono venti, i minuti sono venti, ogni volta. Le persone, quelle, invece, sono molte, parecchie di più, in dieci metri per quattro. Quattro metri e mezzo, per esagerare. Misuro ogni cosa, è dentro di me. Qui mi è anche di conforto. A casa adoro il il momento della doccia, subito dopo fatta la barba; bollente, che quasi la pelle brucia. Quella del mattino è veloce, energica, per svegliarmi. La sera mi lascio cadere l’acqua addosso, lenta, come fosse pioggia, fino a stancarmi. È un poco come dar tregua alla giornata, segnarne la fine. Ogni sera uguale, a momenti un rito; a doccia finita, prendo un pettine dai bicchieri in fila sul lavabo, uno per il lunedì, un altro per il martedì, e poi uno diverso per gli altri tre giorni della settimana in cui si lavora. Li ho scelti blu; è un vezzo, e un’ossessione. Qui è differente. Qui ciascuno ha solo venti minuti per sé; barba, una doccia senza onore, proprio solo per lavarti lo schifo di dosso, poi ci si deve asciugare, una passata di pettine, di furia, il tutto in venti minuti. Quindi fuori tutti, e avanti gli altri venti. Mi sono portato uno dei miei pettini da casa, ma mi è stato sequestrato all’ingresso. Ne ho cercato uno blu allo spaccio, avrebbe fatto un po’ regola e consuetudine. Ne ho trovato uno con denti fittissimi, rosso.
Ho deciso di chiamarli come i colori, ciascuno una tinta; mi aiuta far così, li rende più cose, e meno persone. Forse me ne dimenticherò più in fretta, una volta fuori. Forse sarà un poco come non esserci stato, qui.
Il Rosso lo devo aver già incontrato. Viena dalla Sicilia, alto, con una carota sbiadita in testa, come di antico Normanno. È immobile, gli occhi sempre in basso, aspetta il suo turno, ma capisci che non ti perde mai, anche se gli stai dietro nella fila, a distanza, anche se gli sei nascosto. Il Rosso sa cosa fai, perfino se sogni. È il Rosso che mi ha spiegato come si debba fare la doccia qui, la prima volta. Non pensavo che a cinquantasette anni dovessi ancora imparare come fare una doccia, ma è stato così. Si chiama Gavino. Il nonno era sardo, e il suo nome viene dalle montagne della Gallura. È stato quando mi son tolto le mutande, il primo martedì:
Qui le deve tenere addosso, le mutande, e si deve lavare con quelle. Anche col sapone, ma al loro posto.

Il Verde l’ho chiamato così perché le mutande le ha sempre verdi, oliva, o bottiglia. Quando le bagna, sembra avere il sottobosco tatuato. Qui ti vengono in mente cose stupide come questa. Lo speri, in realtà, perché per lo più la testa ha un rumore di fondo, affollata com’è di malinconia, e ti mancano tutti. Oggi pensavo alla Bianchi azzurro del cielo di mio padre, e a quando si è perso, finito in mare con le ruote, i piedi, i pantaloni, senza ricordarsi come ci fosse arrivato. È morto in fretta, non molto tempo dopo, senza la Bianchi, e il suo azzurro del cielo.
A me qui danno tutti del Lei. Del Lei con la L maiuscola, lo capisco da come muovono le labbra e arricciano il naso. Sono molto cordiali, amabili perfino, ma con rispetto. Anche Gavino, il Rosso, che quasi si vergognava per me, per le mie mutande tolte, il primo martedì nelle docce. Gavino era stato mio dipendente in fabbrica, faceva il magazziniere, io non lo conoscevo di persona e prima non sapevo nemmeno come si chiamasse. Adesso è tutt’altra cosa; io resto l’ingegnere, con la L grande, ma le mie mutande, la mia merda, il mio piscio sono come quelle di tutti gli altri. Marrone la prima, giallo il secondo.
Il Fucsia porta sempre una bandana disegnata dai figli, fucsia, appunto, con grandi fiori e le foto dei bambini: Mi hanno detto che così penso a cose belle, anche qui. Ci va anche sotto la doccia, con la sua bandana. Rubava, e l’hanno preso. I figli sono tutto, per il Fucsia.
Gavino ha i denti gialli, sporchi del fumo di trent’anni filati di venti sigarette al giorno. È qui per fatti non da poco, così mi ha detto, senza specificare, e certo io mi guardo bene dal chiedere, che sapere a me non guadagnerebbe nulla. A lui invece dire farebbe gran male. Gavino, il Rosso, è un po’ la nave scuola. Chiunque arrivi qui non è proprio a suo agio, soprattutto la prima volta nelle docce; non sa dove appoggiare il sapone, perché non ci sono mensole, né grandi ma neppure piccole; non sa dove appendere il telo per asciugarsi, perché gli appendiabiti sono lontani; non sa che le mutande qui ce le si deve tenere addosso anche quando ci si lava i coglioni. Il perché non saprei dirlo, ma di certo ha a che fare con la morale comune. E nel chiuso di questa stanza delle docce, venti docce, per venti minuti, per venti persone, più quelle che ti osservano all’ingresso, la morale perde i suoi connotati comuni e insieme il pudore.
Il Nero è proprio un nero. È venuto dal Senegal, davanti al mare di Gorée, l’isola degli schiavi prigionieri, destino vuole. Qui ci è finito per spaccio. Smerciava davanti al liceo, quello dove andavano anche i miei figli. È nero, tanto che sembra il centro della terra e fa fin paura, e puzza, perché negarlo, un odore di sudore che taglia l’aria, ed è difficile stargli vicino.
Bianco e blu. Sono i miei colori preferiti, fin da bambino, io con le canotte bianche, mio fratello con quelle blu. Pensavo di non separarmi mai da mio fratello, anche se è più giovane di me di otto anni e otto mesi. Perfino la stessa università, nella città delle “madamine”, lontani da casa. Poi lui si è trasferito nella capitale, si è sposato quasi in Campidoglio, ma il bianco e il blu sono rimasti i nostri colori. Qui, in fila accanto a me c’è sempre un vecchio con gli occhi blu, e i capelli bianchi, diafani ormai. L’ho chiamo il Blu, il suo nome è Vittorio. A me ricorda l’orchestra di piazza Vittorio a Roma, quella a metà della destra che dà botte e l’altra degli immigrati che suonano i fiati. Ogni volta sorrido al vederlo, e sento la musica; non ascoltavo mai la musica prima. Anche il Blu lavorava in fabbrica, faceva il controllore dei termostati, un ruolo importante, un grado in più o in meno negli impianti e si facevano danni gravi. Ne avevo duecento come Vittorio.
Il Ruggine è basso, e ha una voce polverosa, che graffia quasi. Sceglie sempre la doccia di fronte alla mia, e si lava con poca voglia, proprio come il ferro che non ama bagnarsi, e si rovina col tempo. Il Ruggine è così, sfuggiva la gente. Aveva rubato il rame dai tralicci. Il suo complice c’era rimasto appeso, arso come uno spiedo del mercato. Il Ruggine ha ancora nel naso il puzzo di bruciato, e di morto.
Di Vittorio mi ricordavo, avevo in mente un uomo mansueto, come le bestie quando le addomestichi. Era mite, da fuori; Vittorio è qui perché ha sparato a un tizio, non voleva ucciderlo, ma quello ha pensato bene di morire. Mi ha detto che desidererebbe raccontarmi perché lo avesse fatto. Io, invece, non vorrei proprio sentirla quella sua storia, non vorrei farmi carico anche della sua, oltre che di quelle di Gavino e di Sandro, e di quella di Gregorio il Bigio, di Marco il Giallo, di Luciano l’Azzurro, di Guglielmo e di tutti gli altri. Non vorrei davvero sentirmi girare in testa anche le loro venti realtà, oltre alla mia; sarebbe troppo, una folla di storie, e di vite, e di risa, e di urla, di colpe, o di soprusi. Io voglio uscire in fretta da qui, prima possibile, e dimenticare la fila per le docce, il martedì, il giovedì e il sabato. O almeno vorrei provare a farlo, scordare il carcere, e i loro colori.
(Continua in libreria…)


