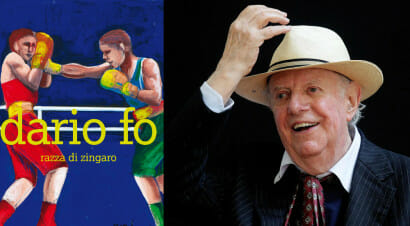Ne “Il treno notturno”, raccolta arricchita da sette racconti inediti, Thom Jones (1945 – 2016) si addentra in un viaggio crepuscolare tra giungle tropicali, dipendenze da psicofarmaci e incontri di pugilato all’ultimo sangue. Arriva in Italia il compendio più completo dell’autore americano, che ha stupito il pubblico con la sua violenta autenticità – L’approfondimento
In una parte della letteratura americana contemporanea si è andata rafforzando una tendenza alla scrittura autobiografica, all’esperienza-del-sé, generando in alcuni casi un vero culto della testimonianza. Ci si è chiesti, allora, per chi (e a chi) stia parlando l’autore o l’autrice, se tutto quello che si trova nelle pagine è la propria ombra.
Poi, però, prendiamo Il treno notturno (minimum fax, traduzione di Martina Testa), raccolta di racconti distillata direttamente dal vissuto dell’autore, e ci chiediamo: come possiamo accettare quella forza trascendente (e universale) che percorre dei testi così sanguigni, fisici, legati in modo quasi insostenibile al corpo e alla mente di un singolo individuo?
È sufficiente percorrere i primi tre scritti di questa opera per essere folgorati dalla certezza che nella penna di Thom Jones si coagulano pericolosamente tutti i migliori – e peggiori – miti americani. Allora bisogna chiedersi: è possibile che una sola vita abbia riassunto in sé tutte le esperienze più traumatiche degli ultimi cinquant’anni di una nazione? Dove finisce il vissuto, e dove inizia l’invivibile?
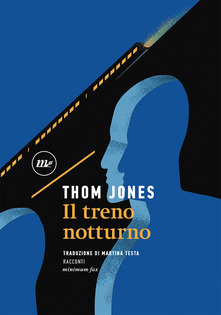
Come scrittore tardivo, l’arte di Thom Jones inizia molto prima della sua scrittura. Ancora prima di entrare nella propria giovinezza, il padre di Thom viene internato in un istituto psichiatrico, dove morirà impiccandosi senza poter più vedere il figlio.
Da ragazzo sviluppa, come il padre, una passione per la boxe che lo porta su qualche ring come peso medio. E qui incorriamo nel primo mito americano: quello del lottatore, del campione.
“Avevo ventisette anni, fumavo due pacchetti al giorno, ero al limite dell’alcolismo. Non avrei dovuto combattere con lui, lo sapevo, ma faceva troppo lo sbruffone. Molto tempo prima ero stato il campione dei pesi medi della Prima Divisione dei Marine. Ero stato un cosiddetto eroe di guerra. Ma adesso ero soltanto un marine di guarnigione, e in pessima forma”.
La boxe di Jones è un incontro al limite del solipsismo, dove il ring si svuota e non rimane che un solo avversario: sé stessi. Il racconto cardine, Il pugile a riposo, è interamente giocato su questa solitudine dell’agonismo, perché l’avversario non è davvero mai umano.
Può interessarti anche
È come il macigno al quale venivano legati i pugili del passato, come Teogene di Taso, che tempestava di pugni gli sfidanti ma non poteva muoversi, incatenato in quel modo a una roccia. Esiste una condizione, un limite, a cui tutto deve sottostare. Una di quelle condizioni – ma non sarebbe scorretto dire uno di quei miti – per Jones, è il trauma del Vietnam.
“Appena gli altri videro la vaselina, mi implorarono di passarla in giro. Non ero l’unico che stava soffrendo di combustione interna. Sulla pelle di quasi tutti i membri della squadra , fili di fumo rancido si sollevavano da fori minuscoli come punte di spillo”.
La verità storica è che Thom Jones non si è mai recato in Vietnam. Durante l’addestramento a Camp Pendleton, in seguito a un incontro dilettantistico, Thom subisce un trauma cranico che lo porterà da un ospedale psichiatrico all’altro, prima con una diagnosi di schizofrenia, poi di un particolare tipo di epilessia, la stessa, si dice, di cui soffrì Dostoevskij.
Può interessarti anche
Nelle numerose figure che popolano Il treno notturno, dai soldati cialtroni ai sergenti rabbiosi, dai medici nichilisti alla lobby dei bidelli, dai pugili innamorati alle madri incapaci di amare, un unico sentimento di inadeguatezza fa da matrice alla forma umana dei personaggi. Se ognuno di questi personaggi è a suo modo vero, come parcellizzazione di un’esperienza dell’autore, essi sono allo stesso tempo fuori luogo, inadatti, sbagliati.
“La lepre vede troppo, il leone troppo poco: ecco qui la differenza tra la felicità e l’inferno, ammesso e non concesso che uno sia un leone vero, e non un povero coglione che non sa come stanno le cose”.
È questa capacità mortale di “vedere troppo” a portare Jones, che ormai veste il camice del bidello, cinquantenne e alcolizzato, a pubblicare il suo primo racconto sulle pagine del New Yorker. La critica e il pubblico lo acclamano, l’ultimo mito americano si compie: quello dell’individuo che sopravvive con le proprie forze, che ottiene successo con il proprio operato.
Se questa opera in parte inedita (sette dei racconti contenuti vedono la luce per la prima volta) ha un potere, è quella di fare sì che la vita vera e il mito immaginario si annientino a vicenda. Dove la biografia emerge, così si innalza anche la narrazione storica, per poi affondare insieme nel gorgo dell’indicibile.
Non importa che tu non abbia mai attraversato il confine del Messico strafatto di psicofarmaci, passato giornate inutili nel buio di una stanza, o che tu non sia mai stato salvato da un cane dopo una crisi epilettica. Perché ci sono opere come questa che hanno il coraggio dire che nella vita tutto è Vietnam, tutto è un gancio imprevisto che ti sfonda il mento, tutto è la conseguenza di un trauma che non abbiamo mai vissuto.