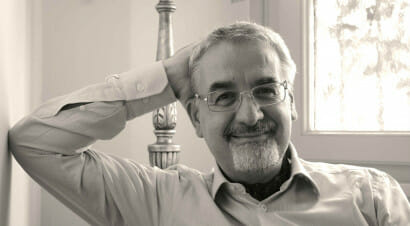Come capire se un figlio ha bisogno di aiuto? Quali sono i comportamenti che devono mettere in allarme mamme e papà? A che rischi vanno incontro oggi i giovani? L’adolescenza è una terra impervia e inesplorata, in cui spesso sia i ragazzi sia i genitori rischiano di perdersi. Su ilLibraio.it il capitolo “Come imparare ad ascoltarli” dal saggio-guida “Anime adolescenti” di Furio Ravera, psichiatra e psicoterapeuta
Furio Ravera, psichiatra e psicoterapeuta, già cofondatore con Roberto Bertolli della Comunità terapeutica Crest, dirige presso la casa di cura Le Betulle un reparto per la diagnosi e il trattamento dei disturbi della personalità e le tossicodipendenze.
Ravera ha pubblicato Un buco nell’anima (con Guido Vergani e Roberto Bertolli, Mondadori), Un fiume di cocaina (Bur Rizzoli) e Le regole o la manutenzione della Vespa (Ponte alle Grazie).
A metà gennaio esce per Salani il suo nuovo saggio, Anime adolescenti – Quando qualcosa non va nei nostri figli. Un libro attuale, una guida destinata ai genitori di oggi.
Come si spiega nel saggio, l’incontro con i figli al momento della nascita è un incontro fra sconosciuti che genera un legame indissolubile. Il bambino è impegnato in un processo di conoscenza gigantesco: deve imparare a riconoscere i segni che provengono dal mondo interno, le emozioni, e quelli dal mondo esterno.
All’inizio dell’adolescenza si realizza una situazione analoga. Qui ci troviamo in un periodo molto delicato, nel quale possono avvenire apprendimenti distorti riguardo al modo di affrontare le cose, la gestione delle emozioni, i rapporti con gli altri. La partita fra adulti e ragazzi si gioca sulla capacità di vero ascolto e di riflessione, sulla consapevolezza di ciò che si desidera per i figli, facendo attenzione alle attese più o meno forti su di loro, e sulla genuinità della relazione.
Come capire allora se un figlio ha bisogno di aiuto? Quali sono i comportamenti che devono mettere in allarme i genitori? A che rischi vanno incontro oggi i giovani? L’adolescenza è una terra impervia e inesplorata, in cui spesso sia i figli sia i genitori rischiano di perdersi.
Su ilLibraio.it per gentile concessione della casa editrice, un estratto:
Come imparare ad ascoltarli?
Primo: non si facciano paragoni: ‘ai miei tempi…’ e così via. I tempi sono molto cambiati e non si può ascoltare onestamente nessuno se non lo si colloca nel tempo in cui vive. Perciò non dimentichiamo di costruirci una rappresentazione esauriente dell’ambiente e delle consuetudini sociali attuali. Cerchiamo di capire quali sono gli ostacoli più diffusi, come funzionano le relazioni a livello di dinamica dei ruppi, soprattutto come funzionano i fenomeni per cui si è esclusi o accettati, le relazioni preferenziali, che sono molto liquide, i migliori amici che improvvisamente non lo sono più, le vicissitudini sentimentali e l’esposizione mediatica di ciò che segue alla rottura di una relazione, con feroci gelosie attivate dalle foto sui social. Secondo: validare le emozioni e i pensieri che vengono comunicati. Se un figlio o una figlia comunica un certo disagio emotivo per una particolare situazione, non si può rispondere con frasi che comunicano svalutazione o divieto: ‘Non devi provare questa emozione! Non devi formulare questo pensiero’. Spero che sia facile capire come questi atteggiamenti siano errati. Il compito, certamente difficile, è trovare un modo per convivere con certe emozioni, prendere confidenza con esse, modularle e attenuarle in maniera che non pilotino le nostre azioni. È importante assimilare questo principio, che aiuta a chiarirsi le idee: i problemi non nascono dal dolore o dal disagio, ma sono la conseguenza di quello che facciamo del nostro dolore o del nostro disagio.
Può interessarti anche
In altre parole si deve imparare a creare uno spazio temporale fra la percezione della sofferenza e le eventuali azioni per mitigarla, valutando opzioni diverse. Quando questo intervallo di tempo non c’è più o non c’è mai stato si confonde addirittura la sofferenza con il rimedio, buono o cattivo che sia.
Un esempio interessante è offerto dal craving, il bisogno incoercibile che i tossicomani possono sperimentare, anche quando sono disintossicati da un mese, della sostanza da cui sono dipendenti.
Se, nel corso di un trattamento terapeutico i pazienti sono stati addestrati a tecniche per tollerare lo stress, familiarizzano con un procedimento nuovo: quando sorge un craving osservare la situazione, come suggerisco sempre, fotogramma per fotogramma, e ripercorrere all’indietro tutti i momenti che ne hanno preceduto l’insorgenza alla ricerca di un pensiero, un ricordo, una sensazione apparentemente neutra che tuttavia ha avuto la capacità di attivare un disagio – questo è il punto su cui porre attenzione – che a sua volta ha causato il craving come rimedio automatico al disagio.
Può interessarti anche
Questo vale anche in assenza di tossicodipendenza. Al posto del craving possono esserci automatismi mal appresi, che vengono attivati davanti a un disagio. Questi comportamenti disfunzionali vengono indicati come i tratti caratteristici di un disturbo psicologico. Sono già la febbre o l’ascesso, non il batterio che li produce. Sappiamo tutti che è meglio attaccare il batterio anziché la febbre, e questo principio vale anche in psichiatria e psicologia clinica. Parlando con i pazienti e i loro familiari ho notato la presenza di automatismi disfunzionali che sono causati dalla frettolosità con cui viene trattato il disagio, come una cosa da attaccare subito o da cui fuggire senza conoscerla.
Allora cos’è l’ascolto dei figli da parte dei genitori?
È una proposta e un sostegno ai figli perché imparino ad ascoltare se stessi ed è contenuta nella domanda: ‘Cosa provi in questo momento?’ Questo non significa che dobbiamo diventare terapeuti dei nostri figli, significa semplicemente annunciare che siamo disponibili ad ascoltare le loro emozioni, a individuarle e capirle insieme a loro. Questo è un gran passo, è prendersi cura di loro, conoscerli, senza pretendere di diventare terapeuti. Alle famiglie che si rivolgono a me io consiglio di fare sedute di apprendimento di mindfulness, per imparare a osservare quello che c’è nel momento in cui decidiamo di interrogarci. Questo consente di comprendere come si muove la nostra attenzione acquistando una maggiore padronanza, di osservare i nostri pensieri ed emozioni generando una piccola ma significativa distanza fra noi e loro e permettendoci di scoprire che noi non siamo i nostri pensieri e le nostre emozioni, e che con esse possiamo avere un rapporto diverso.
Suggerisco questo perché mi sono accorto, nella pratica clinica, che la capacità di auto osservazione è scarsamente diffusa, ma come si fa a sostenere i figli in questo compito se non lo si sa fare? Se non è mai stata sperimentata questa separazione fra noi stessi e le nostre emozioni? Dopodiché conviene anche domandarci cosa sappiamo fare, noi genitori delle nostre emozioni. Sappiamo riconoscerle? Sappiamo modularle? Ne siamo vittime? Le svalutiamo? Le neghiamo? Ognuno di questi quesiti evoca risposte che possono rivelare una risorsa o un problema. Chiediamoci che genere di ascolto può avere un genitore che svaluta o nega le emozioni: capirà ben poco dei racconti dei problemi del figlio e le sue risposte saranno frustranti perché non includeranno un aspetto sostanziale, la coloritura emotiva dell’esperienza. Certe emozioni non sono nemmeno ben riconosciute dai ragazzi e, per tale motivo, non accedono a livello del linguaggio, perciò vengono espresse con il comportamento. Se si negano le emozioni, non possono essere compresi nemmeno i comportamenti.
Si rimane bloccati a un’interpretazione razionale di tutto, per cui la risoluzione di un disagio finisce per essere solo un atto di buona volontà, con conseguente colpevolizzazione del giovane. La volontà infatti funziona fintanto che il disagio non raggiunge un livello da generare comportamenti obbligati, da pilota automatico, per i quali la volontà non può fare nulla.
Ci sono dei genitori che riconoscono il disagio psicologico del figlio, ma per affrontarlo lo esortano a comportarsi come se fosse perfettamente sano e dotato di spiccate capacità psicologiche, superiori alla media. Naturalmente nel dialogo con i figli le cose non vanno meglio per quei genitori dominati dalle proprie emozioni o spaventati da esse. Alcuni genitori manifestano sentimenti di colpa per i problemi dei figli e alcuni ne rimangono paralizzati. I figli si accorgono che i genitori non reggono, che sfuggono o al contrario chiedono di essere protetti dai figli stessi, in una sorta di inversione di ruolo.
Bisogna trasformare questo sentimento di colpa in una risorsa, una spinta a studiare in cosa pensano di essere stati mancanti, inadeguati, aiutandoli a riconoscere che non erano dominati da un’intenzione maligna di danneggiare i figli, semplicemente in certe circostanze non avevano tutte le risorse proporzionate al compito. Se in una famiglia si è verificato uno stato di disagio per un figlio, non si può pensare che l’unica persona su cui è necessario intervenire sia il figlio stesso. Durante le varie fasi di sviluppo, dalla nascita in poi, i genitori sono un organo che partecipa in maniera complementare allo sviluppo psichico del figlio e come tali devono partecipare al processo di cura dando una disponibilità all’osservazione di sé e al supporto per la correzione di quelle disfunzioni che si sono dimostrate significative per la malattia del figlio.
Non esistono genitori che non sono stati figli di qualcuno. Ognuno fa i conti con queste figure e riceve un calco dalla relazione con loro, quelli assenti e responsabili di incuria e quelli presenti responsabili delle loro disfunzionalità. Taluni genitori veicolano traumi che hanno un effetto transgenerazionale e che devono essere evidenziati e trattati. In sintesi, quando si prende in carico un giovane paziente i genitori non possono essere considerati come un’entità neutra, ma vanno indagati anche quando in apparenza le cose sembrino andare bene.
(continua in libreria…)