In questa realtà contraddittoria e violenta la tenerezza è ciò che servirebbe per poter vivere e sentire in un mondo finalmente comune. Con il suo saggio Isabella Guanzini racconta il bisogno dell’umanità di una virtù che, se autentica, si insinua con delicata tenacia tra i grandi sentimenti civili e la retorica del potere – Su ilLibraio.it un capitolo
Parlare di tenerezza significa parlare di amore, di tempo che passa, di filosofia. Significa parlare di umanità e di curiosità verso l’altro, di quella leggerezza profonda che ci permette di intercettare, fra le righe, il senso più fecondo e creativo della nostra finitezza, della nostra fragilità. Ed è questo che fa Isabella Guanzini – professoressa ordinaria di Teologia fondamentale all’università di Graz dal 2016, filosofa e teologa – nel suo Tenerezza, La rivoluzione del potere gentile, in libreria per Ponte alle Grazie.
Perché la tenerezza, se autentica, non sopporta facili definizioni: si insinua con delicata tenacia tra le grandi virtù civili e la retorica del potere. Lo sanno bene DeLillo e papa Francesco, Platone, Max Weber e Foster Wallace, Enea. Lo mostra la cronaca giornaliera quando parla della tragedia dei migranti.
La tenerezza è ciò che servirebbe per poter vivere e sentire in un mondo finalmente comune, ma, purtroppo, spesso, manca. Per questo motivo è tanto importante parlarne, e, al tempo stesso, è un’impresa ardua. Oggi, in questa realtà contraddittoria che, nella sua opaca pesantezza, si rende indecifrabile, narcisistica, violenta e sentimentale al tempo stesso: oggi c’è un estremo bisogno di una “rivoluzione”: la rivoluzione del “potere gentile”, la Tenerezza.
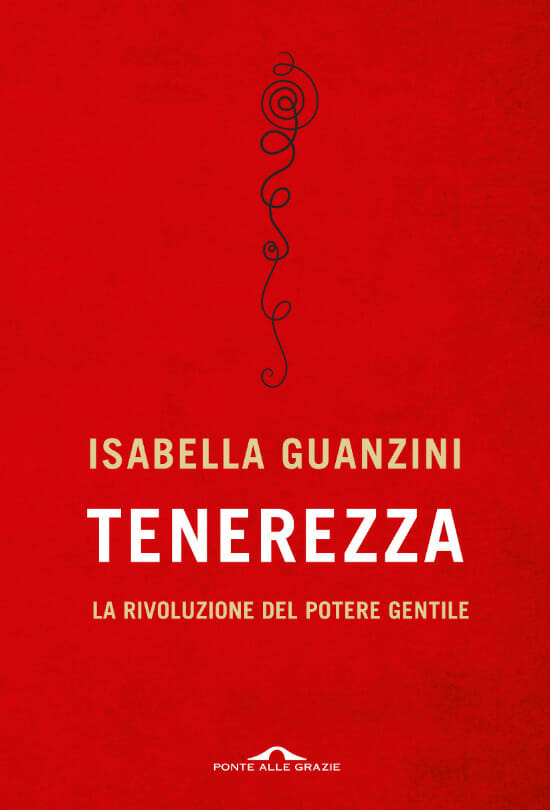
Per gentile concessione dell’editore, riportiamo un estratto:
Tenerezza mediterranea
Lampedusa e Lesbo disegnano i confini meridionali e orientali dell’anima europea: rappresentano i suoi limiti geografici e spirituali, ossia la sua verità ultima, dove deve venire infine a capo di se stessa. Due isole come due occhi d’Europa verso l’interno e verso l’esterno, che restano spalancati anche per giorni per le storie di orrore e di speranza che passano davanti a loro. Sono “porte d’Europa”, ora soglie dolorose di un rito di passaggio verso un’età della vita possibilmente migliore. Come ogni esperienza di iniziazione, tuttavia, portano con sé una prova di sofferenza talvolta inaudita, grazie a cui non sempre i corpi divengono effettivamente più forti. Il monumento di Paladino a Lampedusa, la sua porta sul Mediterraneo di ceramica e ferro zincato sull’ultimo promontorio d’Italia affacciato verso la Libia, ricorda il dramma di migliaia di migranti in esodo forzato, che hanno perso il proprio destino agognando una terra. L’occhio che è l’isola è il solo testimone di chi non è mai riuscito a raggiungerla e il monumento è lì a dichiararlo, in onore dei morti del mare, per le generazioni a venire. La sua ceramica speciale assorbe e riflette la luce, perfino quella lunare, perché esso sia un faro simbolico anche per le traversate notturne, in modo che le carrette del mare che raggiungono Lampedusa non finiscano semplicemente ammassate nel cimitero delle barche che si trova a poca distanza.
Lesbo e Lampedusa non sono però isole soltanto di morti, ma anche e soprattutto di vivi. Sono come l’epilogo di vicende millenarie, al limite dei continenti, in cui si deposita l’infinita complessità e bellezza di un’umanità sempre più in dispersione. Nelle zone di soglia e di confine si concentra ciò che gli apparati e le istituzioni non riescono a elaborare e integrare nei loro processi e nei loro dispositivi: negli hortis migrantibus viene alla luce la nuda vita dell’umano nella sua verità ultima, oltre ogni maschera e sovrastruttura – ma anche oltre ogni giustizia e ogni cura.
A Lampedusa è ora possibile visitare il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo, un nuovo orto simbolico dal nome bellissimo, che intende promuovere una “cultura che unisce”. Insieme a opere d’arte e fotografie dedicate ai migranti, espone gli oggetti recuperati in mare durante i salvataggi. Così desidera essere un luogo di memorie del sottosuolo, in onore di tutte le storie dolenti di uomini e donne scomparse nell’acqua. Come la giovane madre africana di Favour, mai giunta in terra italiana. Favour è una bimba di nove mesi sbarcata a Lampedusa da sola: sua madre, una giovane del Mali, incinta di un altro bambino, è morta durante la traversata, uccisa dalle molte ustioni causate dal carburante del gommone che li trasportava verso la Sicilia. Altre donne, anche loro ferite da ustioni serie su tutto il corpo, l’hanno presa con sé, tenendosela stretta, fino ai soccorsi della guardia costiera, che le ha raccolte e condotte al poliambulatorio dell’isola.
Ecco il mondo messo nelle lotte
Ecco l’alta marea del pianto con singhiozzo e cateratte
Ecco il veleno. Ecco lo schiaffo e l’ustione. Ecco l’amputazione.[1]
Qui la bambina è stata accolta, accudita con acqua, latte, biscotti e creme protettive. È un nuovo abbraccio in terra straniera, ugualmente materno e paterno, dopo la perdita in mare della tenerezza originaria. È qui, a Lampedusa, che le è stato dato il nome Favour: è diventata la favorita, la privilegiata, la bimba chiamata per nome, e proprio per questo aperta realmente a un nuovo destino. Dopo l’appello del medico locale, Pietro Bartolo, che è testimonianza vivente di cosa significhi accogliere e curare i migranti, o diagnosticarne la morte, la sua storia ha suscitato attenzione e commozione, facendo giungere sull’isola moltissime richieste di adozione. In un’intervista a margine del film Fuocoammare (2016), di Gianfranco Rosi, che vuole essere un racconto della vita degli abitanti e dei migranti dell’isola, il medico elogia il grande spirito di accoglienza dei lampedusani, abituati a raccogliere tutto ciò che arriva dal mare. In un passaggio racconta:
Tra tanta tragedia loro mi hanno regalato il momento più bello: nella stiva di una nave affollata trovai una donna nigeriana che stava per partorire. Le si erano rotte le acque ma non aveva trovato spazio per partorire e non aveva più le contrazioni. La portai in ambulatorio e lì allestimmo una sala parto di fortuna: le feci un parto cesareo per salvare la piccola, ci riuscii ma non era in buone condizioni. Era notte piena, non avevo parlato con nessuno della cosa. Quando uscii dall’ambulatorio con il cuore pesante trovai cinquanta donne di Lampedusa che erano corse portando pannolini, vestiti, passeggini. Ora la donna e la bambina vivono a Palermo. La bambina l’hanno chiamata Gift, dono. È stato un dono bellissimo per tutti noi.
Favour e Gift sono due regali del Mediterraneo, nate nel o sopravvissute al dramma dei profughi del nostro tempo. Concepite in terra africana, sono state poi custodite da gesti di tenerezza siciliana. Per quanto drammatico e incerto sia stato il loro venire al mondo, un gesto di tenerezza ha impedito loro di uscirne, a differenza di quelle che sono state bruciate dal carburante di un gommone o risucchiate dal mare, dove cercavano la vita e invece hanno trovato la morte. Favour e Gift sono due doni ma anche due nomi donati, entro un contesto sociale e culturale che, come ha dichiarato in modo appassionato Papa Francesco proprio a Lampedusa, genera “una globalizzazione dell’indifferenza”, che “ci rende tutti ‘innominati’, responsabili senza nome e senza volto”. Il chiamare per nome è il dono di una possibilità nuova di vita entro una condizione di assoluta esposizione indifesa. Tenerezza nomina qui precisamente la percezione profonda dell’infinita precarietà e fragilità della vita, della sua mancanza estrema, che si manifesta in una bambina di nove mesi arrivata in Italia da sola, o in un neonato fuoriuscito dalla pancia di una madre come dal ventre di una barca alla deriva. Qui la tenerezza è ciò che rompe la “bolla di sapone» dell’indifferenza globale che «ci rende insensibili alle grida degli altri”. Il primo viaggio a Lampedusa di Bergoglio vuole ridarci e ridare a se stesso la capacità di piangere e di sentire tenerezza per tutto ciò che nella vita sembra ormai perduto.
“Adamo dove sei?”, “Dov’è tuo fratello?”, sono le due domande che Dio pone all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: “Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo?”, chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie?
La tenerezza corrisponde a una ritrovata capacità di piangere insieme all’altro e alla possibilità di comprendere questo stesso pianto come un gift o un favour per tutti. Nello stesso tempo, tenerezza è il gesto che fa nascere, contro ogni speranza, in mezzo ai barconi e ai relitti; o quello che dà un nome e una tazza di latte a una bimba africana scampata alle ustioni del mare.
Anche nella tendopoli di Idomeni, fra Grecia e Macedonia, dove vivono più di sedicimila profughi, la storia di un bimbo appena nato diventa il simbolo della tragedia umana in corso. Una foto intensissima, dai toni caravaggeschi, che sembra un Giudizio universale per il tempo presente, ritrae un neonato che viene lavato con l’acqua di una bottiglia di plastica, poco dopo il suo parto. Una donna lo tiene sollevato sopra un pavimento di fango, un uomo lo bagna ed entrambi lo puliscono teneramente dall’orrore di un destino incerto. Sullo sfondo, due bambini si sporgono dalla piccola tenda che sembra scoppiare di umori e di gente, dove la madre ha forse partorito fra lacrime e sangue. Il neonato è sospeso fra l’aria e la terra, sotto una piccola cascata d’acqua, con la sua memoria genetica di fuochi e battaglie che la famiglia si è appena lasciata alle spalle.

LEGGI ANCHE – La rivoluzione della tenerezza
Il piccolo corpo esposto a ogni elemento è nuda vita per eccellenza: non si può espellere ma nemmeno accogliere, e resta così sulla soglia fra i viventi e i morenti, segregata entro una zona di indistinzione fra corpo biologico e corpo politico in un campo ai confini del mondo. È immagine eloquente della vita nello stato di eccezione, in cui tutto può accadere nel vuoto di diritti, di doveri e di dignità. Questi campi sono come i buchi neri d’Europa, in cui vengono risucchiati secoli di civiltà, di cultura e di umanità. Il corpicino neonato sembra essere l’ultima cerniera fra mondo umano e mondo inumano, come un ponte delicatissimo che collega mondo dei morti e mondo dei vivi, a pochi centimetri dallo sprofondamento. È una copula mundi, come la chiamerebbe Marsilio Ficino, un elemento di connessione fra sensibile e sovrasensibile, un piccolo anello di congiunzione fatto di fragilità e di bisogni, capace di tenere ancora insieme i mondi se la tenerezza saprà preservarlo.
Qui si tocca la potenza dei legami fra le generazioni anche nella devastazione, che si esprime in gesti di tenerezza che sfidano la brutalità della guerra, della miseria e dell’esilio. Soltanto se non interromperemo il flusso dei legami nonostante la violenza e la degradazione, se sapremo versarci l’un l’altro piccoli getti di acqua fresca nell’aridità della condizione presente, la vita potrà continuare. Se sapremo avere abbastanza tenerezza da custodire questo flusso fra le generazioni, impedendo che il fango ricopra tutto con la sua consistenza melmosa e oscura, l’umanità sarà preservata, a Lampedusa, a Idomeni o negli slum metropolitani. “Se l’acqua con cui ti hanno lavato non sarà stata troppo fredda, se i microbi e i batteri che proliferano nella fetida melma pestata da scarpe esauste non infetteranno la ferita del cordone ombelicale, allora anche per noi ci sarà perdono”.[2] A Idomeni la vita tuttavia resiste, come una piccolissima pianta che emerge da una terra assetata d’acqua. Soltanto la tenerezza sarà in grado di preservarla dall’inaridimento e dalla desolazione, lasciandole sul corpo impronte di umanità, per la durezza del tempo a venire. E anche noi, spettatori confusi e inermi di questo dramma nel Mediterraneo, saremo forse perdonati per la nostra inadeguatezza e la nostra incertezza, se almeno sapremo costruire ponti e non muri fra popoli e generazioni, con molte bottiglie d’acqua e senza stigmi sociali.
Immagini e pensieri simili giungono dall’isola di Lesbo, l’altro occhio orientale del Mediterraneo. Un tempo è stata terra natale di poeti lirici arcaici, ora è simbolo di una colossale catastrofe umanitaria. Anche quest’isola egea è stata meta di uno dei viaggi papali: un “viaggio triste”, lo ha definito Bergoglio, dove il mare è ormai un cimitero e la terra è un campo profughi, ferita da chilometri di filo spinato. Qui il Papa ha lanciato in mare una corona d’alloro, a ricordo delle molte vittime anonime ora sepolte sul fondo. Anche a Lesbo ci sono molti bambini, e molti ormai orfani del mare.
Dopo quello che ho visto, che voi avete visto, in quel campo rifugiati, c’era da piangere. Ho portato dei disegni per farveli vedere. Che cosa vogliono i bambini? Pace. È vero che nel campo hanno corsi di educazione, ma che cosa hanno visto quei bambini… Ecco un disegno dove si vede un bambino che annega. Questo lo hanno nel cuore, oggi davvero c’era da piangere. Hanno in memoria questo. Uno ha disegnato il sole che piange. Ma se il sole è capace di piangere anche a noi una lacrima ci farà bene.[3]
Piccoli profughi a Lesbo regalano a Francesco molti disegni. Uno di questi, realizzato da un bimbo con una tuta blu, ritrae un sole giallo con raggi di lacrime color sangue, che splende triste su un mare pieno di uomini e barche in naufragio. Il sole vede e piange, partecipando al dolore cosmico di un’umanità che ha perduto ogni cosa. La memoria elementare di questi bambini è già abitata da mare, barche e corpi annegati, e ogni elemento della natura porta con sé le tracce di un’umanità alla deriva. Il sole e il Mare Nostrum sono forse i testimoni e i depositi mnestici più attendibili di ciò che oggi sta drammaticamente accadendo: forse sono anche i luoghi più inondati di lacrime, insieme alle due piccole isole al confine fra i continenti. I bambini se ne sono subito accorti, a est e a sud dell’Europa, invocando padri e madri ormai perduti, disegnano i loro incubi e le loro storie, perché non si spezzi la catena dei viventi.
La depressione endemica delle società benestanti e la nuda disperazione dei popoli deprivati si trovano ora faccia a faccia, lungo le rotte di un’umanità fragilissima e nuda che si salverà soltanto attraverso la tenera disponibilità a portare gli uni i pesi degli altri. Soltanto gesti di tenerezza potranno risarcire – anche se solo in parte – dell’abbandono e della violenza patiti. Per ora ci sono un medico, una bottiglietta e un sole che piange, per dare un nome a un futuro nuovamente possibile.
[1] M. Gualtieri, da Fuoco Centrale e altre poesie per il teatro, Einaudi, Torino, 2003.
[2] M. Mazzucco, la Repubblica, 13 marzo 2016.
[3] Conferenza stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno da Lesbo (Grecia), 16 aprile 2016.
(Continua in libreria…)
Fotografia header: tenerezza guanzini © midivertounmondo



