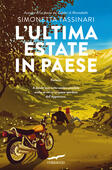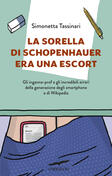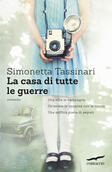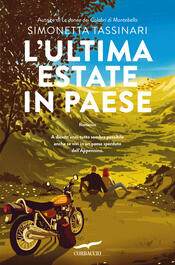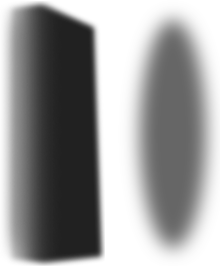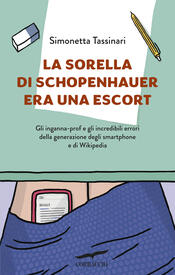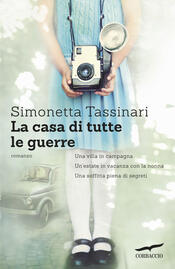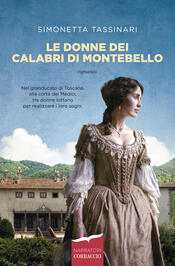C’è un sentimento di cui nessuno ama parlare, tranne quando si tratta di attribuirlo agli altri: l’invidia. Si nega, si trucca, si mimetizza. Eppure, come spiega su ilLibraio.it la scrittrice e filosofa Simonetta Tassinari, “non tutte le invidie vengono per nuocere, e in certi casi possono diventare una bussola emotiva…
Invidia: istruzioni per l’uso (o per il disuso)
C’è un sentimento di cui nessuno ama parlare, tranne quando si tratta di attribuirlo agli altri: l’invidia.
“Non sono invidioso, eh, ma…”, e segue l’elenco delle fortune altrui commentate con un sorriso incerto, come si commenta il collega che, “senza studiare”, ha superato il concorso al primo colpo.
L’invidia è così: non si confessa. Si nega, si trucca, si mimetizza sotto nomi più educati – fastidio, disagio, senso critico – ma è sempre lì, appollaiata sulle spalle, con l’aria di chi osserva e giudica, pur non avendo ricevuto alcun invito.
Tutti, ma proprio tutti, siamo un po’ invidiosi
Iniziamo da qui: tutti, ma proprio tutti, siamo un po’ invidiosi. Non c’è da offendersi. È inutile mettere mano al petto e recitare un “io no”, perché mentiremmo. Anzi, chi dice di non esserlo mai è o santo o bugiardo. O entrambe le cose, il che è un bel paradosso.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
L’invidia è una di quelle passioni umane che resistono a secoli di moralismi, catechismi e aforismi da agenda motivazionale. È ostinata, insidiosa, strisciante. E, soprattutto, è democratica. Non guarda in faccia a nessuno: colpisce il barista e il vincitore di un Pulitzer, la suocera e il manager rampante, la studentessa fuoricorso e la mamma perfetta su Instagram.
L’invidia ha una pessima reputazione
L’invidia ha una pessima reputazione. È una delle passioni tristi per eccellenza, considerata tossica, malevola, persino pericolosa. A nessuno piace essere definito invidioso. È come indossare un cartello al collo: “Non sopporto la tua felicità”. Un po’ come se dicessimo al mondo: “Ti odio perché sei bravo”. Non funziona bene nei rapporti sociali.
Ne ho parlato spesso nei Caffè filosofici, ed è curioso notare come, su questo tema, molti partecipanti si trasformino in osservatori silenziosi più che in oratori appassionati. È il classico argomento da “vedo come va, poi forse intervengo”, come se l’invidia potesse essere contagiosa anche solo a nominarla. Si aspetta che qualcun altro rompa il ghiaccio, magari con una battuta, e poi – solo poi – si azzarda un timido: “A me in genere non capita di provare invidia, però conosco molta gente che…”.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
Ma è inutile negarlo (per l’appunto): a volte ci tocca fare i conti con quella vocina che sussurra: “Perché a lui sì e a me no?”.
L’invidia? Per natura è orizzontale
Non siamo invidiosi del re d’Inghilterra, non di Bill Gates, non dell’ultimo premio Nobel per la fisica. L’invidia non guarda in alto, non punta all’Olimpo: ha lo sguardo basso e laterale. È, per natura, orizzontale. Invidiamo chi ci assomiglia, chi fa le nostre stesse cose, chi ha pressappoco la nostra età e si è laureato un anno prima, ha trovato lavoro un mese dopo, si è sposato con una persona apparentemente simpatica e ha avuto figli di media bellezza ma di ottimo rendimento scolastico.
Aristotele, con la sobrietà greca che non lasciava scampo, l’aveva già capito: il vasaio odia il vasaio. Non l’arconte, non il poeta, non il filosofo. Ma proprio quello che impasta la stessa argilla, nello stesso quartiere. Perché se lui ce la fa, e io no, non è colpa del destino: è colpa mia. O peggio, colpa sua. L’invidia nasce nel confronto tra simili, e cresce come l’edera nei giardini: si avvinghia, si estende, soffoca le piante che prima ci sembravano così promettenti e che ora fioriscono meglio della nostra. È un sentimento esecrato, certo. Nocivo. Tossico.
Le espressioni parlano chiaro: verde d’invidia, roso dall’invidia, livido d’invidia: mai che qualcuno sia roseo d’invidia. L’invidia è considerata un difetto dell’anima, una mancanza, una vergogna da nascondere sotto il tappeto del “figuriamoci se io…”.
Può interessarti anche
Non tutte le invidie vengono per nuocere
Eppure. Eppure bisognerebbe fare una distinzione. Perché non tutte le invidie vengono per nuocere. Ne esistono di diverse gradazioni, di vario peso specifico. Alcune passano in fretta – uno scroll su Instagram, un sospiro, e via. Altre restano lì come un sassolino nella scarpa, e se non le guardi in faccia, diventano rancore. Ma forse, se le si prende per il verso giusto, possono diventare qualcos’altro. C’è un tipo di invidia che non morde, ma stimola. Un’invidia bianca, o per lo meno grigio-perlacea. Un’invidia che non vuole distruggere, ma emulare. Che guarda l’altro e pensa: “Perché non io?” – e poi aggiunge: “Vediamo come posso fare anch’io”. È quella che muove, spinge, fa migliorare. È, in un certo senso, un atto di partecipazione alla vita sociale. Implica attenzione, amor proprio, desiderio di crescere.
Marcel Proust la definiva “un omaggio che la mediocrità rende al talento“. E come ogni omaggio, può avere una sua dignità, purché non scivoli nella vendetta. Shakespeare la chiamava the green-eyed monster: il mostro dagli occhi verdi. E, in effetti, è un mostro strano: non ruggisce, non ringhia, ma ti guarda fisso mentre scorri il profilo LinkedIn di un ex compagno delle medie e ti sussurra: “Davvero è diventato Direttore? Lui che copiava da te il compito di matematica?”.
Il problema dell’invidia non è tanto provarla, quanto non ammetterla. È silenziosa, ma potente: lavora di notte, come le talpe, e può scavare gallerie sotto la nostra autostima fino a farla crollare all’improvviso, in pieno giorno. Dante, che di anatomia morale era maestro, nel Purgatorio immagina gli invidiosi con le palpebre cucite da fil di ferro: occhi che non devono più vedere, perché hanno guardato troppo male. Nondimeno, in una società che ci spinge al confronto continuo – sociale, economico, estetico, relazionale – forse la colpa non è solo dell’occhio, ma anche del sistema ottico in cui siamo immersi.
La Rochefoucauld scriveva: “Raramente l’invidia è tanto ben nascosta da non essere riconoscibile“. In effetti, la sentiamo anche quando è mascherata da giudizio estetico: “Ha pubblicato un libro? Mah, a me non è piaciuto”. Da giudizio morale: “Sì, ma a che prezzo?”. Da ironia forzata: “Eh, beato lui che ha tempo per andare in palestra”.
In certi casi l’invidia è persino un segno di salute interiore
L’invidia è un profumo che resta anche quando l’altro è uscito dalla stanza. Freud, che era capace di trovare desideri nascosti anche in una stretta di mano, l’avrebbe collegata alla percezione di mancanza. L’invidia come sintomo di un vuoto che non si sa nominare, e che prende la forma delle conquiste altrui. Ma forse non serve tutta questa psicoanalisi per riconoscerla. Basta fermarsi un secondo, quando ci pizzica dentro, e dirle: “Ok, ci sei. Ora vediamo se puoi servirmi a qualcosa”. In certi casi, l’invidia è persino un segno di salute interiore: chi invidia ha ancora desideri, aspettative, sogni. L’apatia, quella sì che è preoccupante.
Possiamo dunque imparare a trasformare l’invidia in carburante, in spinta per migliorarci. Basta saperla riconoscere e incanalarla.
Invece di negarla, mettiamola sotto il microscopio:
- Chi invidio, davvero?
- Perché proprio quella persona?
- Cosa dice di me questa invidia?
- Cosa posso fare per colmare quel divario?
L’invidia può essere una bussola emotiva: ci segnala dove stanno le nostre passioni vere, dove batte davvero il nostro cuore. A volte ci fa male perché mette il dito su ciò che non abbiamo il coraggio di inseguire. Ma può anche essere la scintilla che accende un cambiamento.
Consigli non richiesti per convivere con l’invidia
- Ammettila. Non vergognarti. Fa parte della nostra umanità, del fatto che siamo essere sociali e siamo interessati a quel che fanno gli altri. Se riesci a ridere della tua invidia, sei già a metà dell’opera.
- Non nutrirla troppo. Se passi ore a “stalkerare” il profilo di quella persona che ti fa salire il fumo dagli occhi, stai solo aggravando il problema.
- Usala. Chiediti cosa ti rivela su di te. Trasformala in motivazione (non in risentimento).
- Parlane. Confessare a un amico di essere “un po’ invidiosi” a volte scioglie il veleno.
- Non confrontarti compulsivamente. La vita non è una gara. E poi, ognuno ha il proprio percorso, con le proprie tappe e deviazioni.
E se, in fondo in fondo, invece fossimo… anche un po’ orgogliosi dell’invidia?
No, non nel senso di vantarsene al bar (“oggi ho provato una meravigliosa invidia per quel tipo con la Ferrari!”). Ma riconoscerne il valore emotivo, il potenziale di crescita, persino il lato tenero. Perché, in fondo, l’invidia è una forma di amore maldestro per ciò che ci sembra bello, importante, luminoso. Un amore contorto, certo. Ma comunque un amore.
L’invidia può mordere, ma siamo noi a decidere se trasformarla in rabbia o in energia. Quindi, la prossima volta che sentite serpeggiare quel tantino di invidia, non cacciatelo subito via. Ascoltatelo. Potrebbe dirvi qualcosa di molto, molto utile.
E magari strapparvi anche un sorriso.
Verde, sì, ma di consapevolezza.
Fino al punto di farvi guardare qualcuno che ha fatto qualcosa di importante, e pensare: “Bravo. Mi hai fatto un po’ rodere. Ma anche venire voglia di provarci anch’io.”
E, allora, sarà valsa la pena.
L’AUTRICE – Simonetta Tassinari ha insegnato storia e filosofia nei licei e nel Laboratorio di didattica della filosofia dell’Università del Molise. Da anni coltiva la psicologia relazionale, la psicologia dell’età evolutiva, il counseling filosofico e divulga la filosofia tra bambini e ragazzi. Anima partecipati caffè filosofici e tiene conferenze in tutta Italia e all’estero. Collabora con la fondazione Quid+ e con Treccani Futura.
Ha pubblicato romanzi, testi di argomento storico e filosofico (tra gli altri, per Einaudi scuola) e il saggio “brillante” – sull’insegnamento della filosofia nelle scuole – La sorella di Schopenhauer era una escort (Corbaccio). Con Corbaccio ha pubblicato anche Donna Fortuna e i suoi amori, La casa di tutte le guerre, Le donne dei Calabri di Montebello e L’ultima estate in paese.
Per Feltrinelli ha pubblicato nel 2019 Il filosofo che c’è in te; S.O.S. filosofia. Le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita, rivolto agli adolescenti; Il filosofo influencer. Togliersi i paraocchi e pensare con la propria testa (2020); per Gribaudo Instant Filosofia (2020) e Le 40 parole della filosofia (2021) eIl libro rosa della filosofia – Da Aspasia a Luce Irigaray, la storia mai raccontata del pensiero al femminile (2024). Il suo nuovo libro, uscito nel 2025, è Il bello tra le crepe – Manuale di riparazione della vita quotidiana.
Qui i suoi articoli per ilLibraio.it.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it