Nonostante fosse sicuro di non avere una biografia, Giorgio Manganelli ha vissuto: questo ci dicono le sue “Lettere Familiari”. Ha amato, con tenerezza e disperazione. È stato fidanzato, poi marito, padre, fratello e figlio. Ha vissuto, con difficoltà, come un uomo. Scopriamo che è stato un uomo diverso dalla sua immagine, come ogni uomo. Ma non è stato solo questo. Per quanto non volesse esserlo è stato uno scrittore. Le sue lettere ci dicono qualcosa su quale sia, e se ci sia, la differenza tra le due figure, l’uomo e lo scrittore. Se sia maledizione o prodigio, se possa essere una protesta contro l’esistenza o se abbia a che fare col congegno di una fiaba. Ma anche altro: ci dicono quando è necessario inventare una menzogna e crederci, quando dialogare con l’ago che trama la vita, come fare in modo che le parole terrorizzino o scherniscano le regole degli uomini. Ci dicono, soprattutto, che queste Lettere, anche se non sono scritte per noi, non possono fare a meno di essere un’opera dell’autore
“Teppista” della letteratura, “buffone metafisico”, “malinconico tapiro”.
Architetto ateo che costruisce chiese, competente in fatto di cose che non esistono, retore dell’ossimoro, maestro di menzogne e budelli. Uomo esperto di vuoti, di angosce, eroico in grado massimo nella virtù della vigliaccheria, ma uomo scisso tra liturgia e profanazione, dizionario-uomo, umile anglista, professore svagato.
Autore di sillabe che frugano il nulla, il suo frastuono e il suo balbettìo. Addirittura, più spesso rievocato come mammifero che come essere umano.
Molti nomi ha avuto, molte cose è stato, ma anche chi ne conoscesse solo per pochi tratti la figura, tra tutti i prodigi che potrebbe cercare rovistando tra le carte di Giorgio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 – Roma, 28 maggio 1990), tutto si aspetterebbe di trovare tranne il coagularsi del miracolo di una vita.
Si sbaglia. Questo dicono le Lettere Familiari, appena ripubblicate da Nottetempo con un’introduzione di Giorgio Vasta che ne vale bene la riedizione.

A quanto pare Manganelli ha amato, con tenerezza e disperazione. È stato fidanzato, poi marito. E padre, fratello, e figlio, con dolcezza, angoscia o reticenza. Ha provato a insegnare, ha parlato di pioggia e di sole, si è intestardito per questioni di mobilio, ha dato consigli, si è offeso e si è divertito. Ha inventato una fiaba e ha avuto bisogno di un cappotto. Ha avuto problemi all’intestino (“un debordamento di origine colitica”).
Ha consolato, forse ha cercato anche un Dio. Ha dialogato fitto fitto con le forze che intessono il refe di una vita. Con difficoltà, come un umano. Lui che umano non lo sembrava neppure – è diventato istantaneamente di culto l’aneddoto (“Credo, anzi sono sicuro di non avere una biografia. Ci sono solo […] aneddoti”) raccontato dalla figlia Lietta in Aspettando che l’inferno cominci a funzionare sulla sua presunta bruttezza: Manganelli passeggia per Roma con Edoardo Sanguineti e Mario Bortolotto. Si ferma e chiede a bruciapelo a Bortolotto chi è più brutto, se lui o Sanguineti. Questo ci pensa un po’, poi risponde: “cosa c’entra, Edoardo è antropomorfo, tu no”.
Forse non sarà stato bello, fa niente, comunque Manganelli, fosse anche solo per irridere ogni coerenza della sua icona, ha vissuto. Certo, è strano, ma potevamo aspettarcelo. Ma se è vero, ed è vero, come scrive Giorgio Vasta, che le parole che leggiamo in questo libro non sono per noi, che ci aggiriamo tra queste pagine come in una casa che non è fatta per ospitarci, questo è in buona sostanza un danno collaterale.
Il motivo per cui ci riconosciamo nel piglio del ladro, frughiamo cassetti e nostro malgrado ci ritroviamo a vagare di buio in buio, è perché tra quelle pagine non cerchiamo una vita, ma la stessa vertigine data da uno che ha messo le parole a macerare e, imparato a mentire, a quarant’anni e rotti dimentica di star compilando un libro ed esordisce con un’esplosione.
“Non ce l’ho”, una storia, rispondeva a chi lo calunniava chiamandolo scrittore, “sono un’esplosione; questa esplosione è stata un libro – Hilarotragoedia -; prima di questo libro non c’era nulla, solo qualche articolo di letteratura inglese”.
Ladri certo, come non esserlo: l’immagine di Vasta è uno splendido omaggio al più losco degli scrittori, ed è una tentazione troppo dolce per non voler partecipare a questo convitato di pietra; ma ladri perché in cerca di ordigni. Non rimarremo delusi.
E infatti, anche anni prima del suo esordio, anche di fronte al Manganelli ventenne che ci depista nella parte maggiore della raccolta con lettere al miele, anche di fronte a chi non è il futuro Manga, ma ancora Giorgino, Cicciolino, picolino, ciolino, cinaglia, che cerca e fruga una manina, quando cioè – scrive ancora Vasta – è tutto preso dal bisogno di fare “di ogni cosa una cosina”, troviamo lo stesso assassino di parole e il suo falsetto, il suo “mormorio basso e sottile”, sicché quando le parole mettono in moto la loro macchinazione, e proprio mentre si occupa dei suoi panni sporchi, c’è sempre il borborigmo inconfondibile di Manganelli. La parola di uno scrittore.
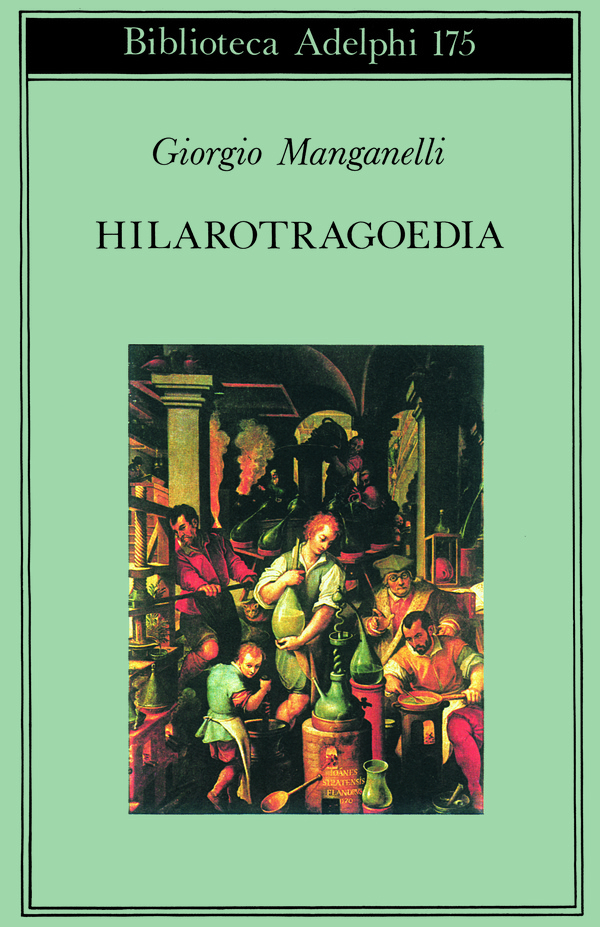
Recriminerebbe. Poteva accettare di essere chiamato scrittore giusto quando definiva una condizione sindacale, perché “l’autore è un sognatore, fondamentalmente; è anche un sognato. Sognato dalle sue parole, che sono i veri sognatori; l’autore è come un loro personaggio, deve recitare il ruolo che gli danno”.
Senonché poche pagine quanto quelle di queste lettere ci spingono a una delle domande più antiche che accompagnano il mistero della letteratura, a cui ogni cultura ha elaborato una risposta diversa. E cioè, se quella di scrittore è una cosa che si fa o che si è.
Qualcosa che si fa: la pratica di un artigiano che fa il suo bel mestiere con le sue tecniche e i suoi strumenti e, quando imbrocca il capolavoro gioca nel campo dell’alchimia: guadagna un’esistenza mentale agli oggetti della natura, cava significati e suoni e leggende come profumi, spreme cose e ne stilla sintagmi, rendendo per dire una rosa davvero una rosa, un lupo, un lupo; ma pur sempre un’attività che può essere compiuta o meno, come andare in banca, fare la spesa, mentre la vita, tiepida, accade. Oppure, se sia, intimamente, non tanto, o non solo, qualcosa che si è, quanto qualcosa che non si può fare a meno di essere. Un’offerta di parole che viene da fuori, da muse o furie, sogni o recessi dell’inconscio, che dettano dentro e non è dato rifiutare. Un gesto fratello dell’ossessione, della nevrosi o della mania. Maledizione o lento delirio: la condizione di chi non può fare a meno di offrire sempre la stessa risposta a un brulichio di domande diverse.
Non ci è dato saperlo. Ma Manganelli sembra suggerirci un’ipotesi di lavoro. E, cioè, che questa pulsione oscura abbia a che fare con una coazione insieme infantile ed eroica, sacra e viscerale, forse quella “merda liturgica e astratta” che per Michele Mari dovrebbe essere messa a divisa di ogni libro del nostro.
Dicevamo, infatti, dei panni sporchi: nelle Lettere è come dire che, tolta la meraviglia di trovarci davanti un Manganelli romantico fino a bambineggiare (lui, l’antiromantico, “l’amore è importante certo, secondo solo allo studio delle lingue straniere”, l’autore de Gli sposi, la più straziata prosa sul disamore non che esista, ma che possa essere anche solo concepita), di un Manganelli inaspettato e commovente, il prete del niente che di fronte al dolore parla della volontà di Dio (lui, che ha compresso l’inferno e la sua cosmogonia nel nero opaco di un intestino), nonostante una lingua che comunica, una lingua orfana di maniera e cerimonie, ritroviamo il nucleo essenziale di quanto è proprio dello scrittore.
Ci sembra, insomma, che sia un uomo che vediamo compiere lo stesso gesto e ascoltare le stesse voci dell’autore di Hilarotragoedia, della Notte, della Palude definitiva, del Nuovo commento. Che tra l’uomo e lo scrittore sia feroce la contiguità. Che il sogno abbia finito per concepire anche l’uomo.
Qualunque cosa scriva, lettere o trattato, Manganelli sta tutto dalla parte del non essere. Scrive a protesta del fatto che possa esistere una geometria, una geografia, una fisica degli oggetti. Che esista l’angoscia e che esistano le vite degli altri. Scrive, e quatto quatto articola a mezzo del linguaggio un sistema di distanze e vicinanze, una sintassi delle cose, che è ulteriore, parallela o antitetica a quella della realtà. Si ristruttura i suoi punti cardinali, si fa la sua gravità, produce una litania che irride e tenacemente sta contro la condizione umana.
Può interessarti anche
Eccolo, qui, nelle lettere alla fidanzata, e poi moglie, balbettare la melassa degli innamorati, dare nuovi nomi alle cose del mondo, come se potesse colmare la distanza fisica (lui è a Milano, lei a Endenna, Bergamo, ma diventa un “punto metafisico”), ma soprattutto emotiva, di un amore che molto semplicemente un amore non è. Fausta dice no, non lo ama, né può amarlo, e allora bisogna aggiungere zucchero alle parole, come se facendolo si potesse innamorare, creare quello che nella vita manca.
Ma, allo stesso tempo, di fronte al disamore, eccolo, congiurarla quella distanza, servirsene, usare il linguaggio come una calcolatrice. Sottrarre una Fausta che scolora e far risultare il mito (“tu, presente e assente, ti muti in immagine, in voce”). Il legame può rarefarsi, si astrae (“mi sembri quasi un mito, una distanza fatta creatura”). Nel silenzio e nella solitudine il fantasma diventa angelo, capace di guarire una vita (“tu mi appari come una portatrice del senso, senso tu stessa di tante cose non intese mai finora”) e, come resto della matematica manganelliana, il linguaggio prolifica come una malattia, si impenna, traffica assenze con bisillabi, scambia fantasmi con favole, cavalieri, elefanti, deduce astrazione da verbi, produce nomi, crea.
Alla fiaba del Giorgissimo, la riposta, che qui non è riportata, è celebre: “Comprato braciole: urge pangrattato”. “Il raccontatore sa che la finzione, la malafede intima, l’ambiguità nulla tolgono alla drammatica intensità delle pene d’amore” – ha scritto altrove – “alla fatalità di un destino tutto recitato e tuttavia vissuto con coerenza, anche se risibile e insensata coerenza”: Manganelli naturalmente sa. Lo vediamo che si fa acre, chiede parole d’amore, conferme, soffre, si intesta ogni colpa, misura il gelo, ma inventa una menzogna e non può non crederci (“fede estrema: fede nella fiaba”).
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Eccolo ancora farsi padre, inventarsi padre, collaudarsi come padre (dice Vasta), provare a colmare diciassette anni di distanza, a distanza.
A leggerne gli scritti nulla sembra più lontano del concetto di famiglia da Manganelli (“la convivenza indefinita, misurata a decenni, di poche persone in breve spazio è innaturale. Si aggiunga che qualcuno sa che qualcun altro lo seppellirà, e lo sa anche l’altro. Fluttua oggi nell’ambiente domestico un sentore di follia”), ma Manganelli è padre e vuole essere padre, ma è padre e ha paura.
Ha paura, per esempio, di avere contagiato la figlia con le sue nevrosi. Il primo posto dove la porta è da Bernhard, il suo psicanalista. Si sdoppia, vuole dare consigli e chiedere notizie, dare un riferimento; accogliere, ma a volte non ce la fa, non sa come fare, non è.
In Aspettando che l’inferno comici a funzionare, in pagine toccanti, vediamo come Lietta quando va trovare il padre, spesso debba fare ritorno senza essere riuscita nemmeno a incontrarlo, dopo aver trascorso la giornata in compagnia di dettagliati programmi su come svolgere la visita come se lui fosse lì.
Manganelli sa chiederne perdono (perché la figlia “ha il genio dell’amore”) e spiegandosi, spiega ogni vita: come ci siano forze che la intessono, e quanto vale, per quel che vale, dialogare con l’ago. Eccolo, poi, modulare vicinanze e distanze nelle lettere al fratello e alla madre. Usare il linguaggio come un elastico. Stringere con il fratello a misurare complicità, a produrre affetto e risate, creare il luogo di confidenze profonde. E invece per la madre, che gli ha camminato sopra, “storpiandolo per sempre”, allontanare, smagliare la trama dei segni, riempire pagine vuote, pagine piene di parole, dire “il silenzio con parole diverse dal silenzio stesso”, produrne il suono, qualcosa di opaco, di denso, una chiacchiera che dice solo non voglio parlare e articola una separazione definitiva.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
Nel punto più alto della raccolta, lo vediamo guardare in faccia la morte nelle stupende lettere alla cognata Angiola, che gli ha chiesto un viatico per la morte di Renzo, il fratello di Manganelli.
Qui siamo di fronte a “un davanzale di verità”. Abbiamo “un’offerta di parole” contro la morte. Si tratta combattere la morte, ghermirla, di fronte a quel fatto che “lacera la viva sintassi della umana conversazione” dire.
Dunque, Manganelli lotta. Nel suo campo non solo combatte, vince: fa il bello e il cattivo tempo con una furia controllata, numinosa, da mostro pio e consacrato. Sulla pagina Manganelli governa e tiranneggia, terrorizza la vita, fa il re che sta sopra le regole degli umani. Scioglie la legge generale che governa l’essere come fosse un trucco da bambinaie. Si sbarazza senza nessuno sforzo del principio di non contraddizione, raduna i contrari e li affratella (“io vorrei poterti sempre parlare e tacere, e parlarti anche tacendo”; “una scomparsa che è intensa come un’apparizione”, “un silenzio che dice tutte le parole”) fino a spettinare ogni sintassi: all’esperienza che abolisce il tempo infonde uno svolgimento (“Renzo non è morto, che fa pensare a una condizione in qualche modo conchiusa, ma in istato attivo di morte”), fa di un addio un punto di incontro, del dolore dolcezza, guadagna la vita dalla morte (“Non ho mai sperimentato una morte così viva e vitale, così sconvolgente ma datrice di vita”), non solo dice l’indicibile, Dio, ma alza la posta: le sue frasi, minuziose, lo descrivono (“Noi non sappiamo cosa significhi questa parola terribile e antica […] possiamo pensarlo come un luogo, l’unico luogo in cui noi tutti siamo da sempre a sempre; noi, i vivi e i morti insieme”).
È il luogo che valica le dimensioni, che ignora il tempo, che è impossibile affollare e impossibile disertare, e nel quale è impossibile perdersi. Quel luogo potrebbe essere un tappeto, una trama infinita di segni, ciascuno dei quali è privo di senso, e che tutti insieme formano quel misterioso disegno, completo e perfetto. Ma fuori, tra le cose, è diverso: Manganelli si confronta con il limite massimo che incontra il linguaggio, tutto ciò che non sa colmare con le sue astuzie. Le sue frasi mormorano una preghiera, la lingua per una volta si svuota di ogni ironia, convoca a sé cose primarie: luce, amore, solitudine; il signore dell’ombra ci lascia un sapore di albe e marine, viaggia in un tempo prima del tempo, quando la morte non conosceva durata e definizione.
Manganelli tratta la vita con il linguaggio. Ammalia ogni angoscia elaborando frasi, trame, figure, congegni che la possano contenere come uno scrigno. Fa della vita segno e opera una ricomposizione a mezzo linguistico, qui stilla miele, lì rende opachi i suoni fino a farli tacere, fabbrica miti, dispensa sospiri. Ma la vita è la vita e le parole sono le parole. C’è dell’eroismo nella sua tecnica, nei suoi prodigi, nella perfezione con cui le parole scintillano ed esplodono, ma c’è anche l’ossessione di uno che è condannato a ripetere sempre la stessa strategia.
Può interessarti anche
Manganelli è troppo intelligente per accettare quieto il gesto che non può fare a meno di compiere: non puoi convertire il disamore in amore con il linguaggio, né accorciare i chilometri, né estorcerlo un amore, non puoi neppure diventare un padre per mezzo di sillabe, nessuna offerta fa smettere la morte di morire, e Manganelli lo sa, ma non può o non sa fare altrimenti che usare i ferri vecchi del suo mestiere, opporre al silenzio lugubre degli oggetti l’aggressione di un fiume di suoni, la musica di una liturgia o un incanto fine a se stesso. Meglio, lo ha sempre saputo. 1953: “Anche scrivere un libro è un atto pratico. Serve per rendere tollerabile l’esistenza, per rinviare il suicidio, per dare al lampione che incontriamo l’apparenza di una donna. Non ci può salvare, perché nulla ci può salvare. È un rito magico, uno scongiuro. Forse all’inferno non si può scrivere”.
Inutilità e splendore, acuta consapevolezza dell’errore e sua viscerale necessità, partoriscono il ghigno e la maledizione del cantore del non essere, del trattatista del nulla, dell’evocatore di fantasmi, di quello fluente in cose che non esistono. Manganelli sa che la letteratura è menzogna, il che è un altro modo di dire che il mondo è un grande dizionario e le parole lo riempiono e lo popolano, ma né lo colmano, né diventano oggetti.
Può interessarti anche
Ma quell’oggetto imperfetto, anzi improbabile, tapiro, mammifero o uomo, che è lui stesso vuole abolirlo, fare spazio, farne “un sobborgo dove l’uccisione ha la stessa struttura del dialogo”. Non può accettare che non sia niente se non budello colmo di parole, che non sia lui stesso il linguaggio (ha scritto ancora Giorgio Vasta, con delicata esattezza, che Manganelli ci guarda “come ci fisserebbe il linguaggio se fosse qualcuno”), il che lo rende, se gli oggetti sono oggetti e le parole parole, scrittore, incesto d’uomo e voce, essere esperto massimamente nell’arte di non salvarsi.
Ha ragione, infatti, Manganelli. L’umile filologo che volesse ricavare una biografia da queste lettere ne rimarrebbe deluso. Di questa non esiste nulla, non sappiamo davvero nulla, abbiamo solo congetture, una vita c’è, un uomo c’è, ne abbiamo davanti una testimonianza, ma non lo conosciamo, né possiamo conoscerlo davvero.
Abbiamo qualche aneddoto. E abbiamo le sue parole. Sappiamo cose sullo scrittore. Sappiamo tutto ciò che è necessario sapere: che, al buio in una stanza che è ogni stanza, uno scrittore è vago di parole da usare contro la vita, losco, votato suo malgrado ad affilarsi il linguaggio, per sempre.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it





