Possono le case, le abitazioni di ogni giorno, essere le vere protagoniste di una storia? Samanta Schweblin, celebre autrice argentina, torna in libreria sette racconti che compongono una vera planimetria dell’animo umano. Un viaggio intimo all’interno di stanze vuote, scatoloni da riempire, camere dentro cui sentirsi compiuti come un racconto – L’approfondimento
Nel celebre incipit cinematografico di Fight Club incontriamo un Edward Norton afflitto da una grave forma di insonnia psicotica. Il suo personaggio ha un modo tutto singolare di presentare il proprio disturbo al pubblico. Se da una parte racconta apertamente le conseguenze nefaste della mancanza di sonno, dall’altra ci porta invece all’interno del suo appartamento. Qui si dilunga in una lista infinita dei mobili Ikea con cui progetta di trasformare la propria casa in (letteralmente) un nido.
Seppur dichiarato in modo implicito, emerge subito un legame molto profondo tra il dolore dei personaggi e le case che abitano; un rapporto che non è mai diretto, cristallino, evidente. Sette case vuote di Samanta Schweblin (SUR, traduzione di di Maria Nicola) è un’orchestra di voci che raccontano, ancora prima dei personaggi, le case che abitano. O sarebbe meglio dire che Sette case vuote è un compendio delle azioni, spesso subliminali, inconsce, represse, oscure, che ogni casa implica ancora prima del semplice abitare?
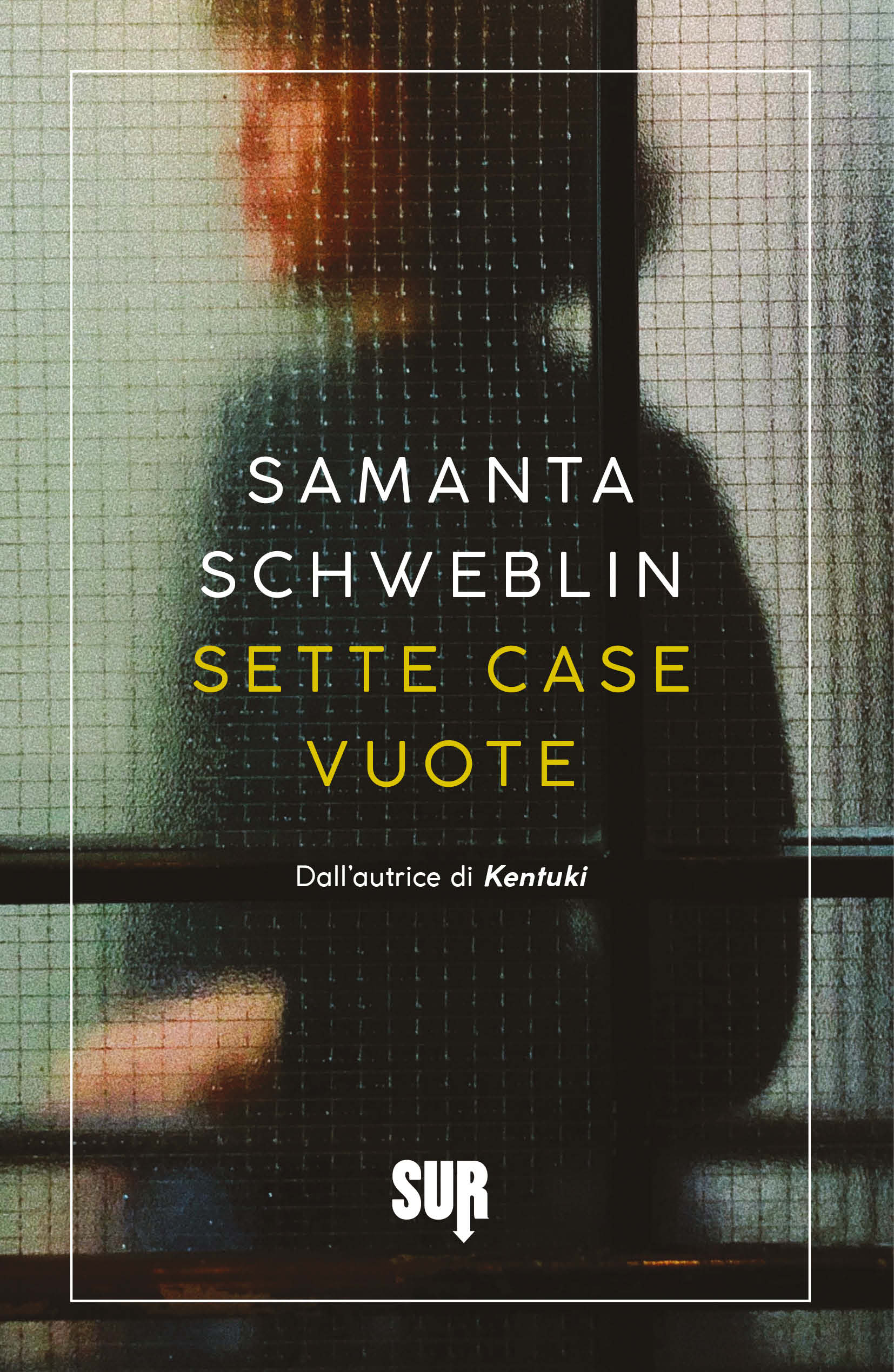
Samanta Schweblin, Sette case vuote
Cercando il significato della parola prossemica sull’Enciclopedia Treccani si può leggere: “parte della semiologia che studia il significato assunto dalla distanza che l’individuo frappone tra sé e gli altri e tra sé e gli oggetti, e quindi, più in generale, il valore attribuito da gruppi sociali […] al modo di porsi nello spazio e al modo di organizzarlo”. La letteratura di Samantha Schweblin è da sempre profondamente incentrata sulla prossemica, come ci conferma tutto il suo lavoro.
Il suo primo romanzo intitolato Distanza di sicurezza (Sur 2020, traduzione di Roberta Bovaia), narra la storia di due madri che vedono nella distanza dai propri figli non solo la più grande certezza, ma anche il più grande pericolo delle proprie esistenze. Prima di questo La pesante valigia di Benavides, raccolta di racconti che le è valso il premio del Fondo Nacional de las Artes, raccoglieva le vicende di personaggi sempre al limite del reale, con toni spiazzanti che hanno situato la sua narrativa sul filone di grandi autori sudamericani come Julio Cortázar e Juan Rulfo.
Può interessarti anche
I racconti di Sette case vuote si distinguono dalle prime opere per una scelta più realista, che porta Samantha Schweblin dal surrealismo di Julio Cortázar alla prosa più netta, tagliente, minimalista di autori americani come Cheever e Carter. Quella prima era la distanza tra le persone diventa qui una distanza da sé stessi, dalla casa che rappresenta il proprio essere-nel-mondo.
I personaggi sono dunque piccolo borghesi, persone per bene, madri e padri di famiglia intenti a compiere gesti quotidiani. A volte invadono case altrui, rubando piccoli oggetti di arredamento. Organizzano scatoloni per un trasloco che non saranno loro stessi a compiere. Si agitano quando, arrivati nella casa delle vacanze, i figli sono misteriosamente scomparsi insieme ai nonni. A volte, molto più semplicemente, escono di casa a notte fonda, con i capelli ancora bagnati dopo la doccia, per prendere una boccata d’aria.
Può interessarti anche
La grande virtù di Schweblin è quella di mostrare che sotto una trama apparentemente semplice di pensieri e movimenti si nasconde, in realtà, un rimosso inamovibile. Ci sono paure invincibili, dolori mai confessati, limiti che non si è mai pensato di valicare.
Non a caso si potrebbe dire che i racconti dell’opera “non finiscono”. Una visione canonica del racconto breve ci insegna che esso deve essere perfetto, chiuso, circolare se comparato alla poliedricità del romanzo. Ma qui la figura geometrica a cui si tende non è certo quella della sfera; è semmai quella della stanza, dello spazio angolare, ricco di sfumature e di giochi di luce.
Può interessarti anche
Proprio come si entra in una stanza, ci saranno cose immediatamente evidenti, altre invece che rimangono ben nascoste negli armadi, oppure opache sotto uno strato di polvere. Più che mai in questa opera ci si avvicina, seppure con le dovute distanze, a un altro maestro tanto del racconto quanto del rimosso: è proprio Stephen King, nella prefazione di A volte ritornano, a rivolgersi al lettore dicendo “C’è qualcosa che ti voglio mostrare, qualcosa che voglio che tu tocchi. È una stanza non lontano da qui, infatti, è vicina quanto la prossima pagina. Partiamo?”.
Può interessarti anche
Fotografia header: GettyEditorial 09-06-2021






