Nel volume “Giusto, sbagliato, dipende. Le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana”, a fornire indicazioni su temi linguistici spinosi, o comunque complessi, sono gli studiosi dell’Accademia della Crusca, istituzione autorevole e popolare, seguitissima sui social e giunta ora alla sua prima pubblicazione ufficiale in libreria, che analizza e chiarisce ogni tipo di dubbio, errore ricorrente, equivoco o falso mito sull’italiano – Su ilLibraio.it un ampio estratto dedicato alle lettere più ostiche dell’alfabeto…
È davvero sbagliato dire ma però? Come va scritto qual è? Attenzionare è un verbo ammissibile? Si dice arancina o arancino? Che cos’è la cazzimma? Su sé stesso l’accento ci va o non ci va? Come si affrontano le questioni di genere nella lingua italiana?
Queste sono sono solo alcune delle centinaia di domande contenute nel volume Giusto, sbagliato, dipende. Le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana, edito da Mondadori e curato dall’Accademia della Crusca, che da secoli è il punto di riferimento per antonomasia su tutto ciò che riguarda la nostra lingua.
Può interessarti anche
A fornire delle indicazioni su temi spinosi, o comunque complessi, è quindi questa istituzione autorevole e popolare, seguitissima sui social e giunta ora alla sua prima pubblicazione ufficiale in libreria.
Grazie ai suoi studiosi, l’Accademia nel volume analizza e chiarisce con la sua ormai celebre semplicità e precisione ogni tipo di dubbio, errore ricorrente, equivoco o falso mito sull’italiano: dal lessico all’etimologia, dalla grammatica alla sintassi, dalla punteggiatura agli inglesismi.
Si tratta dunque di un testo pratico e pieno di curiosità, aneddoti e storia, che pagina dopo pagina fornisce il ritratto di una lingua vitale e in continuo cambiamento, la quale finalmente potrà essere esplorata o ripassata fin nei minimi dettagli.
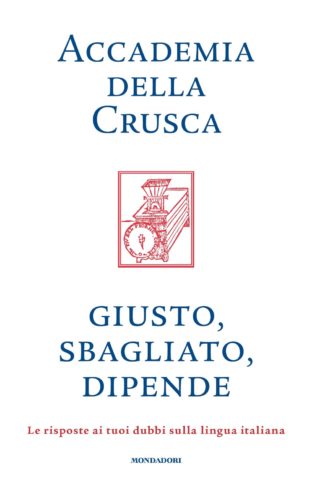
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un estratto dedicato alle lettere più ostiche dell’alfabeto:
H come acca
[…] ► Che cos’è l’hangover?
Il sostantivo hangover, dal verbo (to) hang nel significato di “essere o rimanere in una dubbiosa incertezza; essere dubbioso o indeciso” a cui è stata aggiunta la preposizione over, è un termine di origine angloamericana, la cui prima attestazione risale al 1894 per indicare “una cosa o una persona rimasta o avanzata; un residuo o una sopravvivenza, un effetto collaterale” (Oxford English Dictionary, OED). Già nel 1904, nel Foolish Dictionary di Gideon Wurdz, il termine compare con il significato odierno che evoca “gli spiacevoli effetti collaterali degli stravizi, specialmente alcolici” (OED). La parola hangover è entrata anche in italiano. È registrata, infatti, nel GRADIT (che la ritiene termine specialistico del linguaggio medico) e nel Supplemento 2009 del GDLI (da segnalare, invece, l’assenza nello Zingarelli 2021, nel Devoto-Oli 2021 e nel Vocabolario Treccani) come sostantivo maschile invariabile con il significato pressoché identico a quello inglese: “Effetto postumo di un’eccessiva ingestione di alcool o sedativi”.
A metà degli anni Sessanta, in un articolo del “Corriere della Sera” (Alfredo Todisco, Fanno il bucato in America i nostri panni linguistici, 18 marzo 1965), il termine compare insieme a “centinaia di vocaboli stranieri […] entrati a far parte del nostro idioma”. Difatti, la diffusione di hangover dagli anni Sessanta in poi aumenta considerevolmente, non soltanto in letteratura, ma anche in pubblicazioni scientifiche d’ambito medico.
Nel nuovo millennio, la parola non ha arrestato la sua diffusione. La sua presenza si fa sempre più massiccia nei romanzi e in letteratura, mentre diminuisce nei testi scientifici (e dunque viene meno quella connotazione specialistica che potrebbe aver contribuito inizialmente al suo ingresso nella lingua italiana). Inoltre è attestata anche in ambiti d’uso giovanili, come la musica rap (si segnala la canzone Hangover del 2016 del rapper romano Gemitaiz), e sui social in due diverse costruzioni sintattiche più frequenti “essere/stare in hangover” e “avere un hangover”.
L’italiano ha a disposizione diverse possibilità per esprimere il concetto in questione. Quelle più utilizzate sono “postumi della sbornia” e “postumi della sbronza” (o a volte anche soltanto “postumi” senza specificazione). Si tratta di due espressioni costruite sulla base del sostantivo “postumo” che, specialmente al plurale, significa “disturbo, strascico lasciato da una malattia | estens. conseguenza, ripercussione” (GRADIT). Tra le due possibilità la più diffusa è “postumi della sbornia”. Altre alternative possibili vedono l’aggiunta dei prefissi dopo- o post- ai sostantivi sbornia o sbronza (con grafia univerbata, separata o unita da trattino). L’unico a essere registrato nello Zingarelli 2021 è “doposbornia”, che tuttavia ha poche occorrenze almeno sulla stampa. Concludiamo, infine, la rassegna delle alternative con il possibile recupero di un termine ormai desueto. Si tratta di “spranghetta”, presente già nel Vocabolario toscano dell’arte del disegno di Filippo Baldinucci del 1681 e nel Bacco in Toscana (dalle annotazioni accresciute alla terza edizione del 1691, ma già nell’edizione del 1685) di Francesco Redi: “Quando il vino è gentilissimo, / digeriscesi prestissimo, / e per lui mai non molesta / la spranghetta nella testa”, e poi ripreso da Manzoni nel capitolo XV dei Promessi sposi: “Tra la sorpresa, e il non esser desto bene, e la spranghetta di quel vino che sapete, rimase un momento come incantato”. La voce (propriamente diminutivo di “spranga”, dunque con valore affine a quello di “cerchio alla testa” ovvero “senso di dolore e di pesantezza al capo”, GRADIT), è registrata con questo significato dapprima nella terza edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca e poi nell’Ottocento nel Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini (Milano, Stamperia Reale, 1814) alla voce sfrison: “Spranghetta. Dicesi di dolore nel capo, cagionato da troppo bere vino”. Oggi il termine è presente nel GDLI, nel GRADIT, nel Devoto-Oli 2021 e nello Zingarelli 2021 con il significato di “mal di testa, intontimento causato dall’avere bevuto troppo”, ma etichettato come popolare e disusato. Ed effettivamente le attestazioni negli archivi giornalistici sono piuttosto rare e del tutto assenti in Google Libri.
Può interessarti anche
J come j
[…] ► La o il jihad? Oppure lo jihad? Il o lo jihadista?
A rigore jihad dovrebbe essere maschile, perché tale è in arabo e glielo consente anche il suo traducente italiano più letterale, “sforzo”, o “combattimento”. Ma gli italiani lo usano molto più spesso al femminile (tre a uno il rapporto delle frequenze in rete), legittimato da traducenti altrettanto validi come “lotta”, “prova” e, soprattutto, “guerra santa”. Sulla “Repubblica” nel 2015 la jihad aveva 2571 occorrenze contro i soli 248 esempi al maschile. Forse la preferenza per il femminile è motivata anche dall’incertezza nella scelta dell’articolo che accompagna il maschile di jihad e che si rileva anche per i suoi derivati, jihadismo e jihadista. Poiché la pronuncia del fono iniziale in questo caso è, o dovrebbe essere, assimilata a quella della nostra g palatale sonora (come in “giacimento”), l’articolo dovrebbe normalmente essere il e i al plurale (il jihad, il jihadismo, i jihadisti). E in effetti quest’uso è prevalente. Ma poiché la j si pronuncia anche, nei francesismi non adattati, come una sibilante palatale sonora (fono non presente in italiano ma sì in toscano, come nella pronuncia locale di “stagione”, e in vari dialetti), avvertendo l’anomalia si tende spesso a usare la forma dell’articolo preposta alle iniziali speciali, quindi a dire lo e gli al plurale (lo jihad, lo jihadismo, gli jihadisti). In rete le due soluzioni si fronteggiano quasi alla pari e se i jihadisti sono quasi il triplo dei pur numerosissimi gli jihadisti, e il jihadismo è quasi il doppio di lo jihadismo, lo jihad è attestato più di quattro volte di il jihad. In un libro del sociologo Renzo Guolo – docente di Sociologia delle religioni – dedicato a questo fenomeno, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei (2015), jihad è sempre maschile e in genere è preceduto da il, ma a volte anche da lo, mentre i jiadisti pare meno frequente di gli jihadisti e il jihadismo e lo jihadismo sono più o meno sullo stesso piano. Insomma, anche uno dei massimi esperti della materia, se non ha dubbi sul genere di jihad (maschile), ne ha sull’articolo e quindi sulla pronuncia dell’iniziale. Ma è opportuno orientarsi per il e i al plurale come succede con “jeans”. Quanto al genere, è il caso di sospendere il giudizio, perché la pressione del femminile è forte, non ingiustificata e potrebbe alla fine risultare vincente. Basti pensare che, sulla “Repubblica” del 21 novembre 2015, un articolo dello stesso Renzo Guolo riporta sempre jihad al maschile, ma nel titolo (redazionale) la parola è al femminile, per cui l’articolo comincia parlando dell’“attacco del jihad globale”, annunciato nel titolo come la “sfida della jihad globale”.
► Lo Jedi o il Jedi?
Molte perplessità ha suscitato il titolo italiano, peraltro non modificato neanche nelle recenti riedizioni, dell’Episodio VI della saga di Guerre Stellari, Il ritorno dello Jedi (1983): perché lo e non il Jedi, come il jolly, il jingle, il jack? È molto probabile che nella scelta dell’articolo lo la grafia – e un “aggancio” mentale al tradizionale valore semiconsonantico della j – abbiano prevalso sulla pronuncia reale. Che Jedi (in inglese [dȝεdai]) in italiano sia pronunciato [dȝεdi], con la g di gioco, è una certezza: non si è mai diffusa la pronuncia [jεdi] e neppure [ȝεdi]; ciò nonostante, sembra che l’articolo sia stato scelto proprio considerando la j come semiconsonante: lo Jedi, dunque, come lo yeti, lo iato o la Juventus.
Ormai il titolo è entrato in questa forma nella storia del cinema: una scelta considerabile “d’autore”, seppure anomala, ma che si è comunque affermata tra gli appassionati della serie. Nei film della trilogia originale, peraltro, si può rilevare un uso oscillante dell’articolo, con la scelta che non sempre rimane congrua a quella del titolo. Nel settimo episodio della saga, Il risveglio della Forza, il doppiaggio ha invece optato univocamente per il Jedi/i Jedi, sconfessando, di fatto, la scelta del 1983. Ricercando in rete le sequenze lo Jedi e il Jedi i numeri delle occorrenze non divergono in modo significativo, ma sono comunque a favore della seconda. Nonostante la pressione esercitata dal titolo del film della trilogia originaria, dunque, nell’uso prevale, anche se per poco, l’articolo che un italiano sceglierebbe istintivamente per una parola iniziante per [dȝ] (come “gelo”, “giallo”, “giusto”).
Può interessarti anche
K come k
► Da chi compriamo il kebab? Dal kebabbaro, dal kebabbaio o dal kebabista?
La parola kebabbaro, che indica il “commerciante che prepara e vende kebab” (Devoto-Oli 2018), e ormai molto usata dagli italiani ed e registrata dal 2012/2014 nella maggior parte dei vocabolari. La prima attestazione, secondo lo Zingarelli, risale al 2003 e alcune ricerche effettuate su Internet confermano che la parola e entrata nell’italiano all’inizio del XXI secolo. Attualmente e ancora una parola “instabile”, registra cioè alcune varianti formali: quella più marcata dal punto di vista regionale e kebbabbaro, la quale allude alla pronuncia tipica del romanesco; la variante kebabaro, invece, sembrerebbe una sorta di ipercorrettismo volto a epurare la parola da qualsiasi riferimento regionale, mentre kebbabaro potrebbe nascere da un errore nella resa grafica delle doppie, scambiate di posto. La forma corretta è kebabbaro: alla base kebab e stato aggiunto il suffisso –aro, ovvero la variante non toscana del suffisso –aio, che quando si aggancia a basi straniere terminanti per consonanti ne determina l’intensificazione: “internettaro”, “gossipparo” ecc. Spesso, parlando del kebabbaro, si ha la percezione che l’origine della parola sia romanesca, a causa sia dell’impiego del suffisso –aro, che risulta molto vitale nelle varieta laziali, sia dell’intensificazione della consonante b. In realtà non possiamo assumere con certezza che il conio della parola sia avvenuto a Roma per diversi motivi. Anzitutto per una ragione esterna alla lingua ovvero la storia del kebab in Italia. Il kebab nella sua forma contemporanea (döner Kebab), ovvero il grande spiedino che gira su se stesso e da cui vengono staccati pezzi di carne poi messi all’interno di piadine, panini ecc., nasce in Germania e comincia a diffondersi prima nel Nord Italia e in particolare a Milano e a Torino, che continuano oggi a essere le città con il maggior numero di kebabbari.
Dal punto di vista linguistico occorre precisare che il suffisso –aro dal latino –arius, pur dimostrandosi particolarmente vitale nei dialetti centro-meridionali e soprattutto nel romanesco e nel napoletano – nei quali viene usato anche, e non solo, per indicare i venditori ambulanti di cibo – è presente pure nelle varietà settentrionali (come ad esempio i settentrionalismi “casaro” e “fornaro”, i regionalismi lombardi “postaro”, “tencaro”, quelli piemontesi “malgaro”, “schiavandaro”, “spadonaro”). Nell’ultimo secolo, inoltre, –aro si è svincolato dalla connotazione regionale ed è stato usato in una serie di suffissati che, nati come regionalismi, hanno pian piano assunto connotazioni differenti, diffondendosi su tutto il territorio italiano: “rockettaro”, “gossipparo”, “graffitaro”, “panchinaro” hanno un’accezione ironica, scherzosa, mentre “stiddaro” (“criminale affiliato alla stidda”), “tangentaro”, “mazzettaro”, “treccartaro” hanno assunto una connotazione spregiativa poiché fanno riferimento ad attività illecite e truffaldine. Oggi il suffisso –aro non è più solo una variante non toscana di –aio, ma un suffisso vitale e produttivo della lingua italiana.
Kebabbaro porta con sé sia il significato agentivo di venditore ambulante, sia una connotazione scherzosa e giocosa. Ci sono stati timidi tentativi di conio di derivati da kebab attraverso altri suffissi, che si sono però dimostrati meno fortunati, come kebabbaio o kebabbista, che di solito indica “l’amatore e intenditore di kebab”.
Per estensione spesso kebabbaro finisce per indicare il “locale in cui si preparano e vendono kebab”, nonostante la lingua italiana abbia messo a disposizione un suffissato specifico con –eria ovvero kebabberia, inserito ormai in alcuni dizionari contemporanei.
► Si può parlare di kamikaze in riferimento agli attentatori suicidi?
La voce giapponese kamikaze, che letteralmente significa “vento (kaze) divino (kami)” e che in origine designava “il provvidenziale tifone, che in una notte di agosto del 1281 distrusse la flotta mongola, pronta ad invadere il Giappone” (DELI), fu usata a livello internazionale, verso la fine della Seconda guerra mondiale, per indicare gli aerei nipponici carichi di esplosivo lanciati contro la Marina americana e, per metonimia, i piloti dell’aeronautica militare che li guidavano, i quali appartenevano a un corpo di volontari disposti a morire gettandosi contro l’obiettivo nemico. Il termine, documentato in italiano in questa seconda accezione a partire dal 1944 (al dicembre di quell’anno risale la prima attestazione sul “Corriere della Sera”), avrebbe quindi dovuto avere un valore storico, riferirsi a un designatum ben determinato e irripetibile. Invece il sostantivo invariabile kamikaze ha avuto, purtroppo, una maggiore fortuna. Anzitutto la figura del kamikaze ha assunto un valore prototipico, tanto da essere citata in testi di psicoanalisi. Ma poi il sostantivo è stato usato in altre due accezioni (cfr. GRADIT): in senso esteso, per riferirsi a “chi compie azioni terroristiche o di guerriglia senza possibilità di salvezza” (e in questo caso compare anche in funzione aggettivale), e in senso figurato, per indicare “chi intraprende in modo temerario e avventato un’impresa che comporta un grave pericolo e un danno personale”. Quest’ultimo valore (presente anche in francese) è documentato già all’inizio degli anni Sessanta, ma sempre con riferimento al Giappone, in un testo di Oriana Fallaci (“Per kamikaze non si intendono più i piloti suicidi dell’ultima guerra. Si intendono gli autisti dei taxi che si buttano nel traffico infernale di Tokio invocando l’aiuto di Buddha”, Il sesso inutile. Viaggio intorno alla donna, del 1961); poi, è stato anacronisticamente riferito agli insorti delle Cinque giornate di Milano da Indro Montanelli (“Sfiduciati dalla renitenza dei borghesi, solo alcune centinaia di kamikaze si gettarono nella mischia”, L’Italia del Risorgimento. 1831-1861, del 1972).
Ancora Oriana Fallaci, in un articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” del 29 settembre 2001, dopo l’attentato alle Torri gemelle di New York, scrive: “A me i kamikaze cioè i tipi che si suicidano per ammazzare gli altri sono sempre stati antipatici, incominciando da quelli giapponesi della Seconda guerra mondiale. Non li ho mai considerati Pietri Micca che per bloccar l’arrivo delle truppe nemiche danno fuoco alle polveri e saltano in aria con la cittadella, a Torino. Non li ho mai considerati soldati. E tantomeno li considero martiri o eroi, come […] Arafat me li definì nel 1972”. Può darsi che la presenza della parola nella Fallaci abbia contribuito a diffonderla con riferimento al terrorismo di matrice islamica, ma l’uso del termine in questo senso era iniziato molto prima in alcune attestazioni giornalistiche che risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso. Già in precedenza il termine, virgolettato, figura in un articolo di Alberto Moravia pubblicato sull’“Espresso” nel 1968, dedicato ai conflitti razziali negli Stati Uniti: “Ma gli estremisti del movimento negro sono dei razzisti disperati e decisi ad un genere di lotta spietata che equivale praticamente ad un suicidio collettivo. Sono dei ‘kamikaze’ che accettano volentieri la propria morte purché porti alla morte dei bianchi”.
Insomma, l’uso esteso di kamikaze, per quanto storicamente improprio, sembra ormai radicato in italiano. Certo, come indica il sito della Treccani, un termine alternativo, specificamente riferibile “a un terrorista di matrice islamica che accetta di perdere la vita nell’attentato da lui stesso compiuto”, ci sarebbe: si tratta della voce araba “šahīd (‘martire’, nel senso originario di testimone della fede che si sacrifica per questa)”, voce registrata anche nel GRADIT, nella grafia shahid, datata al 1988. Ma nell’uso giornalistico italiano questo termine, almeno finora, non ha avuto fortuna – anche perché nella cultura occidentale “martire” è connotato troppo positivamente per essere adeguato al giudizio che essa da degli autori di attentati; da parte nostra, non possiamo certo augurarci che ne abbia in futuro.
Può interessarti anche
► Know how: è possibile tradurlo?
Prima di arrivare a proporre una traduzione per una qualsiasi parola inglese che impera nel nostro lessico, si rendono decisive alcune considerazioni preliminari. Se vogliamo, infatti, sottrarci a un simpatico ma infruttuoso gioco di società, dobbiamo fare una “radiografia” dell’anglismo e arrivare a stilare una “prognosi”, fausta o infausta che sia. Il termine know how (di cui si contano milioni di risultati in italiano in Internet) è così definito nel GRADIT: “L’insieme di conoscenze e di esperienze tecniche necessarie per usare correttamente tecnologie, macchinari, impianti industriali e sim. | estens., possesso di specifiche cognizioni che consentono di svolgere in modo ottimale un’attività, una professione ecc.”. Da tale definizione ricaviamo alcune importanti indicazioni: a) si tratta di un termine che veicola una nozione complessa, bisognosa di una lunga perifrasi esplicativa; b) la sua collocazione iniziale e nei linguaggi tecnico-scientifici; c) ha conosciuto, nel frattempo, una diffusione estensiva nella lingua comune con relativa perdita di specificità semantica. Questi tre requisiti sono tutti ostativi all’ipotesi di una traduzione di successo: risulta infatti difficile, se non impossibile, trovare un equivalente italiano che sia in grado, da solo, di sintetizzare il designato nelle sue varie sfaccettature tecniche ma anche non specialistiche. Per un banale principio di economia linguistica, è normale preferire un’unica parola ad ampio spettro semantico piuttosto che dover ricorrere a più parole, ciascuna delle quali copre soltanto una parte del ventaglio di significati.
Va inoltre tenuto presente un altro dato. Il DELI ci dice che know how è diffuso in italiano a partire dal 1955 e che il vettore e stato la stampa periodica. La probabilità di successo di un traducente italiano e legata alla tempestività con cui viene proposto e usato. Se si dà all’anglismo la possibilità di attecchire nella lingua (tanto più nella lingua comune) diventa difficile pensare di poterlo scalzare. Potremmo oggi sensatamente pensare di sostituire con un corrispondente italiano parole come film o sport? La risposta è no. Da tutte queste considerazioni possiamo concludere, per tornare alla metafora iniziale, che il referto della radiografia di know how sancisce una prognosi infausta per qualsiasi ipotesi di traduzione italiana.
Può interessarti anche
W come w
[…]► Webinar: che cos’è, e come potremmo tradurlo?
Si tratta di un seminario interattivo, convegno, conferenza e simili realizzati a distanza attraverso l’uso di strumenti elettronici (computer, tablet, smartphone) e di Internet. I dizionari registrano la parola come sostantivo maschile appartenente all’ambito dell’informatica e del web e indicano come data di prima attestazione il 2007. Tuttavia, solo agli inizi del 2020 il termine ha acquisito un discreto grado di popolarità e abbiamo assistito a un notevole aumento della sua frequenza d’uso. Sebbene webinar possa tradursi letteralmente in seminario web, esso viene impiegato in riferimento anche ad altre tipologie di eventi pubblici – conferenze e convegni, dibattiti, laboratori ecc. – che prevedono un relatore (o più d’uno) e un pubblico che ascolta e ha la possibilità di interagire. Ciò che differenzia un seminario (o simili) da un webinar è la sua realizzazione attraverso l’impiego di strumenti informatici e di Internet che consentono di svolgere tali eventi in diretta ma “in assenza”. Tale proprietà spiega naturalmente come mai nei mesi caratterizzati dalla pandemia da CoViD-19 e dalle misure di distanziamento sociale si sia affermato anche in Italia il webinar (e dunque la parola stessa) come valido strumento per la formazione a distanza, aziendale o accademica, e non solo. Alcuni hanno proposto l’adattamento o l’uso di un traducente italiano con alternative diverse e tutte in buona misura accettabili: seminario web/online/in rete o seminario virtuale, videoseminario o teleseminario, e infine la parola macedonia webinario (web + seminario) che ricalca le soluzioni adottate anche nelle lingue francese e spagnola.
[…] ► Whistleblower: chi è, e come si traduce la parola inglese?
Alla domanda secca “come si traduce in italiano la parola whistleblower?”, una prima essenziale e altrettanto secca risposta è che, al momento, nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano. Uno sguardo ad altre lingue a noi “vicine” rivela che in francese sembrano già diffusi lanceur d’alerte, dénonciateur e informateur, in spagnolo alertador o denunciante, mentre in tedesco sembrerebbe più frequente il ricorso all’anglismo, pur essendo attestata la forma Informant.
Il Gruppo Incipit, attivo presso l’Accademia della Crusca dal 2015, ha invitato tutti i responsabili dell’informazione a sostituire, nell’uso e nelle comunicazioni con il largo pubblico, il termine inglese opaco e di ostica pronuncia whistleblower, letteralmente “soffiatore nel fischietto”, con il più chiaro allertatore civico. Da rilevare che il traducente qui proposto per la lingua italiana gode dell’appoggio del francese lanceur d’alerte e dello spagnolo alertador. Il corrispondente sostantivo astratto whistleblowing potrà a sua volta essere utilmente sostituito da allerta civica. L’allertatore civico è colui che, dopo aver constatato sistematiche irregolarità all’interno dell’organizzazione pubblica o privata per cui lavora, decide di denunciare l’illecito per il bene della collettività.
Può interessarti anche
X come x
► Carta xilografata o xilografica? E non sarebbe meglio silografata o silografica?
La risposta su quale sia la pronuncia da preferire non è univoca e siamo costretti a lasciare aperte tutte e due le strade. Gli strumenti di consultazione disponibili portano entrambe le grafie, con la s‑ e con la x‑ alla greca (le parole italiane non hanno solitamente questo carattere grafico, che infatti italiano non è, ma ricorre solo nei forestierismi, in genere grecismi). Va ricordata l’esistenza di una convenzione lessicografica per cui l’ordine delle forme nel lemma del vocabolario non è indifferente, anzi esprime una graduatoria di valore. La forma posta per prima è considerata preferibile. A volte i vocabolari adottano un’altra soluzione: mettono a lemma entrambe le forme, separatamente, ma poi in una trattano diffusamente la parola, nell’altra si limitano al rinvio all’altro lemma. Se il lemma silografico è presente, ma rinvia a xilografico, e sotto quest’ultima voce stanno la definizione e gli esempi, vuol dire che il lessicografo ha ritenuto migliore tale forma, pur considerando l’altra accettabile. Sono tutti casi in cui il parere del lessicografico viene espresso in maniera silenziosa, ma efficace.
Nell’Ottocento non avevano dubbi sulla questione Niccolò Tommaseo: nel grande dizionario che porta il suo nome (Tommaseo-Bellini), mise a lemma Silografia e Xilografia, allineando entrambe le forme, ma al primo posto stava la parola con la grafia in s-, al secondo quella con la grafia greca x-. Tommaseo avvisava il lettore: “Siccome quella lettera greca traducesi da noi nella S, così la forma qui notata per prima appare più italiana”. La lessicografia dell’Ottocento si è comportata generalmente come Tommaseo, preferendo la forma adattata. Invece la lessicografia di oggi si comporta in modo opposto, e preferisce x-. Un simile problema si pone per altre parole costruite sul greco: xenofobo/senofobo, xenofilia/senofilia, xilografo/silografo, analoghi ai nostri silografico/xilografico e silografato/xilografato, in cui il primo elemento, silo-/xilo-, vuol dire “legno” in greco (xylon), mentre il secondo viene da -grafo, “scrivere”, che si trova in tante altre parole grecizzanti, come tachigrafo, fotografo ecc.
La lessicografia, sia essa moderna o antica, non registra un verbo silografare/xilografare, necessario presupposto di un eventuale participio s(x)ilografato usato in funzione aggettivale. La mancata registrazione nei vocabolari di questo verbo e del relativo participio non significa che la parola non esista: la consultazione dei vari corpora in rete mostra che il verbo circola eccome, e non da pochi anni. Qual è stata la fortuna delle varie forme citate, e qual è la situazione attuale? Dalla rete si ricava che l’uso di xilografato è sempre stato minoritario, e tale resta ancor oggi. Prevale di gran lunga su tutte la forma xilografico con x-, ma non è sempre stato così, perché in altre fasi storiche silografico con s- è stato a sua volta predominante.
Silografare compare nella seconda metà dell’Ottocento in sintagmi come carta silografata, vignetta silografata, fregi silografati, frontespispizio silografato, iniziale silografata, figure silografate. Prevale la forma con s– iniziale, perché in quel periodo l’italiano tendeva all’adattamento fonetico dei forestierismi, anche di quelli di origine greca. L’aggettivo silografico, invece, e più antico. La più remota attestazione reperita e della fine del Settecento; poi il termine ha circolato in maniera consistente nella prima metà del XIX secolo, anche nella forma con la x‑ iniziale.
L’aggettivo silografico/xilografico, nato alla fine del Settecento, deriva dal sostantivo xilografia, anch’esso risalente alla stessa epoca. Xilografia e silografia sono entrati nei dizionari dell’Ottocento, a differenza del verbo xilografare/silografare, che ne e rimasto fuori, così come il participio silografato.
Ci si potrebbe tuttavia porre qualche altra domanda: se xilografia compare solo alla fine del Settecento, ma tale tecnica veniva usata almeno dal Quattrocento per decorare i libri, come se la cavavano coloro che nei secoli passati dovevano nominare tale arte e i suoi prodotti? E, ancora, se esisteva una parola o una serie di parole per denominare altrimenti la xilografia, perché a un certo punto e cambiata la denominazione?
Nella tradizione italiana, la xilografia era più semplicemente e non meno efficacemente indicata con le espressioni “figure in legno” o “stampa di legno” o “stampa in legno”. Basta consultare la voce relativa del Vocabolario toscano dell’arte del disegno di Filippo Baldinucci, del 1681, dove il procedimento di intaglio di queste figure e descritto con grande chiarezza. Non si era dunque fatto ricorso a un grecismo, ma si utilizzavano termini semplici della vita quotidiana e della bottega artigiana. Il termine greco esisteva già, ma circolava altrove, cioè nei libri in lingua latina.
Nel Settecento, quando il primato culturale della Francia ha iniziato a farsi sentire, e stata la lingua francese a far uso del termine greco, trasportandolo nella lingua locale: si cita di solito la registrazione del termine xylographie nel ce lebre Dictionnaire de Trévoux, del 1771, ovviamente più antica delle attestazioni italiane.
Ecco dunque la trafila: nel Settecento la parola greca viene utilizzata in francese, e il francese presto influenza l’italiano, grazie alla posizione di prestigio di cui allora godeva (simile a quella che ha oggi l’inglese). La tecnica dei legni incisi, che era stata per secoli praticata senza necessita di particolati tecnicismi di matrice ipercolta, incomincia a essere indicata in sede tecnica con la parola nuova, e la parola si impone, fino a produrre un aggettivo, che ha fortuna (anche lessicografica), e un verbo, con il suo participio in funzione aggettivale, che ha a sua volta qualche (minor) fortuna, ma non lessicografica.
A proposito dell’incertezza sull’uso di s– o x– iniziale che riguarda tutte queste forme si può affermare che oggi entrambe le opzioni (in s‑ o in x‑) sono accettabili, e pienamente comprensibile e il rifiuto dell’adattamento fonetico, con la conservazione della x alla greca, che sembra dare a questi termini un aspetto più tecnico; forse, anzi, le forme con x devono proprio a ciò la loro fortuna, la quale trova poi conferma e sostegno nel confronto internazionale, perché anche il francese e l’inglese conservano tali grafie.
Può interessarti anche
Y come y
► Chi pratica lo yoga?
Il nome del praticante questa disciplina, yogi, è un prestito dal sanscrito yogin-, attraverso l’hindī yogī e l’angloindiano jogee. Il dubbio riguarda la pronuncia della consonante in attacco della seconda sillaba. Questa consonante in sanscrito è l’occlusiva velare sonora g, come in “gatto”, “goccia”, “gufo”. In italiano la norma ortografica rende la velare g davanti a vocali anteriori con il digramma gh, come in “ghiro”, “aghi”, “ghetto”, mentre la sequenza gi in italiano rappresenta [ʤi], con affricata postalveolare sonora, come in “giro”, “agi”, o [ʤ] se seguita da vocale non anteriore, come in “giacca”, “giorno”, “giusto”. La forma yogi, se si applicano spontaneamente le norme di conversione dall’ortografia alla pronuncia proprie dell’italiano, si legge [‘jɔʤi], con affricata postalveolare; la pronuncia rispettosa dell’etimologia è però [‘jɔgi], con occlusiva velare. La forma è quindi omofona con il nome dell’orso dei cartoni animati di Hanna & Barbera, il cui nome in inglese è scritto Yogi bear, e in italiano “orso Yoghi”, con un adattamento ortografico che invece non si ha, o almeno non sistematicamente, nel nome del praticante dello yoga. Quanto al nome con cui designare una donna che pratica yoga, la voce propria è il prestito dal sanscrito yoginī, e il valore etimologico della consonante traslitterata con g è anche in questo caso [g], ma in Italia è diffusa la pronuncia con [ʤ] come per il maschile. La forma femminile sembra comunque piuttosto rara: manca, ad esempio, nel GRADIT, che indica yogi e tutte le varianti come sostantivo maschile e femminile invariabile. Anche nelle comunità di praticanti è diffuso l’uso di yogi come ambigenere (uno yogi / una yogi).
Può interessarti anche
(continua in libreria…)










