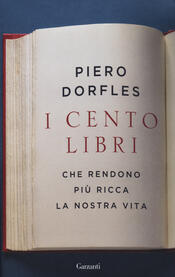Riportando come per incanto a spasso tra il Paese dei Balocchi, Piero Dorfles si interroga su una delle figure più conosciute della letteratura italiana, Pinocchio – Su ilLibraio.it un capitolo dal nuovo saggio del critico letterario
Le palline di zucchero della Fata Turchina. Indagine su Pinocchio (Garzanti) è il nuovo saggio di Piero Dorfles, che si interroga su una delle figure più conosciute e amate della letteratura italiana.
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi è uno dei libri più noti al mondo: ogni anno si aggiungono nuove versioni teatrali, cinematografiche e a fumetti. I protagonisti – da Lucignolo al Grillo Parlante, da Mangiafoco al Gatto e la Volpe – sono entrati nell’immaginario collettivo a simboleggiare vizi e virtù. Ma qual è il segreto del suo successo? Perché il burattino nato dalle mani di Geppetto è diventato così popolare? Dorfles, giornalista e critico letterario da anni protagonista nella trasmissione televisiva Per un pugno di Libri, in questo libro dimostra come, in fondo, non è possibile fare a meno di questo burattino, perché in lui il lettore si immedesima, in quanto è il simbolo della gioventù e dell’incoscienza che ne derivano e che ogni lettore ha vissuto o vive.
Pinocchio è tanto amato perché rappresenta tutto quello che, diventati adulti, può venire rimpianto: l’essere liberi, senza senso del dovere né complessi di colpa. In altre parole, perché è una piccola parte di ciascun lettore, e rappresenta non solo il passato, con ricordi e rimpianti, ma anche il presente e il futuro con le sue aspirazioni e speranze.
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:
(…)
16. Il romanzo di formazione
Babbino mio, […] se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate a traverso! Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca, mi compraste l’Abbecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini, e il burattinajo mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dètte cinque monete d’oro, perché le portassi a voi, ma io trovai il Gatto e la Volpe che mi condussero all’Osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi, e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro; e io via e loro dietro, e io via e loro sempre dietro, e io via, finché mi impiccarono a un ramo della Quercia Grande, dovecché la bella Bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina, e i medici quando m’ebbero visitato, dissero subito: – «Se non è morto, è segno che è sempre vivo» – e allora mi scappò detta una bugia, e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la Volpe e col Gatto a sotterrare le quattro monete d’oro, ché una l’avevo spesa all’Osteria, e il Pappagallo si messe a ridere, e viceversa di duemila monete non trovai più nulla, la quale il Giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri.
Il monologo che Pinocchio sciorina davanti all’incanutito Geppetto nel ventre del Pesce-cane è visibilmente diverso da quelli precedenti. È più connesso, più maturo nell’eloquio, più consapevole della concatenazione degli eventi. Dopo una prima parte, concitata ma realistica, restano nessi incongrui come quel «dovecché» che segue l’impiccagione e precede l’arrivo della carrozzina della Fata, e quel «motivo per cui» che dovrebbe rappresentare la giustificazione logica del passaggio dall’allungamento del naso in casa della Fata al sotterramento delle monete d’oro, e invece rappresenta l’ultima sconnessione di questo terzo e definitivo monologo. Dopo, avremo soltanto il breve percorso, in un solo capitolo, del passaggio dalla perdizione alla redenzione che si verifica dopo il transito purificatore nel ventre del Pesce-cane. Ma la conclusione, pur sgrammaticata, con quel «la quale» che non c’entra nulla, è analitica, potente, matura: il giudice l’ha fatto mettere in prigione «per dare una soddisfazione ai ladri». Qui Pinocchio manifesta una capacità di riflessione che finora non gli avevamo conosciuta; il processo di crescita intellettuale che si sta manifestando è figlio di quanto gli è «andato a traverso», e in questo le avventure, o meglio le disavventure, sono i riti di passaggio che Pinocchio deve superare per arrivare alla conclusione logica della fiaba. «Il burattino passa da un orrore all’altro, prende bastonate sempre più pesanti fino a quando cederà le armi. Tutto questo è il prezzo che bisogna pagare per potersi confondere nella società civile. […] Diventerà un bravo ragazzo solo dopo aver scoperto che il mondo è abitato da truffatori e da giudici che mettono in galera gli innocenti citrulli» [Cerami, 2002, p. xxiv].
Nel monologo «L’arruffìo logico-sintattico mima alla perfezione la tumultuosità fanciullesca dei suoi sentimenti» [Spinazzola, 1997, p. 64], ma compone anche un piccolo capolavoro di riassunto per immagini delle vicende appena trascorse, come nota con una bella similitudine Lavagetto: «Il pericolo, la minaccia, l’inganno, il sotterfugio, i fantasmi, le improvvise apparizioni si succedono come se, ad evocarli, fosse una lanterna magica in cui un operatore frenetico inserisse una diapositiva dietro l’altra» [2003, p. 271]. E infatti la commozione di Pinocchio, quando ritrova Geppetto, è tale che «ci mancò un ette che non cadesse in delirio», e «mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate», prima di gettargli le braccia al collo. Una costruzione linguistica che è il segno di una maturazione emotiva di Pinocchio, e infatti in quest’ultimo monologo «torna la paratassi, che serve a connotare la tachicardia del narratore: è segno della sua commozione» [Lavagetto, cit., p. 270].
La perdita dell’innocenza non passa tanto attraverso una maturazione razionale, quanto piuttosto attraverso l’accumularsi dell’esperienza del carattere ingiusto e contraddittorio della società in cui i grilli parlanti lo vogliono a tutti i costi inserire. Fino all’ingestione da parte del Pesce-cane, Pinocchio subisce gli avvenimenti con la sottomissione di chi non si chiede nemmeno il perché delle cose. È stato «inaccessibile all’esperienza» [Manganelli, 1977, p. 85], attento solo alle sue disordinate pulsioni. Il mondo, tra il reale e il magico, che ha dovuto affrontare, l’ha preso così com’è. Accetta gli imbrogli del Gatto e della Volpe, «due bravissime persone»; non si chiede come mai avendo morso la mano di uno degli assassini gli era capitato di sputare uno zampetto di gatto. Ora, invece, ipotizza che dietro la conclusione giudiziaria della vicenda ci fosse un pensiero, un intento perverso, una stortura istituzionale: dare soddisfazione ai ladri.
Può interessarti anche
Finora Pinocchio, se ha metabolizzato le esperienze, lo ha fatto in base al semplice accumularsi di incidenti e disastri, spesso senza nemmeno prendersene la responsabilità. La sua lenta autocorrezione non si è costruita sulla base dell’accettazione e della verifica dei precetti astratti, che pure tutti gli «aiutanti» non fanno altro che ammannirgli, ma in funzione della graduale assuefazione alla necessità di non sfidare oltre un certo limite le regole della convivenza civile. In questo percorso, però, Pinocchio è sempre autonomo, protagonista, e non succube di adulti e precettori. Il suo sviluppo intellettuale è frutto di una sorta di adattività primitiva, di istintiva accettazione dei recinti entro i quali la sua capacità di provocare l’ambiente è tollerata.
Il burattino della prima fuga, del grillicidio, della vendita dell’abbecedario e dell’ingresso al teatro delle marionette, del seppellimento delle monete d’oro, è un bambino sventato che agisce senza riflettere, che non ha altro progetto che assecondare il senso del piacere, «fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo». Le prove non sono fini a se stesse e, anche se Pinocchio non sembra maturare progressivamente, costituiscono i gradini della scala che lo porta alla conclusione della sua parabola burattinesca. «Un turbine di incontri, pericoli, salvataggi, terrori, pentimenti, tutti però concatenati con l’inevitabilità di una catena genetica» [Fruttero, 2002]. Il Pinocchio che va al Campo dei miracoli, che dorme all’osteria del Gambero rosso è, più che inconsapevole, irriflessivo. Impossibile che non intuisca che sarà imbrogliato, derubato, impiccato. Semplicemente non ne vuole sapere. «Agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai…» argomenta, e si fa una rodomontesca immagine di lui che intimidisce gli assassini, salvo poi dire che, se questi non si dovessero intimidire, sarà lui a darsela a gambe. Pinocchio agisce imbastendo errori e interpretazioni incongrue perché il «mondo mortale degli adulti» [Manganelli, 1977, p. 78] gli è estraneo, incomprensibile, e questo lo fa essere autisticamente isolato nella sua convinzione di potersela cavare malgrado i rischi obiettivi a cui va incontro. Ma contemporaneamente si sta costruendo una personalità, un carattere, anche se infantile. Se anche trovasse gli assassini per strada, non gli darebbero soggezione: «Andrei loro sul viso gridando: “Signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza”». Mitomane, come ogni bambino che si immagina forte di fronte alle prove della vita, vanta a se stesso un’ipotetica, aggressiva durezza che non si sogna di avere, e una «parlantina fatta sul serio».
L’alternarsi di fughe e di penitenziali ritorni è, insieme, il bisogno di essere il ragazzo selvaggio indotto dalla sua indole turbolenta, e la necessità di sottomettersi alla normalità che gli permette di avere di che nutrirsi e di non essere impiccato. Alle fughe seguono i pentimenti, che però non impediscono il ripetersi delle «scapataggini». Nella notte della catinellata: «Eppure il Grillo-parlante aveva ragione». Dopo la scappatella al teatro delle marionette: «Babbo mio, salvatemi!». Dopo l’impiccagione e la guarigione, in un momento di autocoscienza, ammette: «Noi ragazzi siamo tutti così. Abbiamo più paura delle medicine che del male». Non conosciamo i suoi pensieri durante la lunga carcerazione, ma alla liberazione riflette: «Quante disgrazie mi sono accadute! E me le merito, perché […] voglio far sempre tutte le cose a modo mio». Nella sua cuccia di cane da guardia, per l’ennesima volta, si pente: «Mi sta bene! Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo; ho voluto dar retta ai cattivi compagni […]. Ma ormai è tardi, e ci vuol pazienza». Di lì a poco farà, per la prima volta, non il ragazzo perbene, ma il cane perbene [De Rienzo, 2009, p. 134], denunciando le faine ma senza infangare la memoria del cane corrotto. Davanti al sepolcro della Fata recrimina: «Perché […] non sono morto io, che sono tanto cattivo». E, diagnosticata la febbre del somaro, si strugge: «Io sono un burattino senza giudizio… e senza cuore. Oh, se avessi avuto un zinzino di cuore, non avrei abbandonato quella buona Fata». Poiché sappiamo che la redenzione non può arrivare che con una prova finale, sono pentimenti oltreché tardivi, inutili. Dice De Rienzo, citando Santucci, che qui Collodi «recita un catechismo di avvedutezza borghese», posato «ma scialbo e triste» [ivi, p. 131].
Quando, arenato sulla battigia dell’isola delle Api industriose, chiede ragguagli a un cortese Delfino, è consapevole ormai che il mondo può essere molto crudele, e si informa: «Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest’isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare, senza pericolo d’esser mangiati?». Dopo l’esperienza delle imbarazzanti crescite di naso, dovendosi presentare, si descrive come «il figliolo più cattivo che si possa dare». Un primo barlume di autocoscienza, segno di maturità incipiente; ma Pinocchio non è ancora maturato tanto da accettare l’idea che per mangiare si debba dare qualcosa in cambio, e infatti di fronte al fatto che nell’isola «non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino», intuisce che «questo paese non è fatto per me. Io non son nato per lavorare». Ci vuole tutta la pazienza della Fata-mamma per mandarlo a scuola, mentre lui ammette: «A me la scuola mi fa venire i dolori di corpo». Ma ancora una volta scappa, per vedere il Pesce-cane, e lo vediamo mentre piange su quello che crede essere il cadavere di Eugenio: «Oh, quant’era meglio, mille volte meglio ch’io fossi andato a scuola! […] Ma io sono un testardo, un caparbiaccio: lascio dir tutti, e poi fo sempre a modo mio». Poi l’arresto, la fuga, e quando rischia di finire nella padella del pescatore verde, ripete: «Quant’era meglio, che fossi andato a scuola!… Ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago!». Dopo il ritorno, funestato dalla lentezza esasperante della governante-Lumaca e dalla beffa della cena-natura morta, proprio quando sta per diventare un ragazzino, fugge al Paese dei balocchi. Inciuchito, di fronte a una magra cena a base di paglia, si pente ancora: «Ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare! […] Pazienza!». Ingoiato dal Pesce-cane, dovrà finalmente fare i conti con una situazione dalla quale non si esce se non con la riflessione. Preso sulle spalle il padre incanutito, come fosse un nuovo Enea, sia pure aiutato dal servizievole Tonno, arriva alla capanna, messa a disposizione dal Grillo-parlante, al quale l’ha provvidenzialmente regalata la capra-Fata turchina e, messosi a lavorare e a studiare di buona lena, va incontro alla fatale metamorfosi conclusiva.
Può interessarti anche
Man mano che Pinocchio matura, maturano con lui i personaggi che ha intorno. Geppetto, da padre-falegname, che il burattino se lo voleva costruire, strumentalmente, solo per «buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino», diventa un padre affettuoso, che per lui si toglie il pane (le pere) di bocca, disposto a traversare l’oceano in una barchetta a remi per ritrovare il burattino-figlio finché, alla fine, diventa l’abile intagliatore che avrebbe potuto essere fin dall’inizio, se non fosse che così non vi sarebbero state la crescita e la maturazione del personaggio che accompagnano quelle di Pinocchio. La Fata, nel suo complesso sviluppo, mantiene intatto solo il color turchino e la sua natura ultraterrena. Da morta a viva, da bambina a sorella, di nuovo morta e di nuovo viva, da sorella a madre, da madre a spettatrice del circo con apposito medaglione con il ritratto di Pinocchio, a mandante – in absentia – dei pesci che mangiano la pelle d’asino del burattino, a buona donnina con le brocche d’acqua, a capretta, ad anziana sofferente all’ospedale, almeno a sentire le pietose bugie della Lumaca, di nuovo capretta che cede al Grillo la capanna in cui Pinocchio e Geppetto trovano riparo, fino ad apparizione nel sogno e autrice di un biglietto di ringraziamento nel finale. Cambia anche lei, malgrado la sua sostanza soprannaturale, perché anche qui il processo di sviluppo formativo del burattino deve essere accompagnato dalla formazione dei coprotagonisti e degli aiutanti. Come si trasforma la Fata, così «anche Pinocchio, giunto sotto il segno della Regina delle Metamorfosi, deve trasformarsi» [Citati, 1979, p. 212]. Persino il Grillo-parlante, che nasce come uggioso abitante della stanzuccia terrena del quarto capitolo, dopo una breve apparizione sotto forma di fantasma non solo resuscita, ma diventa medico e, alla conclusione delle Avventure, l’affittacamere della nuova residenza della famiglia pinocchiesca. Ma il processo fondamentale di trasformazione avviene con il transito nel Pesce-cane e con il monologo col quale Pinocchio riassume all’incanutito Geppetto le disgrazie che gli «son piovute sul capo». «Quando padre e figlio si incontrano nel ventre del Pescecane è, si può dire, terminato il ciclo della perdizione» [Bargellini, 1942, p. 54]. E anche per Garroni «è qui che Pinocchio prende per la prima volta il sopravvento, diventa “uomo”, decide, opera, da bambino colpevole d’essere nato si fa padre di suo padre» [1975, p. 122].
Nell’ultimo monologo, nello stomaco del Pesce-cane, centrale è il fatto che Pinocchio riconosca che il Gatto e la Volpe non sono «due persone molto perbene», come aveva detto nel secondo monologo, e capisca che ad Acchiappa-citrulli le istituzioni sono dalla parte dei ladri. «Nell’interno del mitico mostro […] Pinocchio comincia a cambiare e a “crescere”» [Servadio, 1976, p. 577]. È in atto un rovesciamento, nel quale le prospettive sbagliate avute fin qui si capovolgono, e tutti i protagonisti delle Avventure rivelano pienamente la loro natura, grottesca se non patetica. Nella nuova prospettiva, il Gatto e la Volpe sono poveri vergognosi, gli orchi sono scherzi del destino facilmente evitabili, finire inciuchiti è un incidente da cancellare e la fuga dal Pesce-cane l’unico atto di resurrezione in grado di produrre l’inversione della visuale, come un binocolo inforcato alla rovescia. Si parva licet, è un processo formativo comune a molti grandi libri, a cominciare dal Don Chisciotte che, rinsavendo, in fin di vita, riconosce la costruzione falsata delle sue fantasie cavalleresche. Succede ad Alice, in particolare nel Viaggio attraverso lo specchio, che conclude le sue avventure con un riordinarsi del mazzo di carte che nella storia sono i sudditi della Regina di cuori e un ricomporsi del giusto ordine delle cose.
A ben vedere, è possibile trovare punti di contatto con il finale delle Avventure anche in diversi altri classici della letteratura. L’inversione di prospettiva, la metabolizzazione delle esperienze che il protagonista ha acquisito nello scorrere del tempo, è il meccanismo che porta alla conclusione della Coscienza di Zeno, quando l’eterno immaturo e irresoluto protagonista si rende conto di essere diventato, lui, il personaggio solido della famiglia e assume il ruolo dell’adulto responsabile, dopo aver passato la vita a cercare di fare i conti con la propria inettitudine e il ricordo di un padre anaffettivo. Ci sono molti altri esempi, ma tentiamo un passo ancora più ardito e rintracciamo un parallelismo nel Tempo ritrovato quando, nell’ultimo volume, i personaggi della Recherche appaiono come ridimensionati dal tempo e dall’esperienza e cambiano quasi magicamente polarità, svelando la vera sostanza di quella sorta di teatrino patetico nel quale Marcel si rende conto di esser stato rinchiuso fino a quel momento. Come in un sogno, ora che la giusta prospettiva si è stabilita, ha finalmente la capacità di scriverne da protagonista invece che da vittima. Così, se me lo si concede, Pinocchio nel finale: smascherate le mascherine, non è più l’oggetto, ma il protagonista e il dominus del racconto.
Collodi, è noto, ripudiava il finale dolciastro del libro e affettava di non ricordare nemmeno di averlo scritto: «Sarà, ma io non ho memoria d’aver finito a questo modo», pare dicesse [Bargellini, 1942, p. 58]. Paolo Poli, indimenticabile lettore delle Avventure, sostiene che l’editing del romanzo, che veniva pubblicato a puntate sul «Giornalino della domenica», lo faceva Emma Perodi, una novellista, che era intervenuta sulla conclusione e si era preoccupata di inserire il lieto fine nel racconto [Poli, 2015, p. 12]. Può essere, anche se il Bargellini sostiene invece che sia stato Felice Paggi, il libraio-editore che per primo l’ha pubblicato in volume, a farlo inserire da un suo redattore: «Non è improbabile che il sor Felice, un editore di libri tutti con la morale, facesse introdurre da Guido Biagi quella glossa» [1942, p. 58]. Il fatto è che il libro non poteva non finire così, pena il tradimento del percorso che, ancora una volta forse senza volerlo, Collodi ha descritto. «Lorenzini sa benissimo che non si può discutere la conclusione della vicenda, […] e che cosa poteva consigliare a un bimbo un uomo dell’Ottocento, se non diventare studioso, attivo, insomma “perbene”?» [Marcheschi, 1995, p. xlviii]. Certo, è così, ma non credo fosse soltanto uno scrupolo pedagogico: è la struttura narrativa delle Avventure che porta, lentamente, verso la fatale conclusione. «La metamorfosi non è un evento che accade d’improvviso a conclusione del racconto, ma un percorso che precede l’avvio e si sviluppa fin dal principio della narrazione» [Gagliano, 2012, p. 100]. Un lento passaggio, dal progetto di fuga e di libertà elaborato davanti al Grillo-parlante nelle prime pagine fino all’accettazione, consapevole e inevitabile, del principio di realtà nel momento in cui, diventato padre di suo padre, Pinocchio salva dal Pesce-cane Geppetto, si mette a lavorare di lena e merita la trasformazione in bravo ragazzo. Malgrado l’autore, è costretto a metter da parte l’attrazione per la libertà e a diventare un essere umano serio e posato. «Il prezzo che paga è quello della spensieratezza in cambio della responsabilità» [Incisa, 2004, p. 128]. Quando le esperienze si sono accumulate, quando si acquista coscienza di sé, sopravviene la dolorosa scoperta di essere parte di un mondo regolato, che non si può rifiutare; e, a ripensarli, i bambini che si è stati, con la fiducia in un mondo meraviglioso in cui tutto è concesso, sembrano distanti, ridicoli, insignificanti, privi di sostanza, come il «grosso burattino […] con le gambe incrocicchiate» appare a Pinocchio.
Può interessarti anche
Ma c’è ancora un altro risvolto, un progetto intrinseco alle Avventure, sgorgato dalla penna inconsapevole dell’autore, che fa del libro un vero romanzo di formazione. «La “bambinata” collodiana si inserisce con originalità nel grande filone del Bildungsroman borghese ottocentesco» [Spinazzola, 1997, p. 55]. Ripensando al processo formativo che porta il burattino da un’infanzia sventata a una posata maturità, val la pena richiamare un passaggio delle Avventure che può avere un significato più profondo di quanto, a prima vista, non sembri. C’è chi ha notato l’incongruenza del fatto che il burattino, che non è mai stato a scuola, è invece capace di leggere l’epitaffio sulla lapide che ricorda la Bambina dai capelli turchini, sedicente morta perché abbandonata dal suo Pinocchio. In effetti non abbiamo notizia del fatto che ci sia stato, tra una sventatezza e l’altra, un processo di alfabetizzazione. C’è stata, sì, una stasi del racconto: quella dei quattro mesi passati in galera tra i malandrini, colpevole di essere stato derubato. Possiamo ipotizzare che nelle carceri ottocentesche ci fossero dei corsi di recupero per analfabeti, come accade oggi, anche se pare poco plausibile. Probabilmente è una delle caratteristiche incongruenze di cui sono intessuti i racconti fiabeschi, ma resta il fatto che esiste un prima, in cui Pinocchio non sa leggere, e un dopo in cui è in grado di farlo.
Nelle pagine finali, Collodi ci dice che Pinocchio, nelle veglie della sera, «si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro, al quale mancavano il frontespizio e l’indice». E si serviva per scrivere di «un fuscello temperato a uso penna» e di sugo di more come inchiostro. Si esercitava, perché durante il soggiorno nel paese delle Api industriose, ospite della Fata, era andato a scuola con profitto e «il maestro se ne lodava». È qui, nell’essersi impadronito degli strumenti necessari per aprirsi al pensiero astratto e alla funzione ordinatrice della scrittura, che Pinocchio certifica il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e il raggiungimento dell’equilibrio che è proprio dei cosiddetti ragazzi perbene. «L’ammissione al mondo della normale ragionevolezza passa dunque necessariamente per l’apprendimento del leggere e dello scrivere» [Lanza, 1997, p. 233]. È nella nascita di una consapevolezza di sé che permette di uscire dallo stato di natura, e di raggiungere la capacità di appropriazione degli elementi culturali dell’esperienza, che Pinocchio abbandona la sua condizione di burattino. Solo gli uomini leggono e scrivono. Qui, volente o nolente, Pinocchio è diventato un essere senziente, si è inumanato, e ha acquistato il pensiero simbolico.
«Com’ero buffo quand’ero burattino!» Quelle che Pinocchio pronuncia alla conclusione del libro sono «Le prime parole che pronuncia a se stesso» [Cerami, 2002, p. xxvi]. È la prima volta, nel racconto, in cui Pinocchio si osserva con occhio analitico, e nel momento in cui prende coscienza della propria individualità e della separazione definitiva dall’irresponsabilità infantile, ecco che si profila la nascita dell’Io, e del principio di realtà. E con la fine del libro si conclude anche, logicamente, il processo di formazione che ne è la sostanza ultima.
(continua in libreria…)