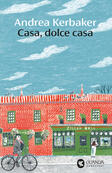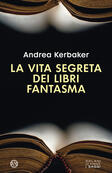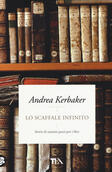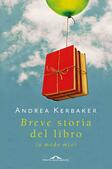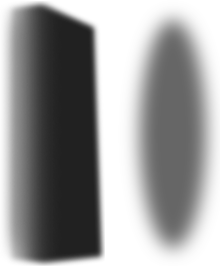C’è la possibilità di guarire dal morbo della vecchiaia? O bisogna fuggire? Il signor Coleridge, protagonista di “Casa, dolce casa” decide di fuggire e, nel farlo, incappa in una serie di avventure imprevedibili e di incontri esilaranti. Strizzando l’occhio a una lunga tradizione di “anziani in fuga”, Andrea Kerbaker tesse le fila del romanzo utilizzando la seconda persona, un azzardo, forse, ma che gli permette di affrontare con un certo vantaggio una situazione archetipica della letteratura, quindi anche in questo caso una situazione a rischio: la vecchiaia, il diario degli ultimi giorni…
Il romanzo in seconda persona, per intenderci dove il narratore considera un “tu” il protagonista, è ritenuto generamene difficile, spesso sconsigliato dai manuali di scrittura perché pone problemi di intreccio, anzi, di come organizzarsi strutturalmente; e sui risultati, chissà.
È un azzardo. Se ne contano così relativamente pochi, i più noti e celebrati dei quali sono per esempio Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino e Le mille luci di New York di Jay McInerney.
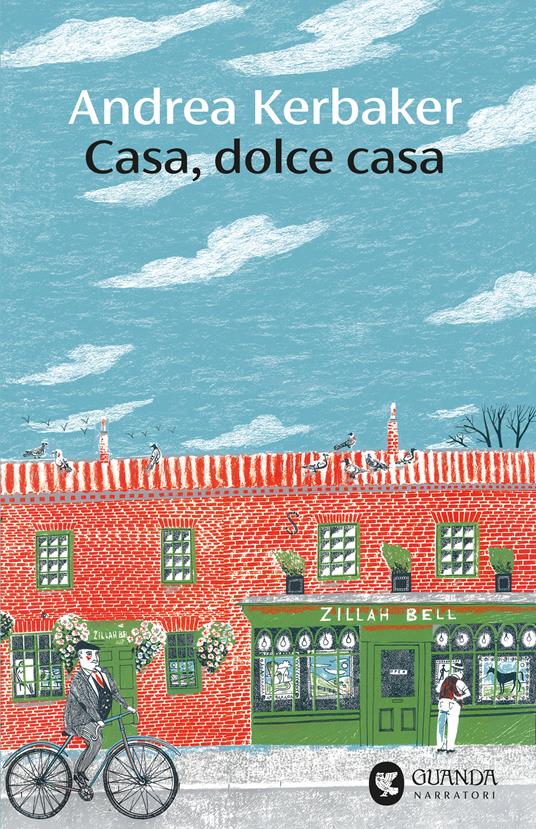
Andrea Kerbaker, bibliofilo appassionato, lettore altrettanto famelico e naturalmente scrittore in proprio, ha deciso di scalare questa montagna correndo tutti i rischi del caso: e in Casa, dolce casa – nulla a che vedere con la sua Kasa dei libri dove raccoglie le collezioni e organizza eventi, fra Milano e Angera – dimostra con la solita grazia che l’impresa è, ovviamente, sempre possibile. Si direbbe anzi che l’uso d’un tale punto di vista narrativo gli abbia consentito di affrontare con un certo vantaggio una situazione archetipica della letteratura, quindi anche in questo caso una situazione a rischio: la vecchiaia, il diario degli ultimi giorni o mesi o anni.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
Il Tu, il protagonista, è infatti un anziano dal cognome piuttosto evocativo, Coleridge (di nome fa più prosaicamente George, ma forse è leggibile un’allusione alla Ballata del vecchio marinaio?) in una residenza inglese, lussuosa e confortevole, dalla quale però decide di fuggire. Ci riesce al secondo tentativo, nonostante gli acciacchi e le difficoltà motorie (ma le scopriremo strada facendo), salta su un bus e va nel villaggio dov’era casa sua, con le chiavi in tasca e la ferma intenzione di riprendere la vita di sempre, lontano da quella “prigione dorata”. Troverà, però, una situazione decisamente cambiata rispetto al suo ricordo, scoprirà che si può fuggire sì, ma che indietro non si torna.
Può interessarti anche
Il signor Coleridge non ha alle spalle la funesta uccisione dell’albatros da parte del vecchio marinaio, che ha perduto la ciurma della sua nave e consegnato lui a uno stato incerto tra vita e morte; è stato un uomo di successo e se ne è anche compiaciuto a suo tempo; è (all’apparenza) lucido e spiritoso, salvo il fastidio piuttosto comune di non riuscire a ricordare certi nomi.
Rimpiange con tenerezza la moglie morta e le di lei risate quando scoprì, per esempio, il romanzo di un esordiente inglese figlio di un autore celebre per aver scritto Lucky Jim. Chi è? Kerbaker, da uomo di libri, si diverte con questi indovinelli (che ormai si risolvono agevolmente con Google, si direbbe purtroppo), come del resto quello sullo “scrittore cecoslovacco” che al protagonista ricorda la sua stessa situazione, di essere sotto indagine e non sapere perché.
In realtà il signor Coleridge ha perduto in gran parte la memoria a breve e medio termine, e proprio questo fa sì che non solo abbia dimenticato il nome di qualche scrittore, ma provi una sensazione di abbandono e solitudine. La realtà è diversa, ma questo lo scoprirà un po’ incredulo e non del tutto convinto solo nel villaggio dove quella che considera casa sua appartiene ormai ad altri, e finalmente le figlie e un amico lo riacciufferanno. Eppure ancora una volta riuscirà a fuggire, per quale meta il libro non dice, concludendosi con la reiterata ripetizione, tre volte, della parola “via”.
Kerbaker sembra qui proporci un riferimento abbastanza preciso a un classico sì, ma nel suo fatale momento biografico: ovvero la fuga di Tolstoj, ottantaduenne e forse malato da Jasnaja Poljana, la notte del 27 ottobre del 1910. Tolstoj fugge da una situazione di disagio non solo famigliare ma esistenziale, in treno, senza una meta. Dopo 5 giorni arriva alla stazione di Astapovo, che è ben presente in Anna Karenina, deve fermarsi, è in condizioni disperate, muore non senza che i suoi amici, i medici, i figli stessi facciano in tempo a raggiungerlo.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
Ogni anziano in fuga da qualcosa che lo angoscia pur non essendogli del tutto chiaro ripete nella letteratura il gesto dello scrittore russo: si pensi all’Hemingway di Il vecchio e il mare o al nostro Starnone di Il vecchio e il male, a Paul Auster e persino a un bestseller di qualche anno fa dello svedese Jonas Jonasson, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, pur divertente – con una componente di thriller.
Ma anche, perché no, a quel delizioso (e terribile se pure con una sorta i lieto fine) Piovevano uccelli della canadese Jocelyne Saucier. O ancora a un piccolo classico come Le nostre anime di notte, di Kent Haruf. Sono libri che investigano il territorio piuttosto malcerto dell’autodeterminazione.
Il tema può ovviamente arricchirsi di volta con variazioni d’autore, ma quello resta: la fuga, il “via” tra disperato e liberatorio, tra terrificato e gioioso che per esempio ci ha raccontato Lawrence Stern nel Tristram Shandy, quando il protagonista si abbandona a una corsa furibonda in Francia, cambiando carrozze come un fuggiasco, appunto, e a tutta velocità; perché si sente inseguito dalla morte e ha deciso però che la farà “ballare come nemmeno si figura, perché galopperò (…) senza mai voltarmi indietro fin sulle sponde della Garonna; e se udrò il suo acciottolio alle mie calcagna, scapperò sul Vesuvio, e da lì a Giaffa, e da Giaffa in capo al mondo; e se mi segue fin là, pregherò Dio che le faccia rompere l’osso del collo”.
Il signor Coleridge è meno guascone, e soprattutto, è molto più anziano. In ogni caso non sospetta di avere alle spalle un’infinita genealogia, come invece sa benissimo Kerbaker: che pone in esergo al romanzo una citazione di Publio Terenzio Afro, senectus ipsa est morbus.
C’è la possibilità di guarire, o bisogna arrendersi a una condizione inevitabile di malattia e privazione? C’è la possibilità, davvero, di fuggire? Il signor Coleridge, nella sua pur misurata reazione al morbo della vecchiaia, ci prova comunque. Lo soccorre, forse in qualche modo lo salva, una lieve ironia, qualcosa di amabilmente spiritoso che è peraltro una caratteristica tipica del suo autore, e della sua cifra stilistica.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it