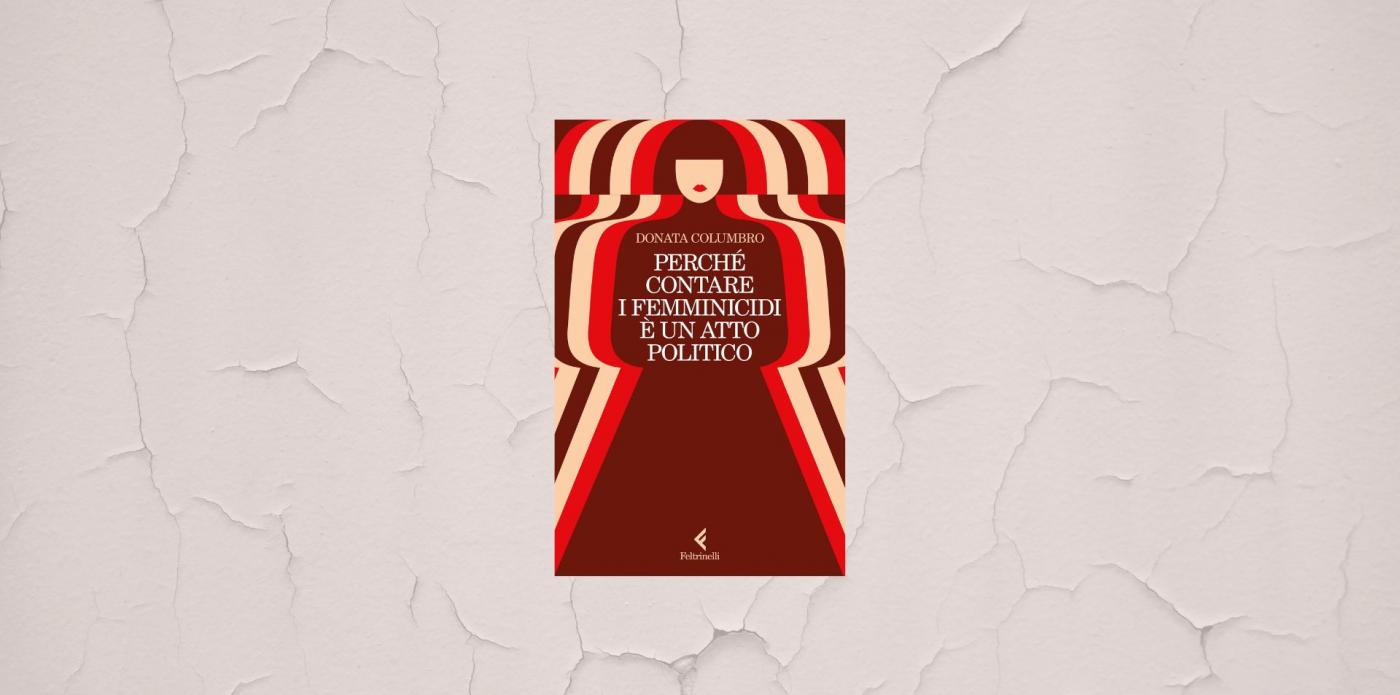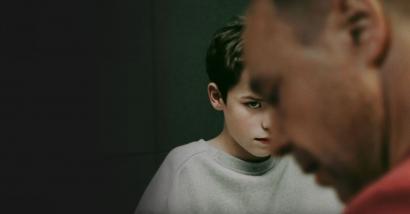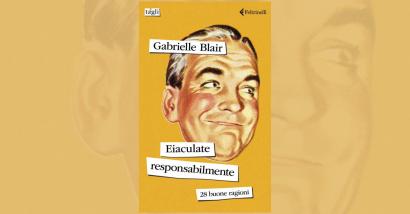Giornalista, scrittrice e divulgatrice, Donata Columbro lavora da anni sul rapporto tra dati e società. Nel suo nuovo saggio, “Perché contare i femminicidi è un atto politico”, affronta un tema cruciale e spesso trascurato. L’abbiamo intervistata per parlare di come i dati non siano mai neutri, perché la loro raccolta dipende da corpi e prospettive, e di come storie e statistiche, insieme, possano diventare strumenti di indagine e prevenzione della violenza di genere: “L’atto politico consiste nell’intervenire sulle fondamenta… capire quali sono i punti critici, sistematizzare le informazioni, destinare risorse e valutare se gli interventi funzionano. È un atto pratico che non lascia spazio alla propaganda”
La parola femminicidio compare sempre più spesso tra le pagine di giornali e negli altri mezzi di informazione. La definizione di femminicidio e i criteri con cui vengono contati questi omicidi, però, restano spesso poco chiari e raramente approfonditi.
L’analisi del fenomeno (essenziale per comprenderlo e prevenirlo) è molte volte assente nel discorso pubblico sul femminicidio, mentre l’attenzione mediatica tende a concentrarsi sulla singola tragedia o sulla storia dell’assassino, relegando le vittime in secondo piano.
Le vite delle donne e i loro nomi finiscono così facilmente dimenticati, ridotti a un dettaglio marginale a cui rivolgere solo un momento di cordoglio. Ma è da quelle storie che chi lavora nel settore parte per individuare gli elementi che potrebbero anticipare un prossimo femminicidio, una prossima vittima.

L’autrice nella foto di Pasqualini, Musacchio/MUSA
Donata Columbro lavora ogni giorno nel tentativo di umanizzare i dati, perché dietro le statistiche, dietro i metodi di raccolta dei dati, ci sono sempre persone, con i propri corpi e con le proprie esperienze, e questo è un dettaglio che molte volte passa in secondo piano quando guardiamo ai numeri.
Nei suoi libri Ti spiego il dato (Quinto Quarto, 2021), Dentro l’algoritmo (effequ, 2022) e Quando i dati discriminano (Il Margine, 2024), Columbro ha analizzato il legame tra i dati e le persone, i contesti, in cui questi vengono prodotti.
Alle sue pubblicazioni precedenti si aggiunge il suo nuovo progetto, in uscita con Feltrinelli: Perché contare i femminicidi è un atto politico. In occasione dell’uscita abbiamo parlato con lei di dati, di potere e del perché capire come contare i femminicidi è un primo passo per studiare la violenza di genere.

Da dove è nata l’esigenza di questo libro?
“L’idea è partita nell’ottobre dell’anno scorso, anche se forse ci ragionavo già da un anno senza saperlo. Una cosa che mi ha colpito molto negli ultimi due anni è la quantità di persone che negano l’esistenza dei femminicidi o della violenza di genere. Quando ho iniziato a lavorare all’idea del libro avevo già osservato questa tendenza. Dopo il 25 novembre 2024 ho visto una serie di contenuti non solo sotto forma di commenti isolati, ma veri e propri materiali creati da persone che si prendevano il tempo di produrli per smentire l’esistenza dei femminicidi o dei dati a riguardo, anche quelli dell’Istat e non solo quelli pubblicati dai movimenti femministi”.
E poi, come è iniziato il lavoro sul saggio?
“Ho iniziato a ragionare su cosa volessero dire davvero questi dati. Nel mio lavoro non cerco mai di limitarmi al numero, alla percentuale o al dato totale, per me non è solo questo il valore del contare. Dentro quei numeri ci sono tantissime altre cose che vanno raccontate, ancora di più se parliamo di un fenomeno come quello dei femminicidi. Bisogna partire da una definizione che non è condivisa nemmeno tra enti dello stesso paese, figuriamoci tra paesi diversi. Ogni confronto o comparazione è quindi molto difficile”.
E qual è dunque l’obiettivo?
“Non è solo la precisione della cifra finale che ci deve interessare, ma il motivo per cui contiamo. Dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno e chiedere alle istituzioni di farsene carico. Esistono organizzazioni, persone singole e centri antiviolenza che già se ne prendono cura autonomamente, e meno male che lo fanno, ma non deve mancare l’attenzione della politica”.
Può interessarti anche
Cosa intendiamo per dato?
“Per me i dati sono fenomeni naturali o sociali, cioè cose che accadono nel mondo e che qualcuno con intenzione decide di definire, misurare, quantificare e categorizzare. Già in questa descrizione è evidente quanto l’intervento umano sia determinante. E questo intervento avviene sempre all’interno di un contesto sociale, culturale e storico. Il modo di contare dipende dall’obiettivo che ci si pone: ecco perché c’è differenza tra il contare delle istituzioni e quello dei movimenti. Ma dipende anche dal punto di vista…”.
Perché?
“Perché a sua volta è legato al corpo e alla posizione che si occupa nella società. Per me la persona che compie l’azione di contare, anche rispetto al corpo che abita e nella società in cui vive, ha uno sguardo diverso”.
I dati, quindi, non sono oggettivi?
“Oggi viviamo in una società ancora profondamente sessista, razzista, abilista, omofoba, e potremmo purtroppo aggiungere altri aggettivi. Anche chi è molto aperto e attento a osservare le differenze non può avere uno sguardo completamente oggettivo: la propria posizione inevitabilmente influenza la produzione dei dati, rendendola parziale. In realtà, tutti noi abbiamo una percezione parziale: non possiamo essere completamente oggettivi, perché partiamo sempre dalla nostra soggettività”.
Ma allora come possiamo considerare affidabili i dati?
“Quello che può rendere una raccolta dati valida e utilizzabile per osservare un fenomeno è il rigore, o quantomeno l’esistenza di una metodologia dichiarata e spiegata, una metodologia che racconti anche i limiti della propria produzione dei dati. A questo punto possiamo fare dei confronti: non per dare ragione a un’istituzione, a un ente o a un movimento, ma per comprendere le differenze e le criticità di chi deve misurare un fenomeno su cui occorre raggiungere accordi per definirlo. La storia di come si misura la violenza di genere, e di quanto tempo le istituzioni politiche abbiano impiegato per trovare le domande giuste, ci dice molto al riguardo. L’oggettività è un mito, sostenuto anche da chi la associa alla razionalità. In questa visione, chi non è oggettivo non è razionale, e chi usa le emozioni mette in pericolo la validità delle statistiche”.
Può interessarti anche
Come mai alcuni dati ci sembrano più affidabili di altri nel caso della violenza di genere?
“Ci sono forse due motivazioni. La prima riguarda il fact-checking e l’attenzione alla disinformazione. Esiste una corrente di pensiero che sostiene che la prima cosa da fare sia verificare le fonti. Io stessa insegno in questo modo: bisogna partire dalla fonte. Le fonti si dividono, in genere, tra ufficiali e non ufficiali, a meno che non ci si trovi in una dittatura o in contesti simili. Le fonti istituzionali vengono presentate come oggettive, ma già grazie all’esperienza dell’era Trump abbiamo visto che non sempre lo sono davvero. Eppure, a livello accademico o giornalistico, si parte sempre da lì”.
Perché?
“Perché le istituzioni hanno al loro interno una metodologia codificata, riconosciuta, ed è importante che esista questa distinzione. Io stessa riconosco l’ufficialità e l’autorevolezza di certe banche dati o lavori istituzionali. Ma, su alcuni argomenti, l’esistenza di pratiche di controinformazione ci dice qualcosa di più: ci mostra che i dati ufficiali possono avere dei limiti, dei buchi, che spesso le comunità dal basso cercano di colmare. Questo è un elemento che chi studia giornalismo non può trascurare”.
Un esempio?
“Se pensiamo al tema della violenza di genere, i dati raccolti dal basso hanno un obiettivo e una metodologia diversa da quelli istituzionali. Partono da una posizione dichiarata, mentre quella ufficiale spesso non lo è. Questo dichiararsi ci mette in guardia: chi esplicitamente adotta una prospettiva non oggettiva porta con sé una visione del mondo. Tuttavia, ciò non significa che non possiamo usare quei dati per costruire altri discorsi. Del resto, anche i dati istituzionali possono servire a fare propaganda: solo che, essendo istituzionali, li guardiamo in un altro modo”.
Può interessarti anche
Dobbiamo quindi cambiare approccio?
“Non dobbiamo limitarci a chiederci se i dati siano ‘oggettivi’, ma domandarci piuttosto che cosa ci dicono, quale vuoto colmano. Prendiamo l’esempio dall’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transcidi di Non Una di Meno: la cosa interessante non sono i numeri in sé, ma le storie che emergono, la disaggregazione dei dati che mostra, per esempio, se le vittime avevano figli oppure no. Oppure l’inclusione recente dei tentati femminicidi: anche lì parliamo di un fallimento delle politiche di prevenzione perché, se si arriva a un tentato omicidio significa che qualcosa non ha funzionato”.
In cosa può aiutarci questo punto di vista?
“Colmare questi vuoti non serve solo a raccontare una realtà diversa, ma può avere anche la funzione di spingere le istituzioni a occuparsene. In molti casi è successo, e meno male che ci sono i movimenti e le giornaliste dal basso a fare questo lavoro. In altri casi, però, non è detto che accada: spesso il potere, proprio perché deve governare, non può permettersi di mettere in evidenza certi abusi o soprusi. E allora è fondamentale che siano le realtà dal basso a farlo questo lavoro”.
Può interessarti anche
Da un lato abbiamo i nomi, le storie, dall’altro lato abbiamo le statistiche. Perché tenere conto di entrambe è un atto politico?
“Lavorando al libro, mi ha colpito quanto il lavoro delle persone che ho intervistato sia simile, anche se non collaborano insieme. Penso, ad esempio, alla giornalista Anna Bardazzi, alla Casa delle Donne di Bologna, a Non Una di Meno, o a chi in RAI ha gestito database sulla violenza di genere. In tutti questi casi, i dati e le storie raccolte seguono schemi simili: elementi che si ripetono e che sono fondamentali per comprendere la violenza e per indicarci come prevenirla”.
E c’è qualche esempio concreto di come vengono contati questi dati?
“Uno dei metodi che ho studiato, quello delle Domestic Homicide Reviews del Regno Unito, è istituzionale, ma molto simile al lavoro dei movimenti dal basso. Prevede la raccolta di interviste con i familiari delle vittime, analizzando ogni dettaglio della loro storia per capire dove le istituzioni hanno fallito. Le storie ci mostrano i punti critici: un braccialetto elettronico che non funziona, l’assenza di educazione sessuo-affettiva a scuola, il mancato sostegno alle famiglie con disabilità, sia per uomini che per donne. Sono dettagli che spesso sfuggono alle statistiche generali, ma sono essenziali per individuare dove intervenire”.
Può interessarti anche
Qual è stata la parte più difficile nel lavorare a questo libro?
“Durante la scrittura mi sono commossa moltissimo, ma ho anche provato un senso di sorellanza, o di comunità, con tutte le persone che ho intervistato. Mi sono emozionata quando ho notato che il lavoro di persone che non si conoscono andava nella stessa direzione: raccontare le storie delle vittime non solo per compilare statistiche, ma per rendere loro giustizia, ricordarne i nomi, le pronunce corrette se erano straniere, l’identità. Immaginare il loro lavoro, in diversi parti di Italia, mi ha reso chiaro anche perché stavo facendo il mio di lavoro. Se avessi potuto aggiungere un sottotitolo al libro, avrei scritto: ‘e anche un atto di cura’”.
E poi?
“Complesso è stato anche riuscire a riconoscere e a chiarire il lavoro di tutte le persone che si stanno occupando di raccogliere dati, perché io non sono quella che ha raccolto i dati. Tutto quello che abbiamo sulla violenza sulle donne è raccolto dalle donne, ed è la cosa più complessa e forte che ho vissuto scrivendo il libro. Le pagine del libro esistono grazie al loro lavoro”.
Può interessarti anche
Perché contare i femminicidi è quindi un atto politico?
“Credo ci sia una dimensione etica in questo. A livello istituzionale c’è un riconoscimento paritetico tra destra e sinistra che le disuguaglianze esistono e che la violenza di genere è sbagliata. Tuttavia, c’è una differenza tra riconoscere il problema e agire concretamente. L’atto politico consiste nell’intervenire sulle fondamenta: capire quali sono i punti critici, sistematizzare le informazioni, destinare risorse e valutare se gli interventi funzionano. È un atto pratico che non lascia spazio alla propaganda”.
E invece perché seguire i soldi è un buon punto di partenza per studiare i femminicidi e la violenza di genere?
“La violenza economica è uno degli ambiti meno esplorati della violenza di genere, anche perché le statistiche nazionali sulla povertà considerano il nucleo familiare e non gli individui per i dati sul reddito. Il dialogo con l’economista Marcella Corsi, che ha studiato un indice del patriarcato, è stato illuminante. Lei analizza non solo il controllo economico nella coppia, ma anche nelle relazioni familiari tra padri e figli. Andando a vedere poi le storie con le sue parole in mente, dai dati emerge come il controllo economico non riguardi solo gli uomini che limitano le donne, ma anche situazioni in cui la donna guadagna di più e l’uomo dipende economicamente, pur pretendendo di amministrare i soldi. Questi disequilibri economici, insieme ad altre dinamiche relazionali, possono avere esiti drammatici”.
Da dove partire per studiare il fenomeno?
“Analizzando i casi nei database che ho potuto consultare, emerge anche come la gestione dei soldi e la mancanza di investimenti influisca sulla possibilità di proteggere persone vulnerabili, ad esempio partner con disabilità, o nel ribaltare stereotipi di cura sempre affidata alle donne. Intervenire su queste dinamiche economiche permette di capire dove i soldi investiti funzionano e dove no. I dati della Commissione di inchiesta sui femminicidi, mostrano che le persone inserite in percorsi di protezione hanno meno probabilità di essere uccise, perché la consapevolezza della violenza permette di interrompere relazioni pericolose, violente e riduce la solitudine e l’isolamento di queste donne”.
Può interessarti anche
Cosa vorrebbe restasse del suo libro ai lettori?
“Vorrei che per i lettori emergesse l’importanza di interrogarsi sul proprio ruolo quando ci si confronta con situazioni di violenza, anche solo attraverso le notizie. È fondamentale osservare dati e storie per riuscire a riconoscere situazioni di abuso nella vita quotidiana, anche tra persone che conosciamo. Bisogna anche tenere presente che i dati ufficiali sottostimano la violenza: leggere le storie ci permette di percepirla meglio e di capire quanto sia diffusa. Posso immaginare che, vivendo in un corpo diverso, sia difficile pensare che davvero una donna su tre abbia vissuto violenza o abuso. La violenza è, a volte, difficile da individuare persino per chi la subisce, e spesso non sfocia in una denuncia; per questo la riflessione dovrebbe concentrarsi su quanto siano frequenti queste dinamiche, dalla famiglia al lavoro. Bisogna far proprio il concetto di ‘sorella, io ti credo’”.
E alle lettrici?
“Alle lettrici e a tutte le altre comunità minoritarie vorrei far passare l’idea che esiste una rete di persone che si prendono cura delle donne e di tutte le soggettività marginalizzate. Il femminismo dovrebbe essere l’opposto della solitudine: ci sono reti di sostegno e azioni concrete che possono davvero salvare. Basti pensare a un dato evidenziato dalle ricercatrici della Commissione d’inchiesta: non aver confidato nemmeno a un’amica la propria situazione di relazione ha messo le donne in pericolo. In questo senso, entrare in contatto con una rete e farne parte può letteralmente salvarci”.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it