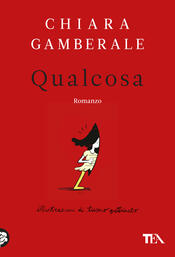“Ho cominciato a scrivere per difendermi dal rischio che no, la quarantena non mi avrebbe cambiata… Perché sono terrorizzata dalla possibilità di non permettere alle grandi esperienze a cui siamo chiamati di trasformarci”. Su ilLibraio.it Chiara Gamberale si racconta e parla di “Come il mare in un bicchiere”, un resoconto emotivo e intimo dei giorni del lockdown, trascorsi a Roma insieme a sua figlia di due anni, Vita (“a volte credo che mi consideri più una compagna di giochi che sua madre”): “La sensazione più pericolosa, per me, è quella di sentirsi persi mentre ci si sente intrappolati… Il bisogno di assoluto che, però, si scontra con il limite del nostro essere umani, del nostro stare al mondo. E che è anche l’unica occasione che abbiamo per incontrare gli altri”
Diario di quarantena: chi non ne ha tenuto uno? Pagine introspettive abbozzate qua e là su un vecchio quaderno, pensieri sparsi impressi su fogli svolazzanti, racconti autobiografici con scenari apocalittici e distopici. Perfino sui social sono apparse le immagini di note dell’Iphone e post che registravano gli stati d’animo di una routine apparentemente sempre uguale.
Tra chi sosteneva che era meglio spostare l’attenzione su altro e chi invece non riusciva a smettere di parlarne, è innegabile che i mesi del lockdown ci abbiano lasciato in eredità molteplici scritti sulla nostra condizione di reclusione forzata.
Tra questi, c’è un piccolo volume di 114 pagine, un testo che scorre rapido e leggero, ma che si sedimenta così in profondità da restare ancorato nella mente del lettore per giorni. Parliamo dell’ultimo libro di Chiara Gamberale (nella foto di Andrea Doretti, ndr), Come il mare in un bicchiere (pubblicato con Feltrinelli e il cui ricavato sarà devoluto allo spazio di accoglienza per i bambini e le famiglie di CasaOz in situazione di emergenza Covid-19), un resoconto emotivo e intimo della sua quarantena, trascorsa a Roma insieme a sua figlia di due anni, Vita.

Sull’autrice, non c’è bisogno di dire molto: Gamberale, celebre per romanzi come Le luci nelle case degli altri (Mondadori), La zona cieca (Feltrinelli, Premio Campiello Giuria dei Letterati), Per dieci minuti (Feltrinelli) e Avrò cura di te (scritto con Massimo Gramellini e pubblicato con Longanesi), ma anche per storie illustrate per bambini come Qualcosa (Longanesi), è tra le scrittrici italiane più popolari.
Nata a Roma nel 1977, collabora con diverse testate e conduce programmi radiofonici e televisivi.
Può interessarti anche
Lo spazio di questo suo nuovo libro è breve ma risuona con intensità, proprio come il mare in un bicchiere. Un’onda non minacciosa ma avvolgente, accogliente, uno spazio personale e collettivo, un “protocollo di autodifesa psicologica ed emotiva che questa incredibile tragedia ci potrebbe suggerire”.
Può interessarti anche
“La quarantena ci renderà migliori”: Chiara Gamberale, che ne pensa di questa frase? E di quello che è realmente successo dopo?
“Sto cominciando a ricevere le confidenze di parecchie persone a cui, fatalmente, adesso manca quello che sono state (o che hanno creduto di potere diventare) durante il lockdown… Io ho avvertito che potesse accadermi anche mentre ero barricata in casa: e proprio per questo ho cominciato a scrivere. Anche per difendermi dal rischio che no, la quarantena non mi avrebbe cambiata…”.
Perché?
“Sono terrorizzata dalla possibilità di non permettere alle grandi esperienze a cui siamo chiamati di trasformarci. Personalmente, mi sto sforzando di mettere in pratica quello che, nei giorni del lockdown, ho avuto la sensazione di comprendere in teoria. Ma è ancora presto per dire se ci sono riuscita”.
“Siamo tutti sulla stessa barca”, anche questa è una frase che si sentiva ripetere molto durante la quarantena. Eppure qualcuno ha fatto giustamente notare che “siamo tutti nella stessa tempesta, ma su barche diverse”. La sua è stata quella di una donna, a cui il dottore aveva appena prescritto una cura per una brutta depressione e con una bambina piccola. Com’è stato?
“Paradossalmente, come racconto nel libro, la quarantena mi ha risvegliata dalla mia quarantena privata, dove ero scivolata… È un po’ come succede in Melancholia di Lars Von Trier, dove la protagonista nella prima parte del film è incapace di vivere, e invece nella seconda si ritrova capacissima a fronteggiare la fine del mondo che incombe. E poi, appunto, c’era mia figlia Vita da proteggere. Una condizione sicuramente particolare, la mia: ma quello che ha reso collettiva l’esperienza del lockdown credo sia stato anche il fatto che ognuno di noi ha avuto la sensazione di essere in una condizione particolare… Chi perché si era appena separato, chi perché si era appena innamorato, chi perché stava per avere un figlio. Ma credo che le uniche persone davvero in una condizione particolare siano state quelle che hanno perso qualcuno di caro o che si sono ammalate o che già stavano fronteggiando un’altra malattia, come una delle protagoniste del libro. A tutti noi altri questa gigantesca esperienza psichica potrebbe servire anche per ridimensionare quello che ci capita e che ci sembra sovrumano semplicemente perché capita a noi”.
Per reagire alle difficoltà del periodo della quarantena, racconta di aver inventato per sua figlia Vita dei modi per non sentirsi succube di un tempo immobile, di un destino dal quale non si può sfuggire. È quindi l’immaginazione l’arma contro i periodi più bui?
“Non lo so, sicuramente è una mia arma… E che però è un’arma a doppio taglio, perché un eccesso di immaginazione nutre quell’insoddisfazione profonda che non mi abbandona mai, mai mai. Ma sicuramente, se si ha un bambino tanto piccolo, può diventare una risorsa. A volte credo che mia figlia mi consideri più una compagna di giochi che sua madre”.
Può interessarti anche
Il libro – anzi, il “quaderno”, come lo definisce lei – è autobiografico ma, allo stesso tempo, racconta scene ricche di elementi immaginifici. Preferisce la realtà o la finzione?
“Sa che non riesco bene a individuare una differenza fra le due dimensioni? Fin da bambina il fantastico non è stato uno strumento per tradire la realtà, ma per capirla meglio, per nutrirla. E infatti la mia vita e la mia scrittura sono in una connessione profonda e continua”.
Il romanzo parte da un dolore e uno spaesamento interiore. Cosa significa sentirsi persi in mezzo al mare? E cosa, invece, sentirsi intrappolati in un bicchiere?
“La sensazione più pericolosa, per me, è quella di sentirsi persi mentre ci si sente intrappolati… Il bisogno di assoluto che, però, si scontra con il limite del nostro essere umani, del nostro stare al mondo. E che è anche l’unica occasione che abbiamo per incontrare gli altri”.
Cosa rappresenta per lei esporsi nella scrittura e raccontare di sé e del suo essere madre?
“Ho cominciato a scrivere prestissimo, ero ancora una bambina, avevo otto anni… È stato il mio modo istintivo per sopportare l’esistenza e cercare di capirla, anziché subirla. Era inevitabile che anche la maternità arrivasse nelle mie pagine”.
Nel libro parla dell’importanza di conoscere se stessi, le proprie emozioni, i propri umori. Qual è il modo per poterlo fare?
“Per quanto mi riguarda il modo è stato non sottrarmi. Al dolore, ma anche alla gioia. Attraversare gli stati d’animo, anche e soprattutto quando sembrano insopportabili. Ma credo che rimanere in contatto con noi stessi sia l’unico modo perché quegli stati d’animo non prendano davvero il sopravvento su di noi sotto forma di sintomi misteriosi, che potremmo fare molta fatica, un giorno, a comprendere…
Può interessarti anche
Ormai si usa la parola “depressione” con leggerezza, in modo inflazionato, per indicare stati d’animo negativi e quotidiani. Crede che sia necessario parlare di questa malattia in altri termini?
“Mi fa molta rabbia quando certe parole vengono usate con disinvoltura. E sì, credo che bisognerebbe fare più attenzione. Ma mi dico anche che è fortunato chi non sa davvero che cosa significhi sentirsi ‘come il mare in un bicchiere'”.
Quando potremo definirci “guariti”?
“Forse mai abbastanza. E però è anche per provare a essere ogni giorno un po’ meno malati che ci ostiniamo a vivere, non crede?”.