“La casa è un tentativo di plasmare il mondo a propria immagine e somiglianza, di raccontarsi e di costruire se stessi”. Abbiamo intervistato Emanuele Coccia, uno degli intellettuali contemporanei più eclettici, in occasione dell’uscita del pamphlet “Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità” (scritto e pensato prima della pandemia, ma la cui lettura è inevitabilmente condizionata dai lunghi mesi di emergenza sanitaria). Per Coccia (che ha traslocato già ben trenta volte) “sarà l’’amore a definire sempre di più l’architettura delle case e delle città: il modo in cui daremo forma a questa intimità sarà molto più capillare e diffuso…”
Emanuele Coccia ha traslocato trenta volte, l’equivalente di trenta giudizi universali e altrettanti riti di passaggio. Per lui è il trasloco che fa la casa. Ha abitato in uno stabile berlinese in cui il bagno era a cielo aperto e d’inverno andarci equivaleva a una spedizione nell’Antartico, provando sulla propria pelle quella logica di disgiunzione e di sintesi impossibile che la toilette incarna. Si è fatto conquistare da un appartamento senza mobili, per poi accorgersi che lo spazio nella sua purezza geometrica è fisicamente inabitabile.
È a partire da esperienze come queste che il professore dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, classe 1976, ha ripensato al luogo che troppo a lungo abbiamo dato per scontato e che la pandemia ci ha portato a riconsiderare nel saggio Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità, edito da Einaudi.
Considerato uno degli intellettuali contemporanei più eclettici, definito il filosofo dei millennial sebbene non vi si riconosca – “io in realtà non credo nelle generazioni” – Emanuele Coccia ha fatto del suo “dongiovannismo domestico” lo spunto per una riflessione poliedrica, raffinata e attuale sulla casa e sulla famiglia. Riprendendo spunti dalle sue opere precedenti come La vita sensibile (Il Mulino, 2011), Il bene nelle cose (Il Mulino, 2014), La vita delle piante. Una metafisica della mescolanza (Il Mulino, 2018), il suo pamphlet filosofico spalanca orizzonti inediti per ripensare il nostro abitare il Pianeta. E senza bisogno di aprire la porta.
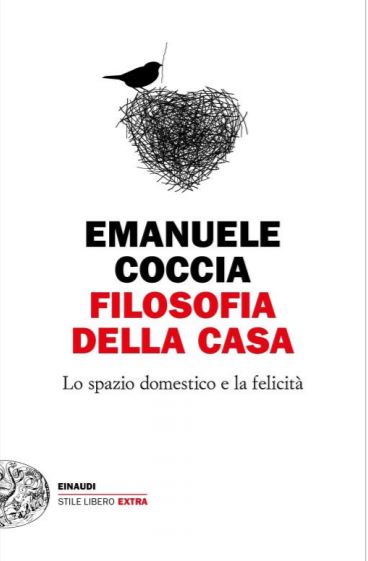
La filosofia è nata come sapere urbano. Quanto l’esperienza legata al Covid-19 ha fatto sì che fosse il momento giusto per una filosofia della casa?
“Scrivere un libro sulla casa proprio mentre tutta l’umanità era costretta a restarci a causa di una pandemia sarebbe stato un incubo. L’idea di questo testo nasce da prima e nonostante il Covid, per via di tutti i miei traslochi e dalla volontà di fare un inventario tra sommersi e salvati di una vita. Inoltre mi era già bastato il senso di colpa per il mio saggio precedente, Métamorphoses (Rivages, 2020, ndr), pubblicato in Francia proprio il giorno in cui lì era iniziato il primo lockdown”.
Perché il senso di colpa?
“Perché nelle ultime pagine di quel libro, scritte due anni prima, sostengo che per capire il futuro sia necessario pensare a un virus. Può comprendere la mia angoscia nei giorni dell’uscita”.
Ma non è proprio compito della filosofia interpretare il divenire?
“Non credo all’esistenza delle discipline e molti non mi apprezzano per questo. La filosofia è nata per opporsi ai sofisti, cioè agli esperti, ai teorici. Era un modo per dire ‘sono un dilettante’, in francese ‘amateur’. Per me la filosofia è il luogo in cui improvvisamente eros definisce il nostro rapporto con il sapere. Una passione sfrenata, disperante, ostinata, come quella con un partner”.
A proposito di rapporti, quello tra filosofia e città sembra in profonda crisi.
“La reazione alla pandemia ha permesso di accelerare in maniera sincronizzata su scala planetaria dei processi già in atto. Chiudere a chiave le città, renderle uno spazio fuorilegge e inaccessibile, non ha fatto che decretarne una morte già iniziata, forse a causa di un eccesso di vita. E al contempo ci ha fatto scoprire quanto avessimo trascurato le nostre case, trattate alla stregua di garage. Questo disequilibrio non poteva funzionare”.
Può interessarti anche
E ne stiamo sperimentando le conseguenze.
“Pensi a quante grandi imprese, incentivando lo smart working anche dopo l’emergenza, stanno portando soprattutto le élite commerciali, a lasciare le città. Per i negozi e i servizi sarà un danno e il paesaggio urbano dovrà essere ridisegnato. Al contempo le case si stanno riappropriando della dimensione lavorativa. E questo è uno dei passaggi più radicali degli ultimi secoli”.
In che senso?
“La modernità è nata strappando il lavoro alla casa. Oggi diventa uno spazio che, per fare posto al lavoro, necessita di essere più bello e più grande. Cambia quindi ciò che noi chiediamo alle case. Questa scoperta, attraverso il virus, di avere tutti la stessa carne, rende la divisione in Stati, Continenti e città superflua. La politica non potrà che essere globale e la domanda da porsi non sarà più in quale nazione vivere, ma con chi”.
Un chi potenzialmente infinito grazie ai social network, autentiche estensioni dei nostri corpi.
“Abbiamo plasmato Instagram, WhatsApp e gli altri social sul modello domestico, come dei salotti digitali, spazi di intimità molto più grandi di quelli che una casa minerale offre, bypassando le città e persino gli Stati”.
Può interessarti anche
Lei nel libro li definisce “immagini utopiche distorte”, uno spazio in cui “la vita si fa auto-fiction e serve a diventare ciò che si è”.
“Entri dentro una casa e sono grotte in cui ti ritrovi in un altro spazio-tempo: in un unico condominio o lungo vie limitrofe puoi passare da Pechino a San Pietroburgo. La casa è un tentativo di plasmare il mondo a propria immagine e somiglianza, di raccontarsi e di costruire se stessi”.
Conferma quindi l’affermazione che “noi abitiamo davvero solo le cose”?
“Sì, e la casa è stata sempre auto-fiction, perché abbiamo bisogno dell’aiuto delle cose per diventare ciò che siamo. I social media hanno semplicemente esteso questo esercizio di auto-definizione in uno spazio virtuale che probabilmente diventerà sempre di più la nostra casa e la nostra patria”.
“Un abito è una casa rovesciata in vetrina […] e una casa è un abito che si è allargato a tal punto da diventare un armadio psichico che cova tutte le trasformazioni che l’io indossa”. Grazie a questa sua definizione mi sento meno in colpa per i miei armadi…
“I vestiti sono scialuppe, battelli, caravan che non hanno bisogno di ruote perché aderiscono al nostro corpo e che usiamo per vivere il mondo. La casa è un vestito enorme di pietra attraverso cui costruiamo la nostra identità, accumulando tutte le cose che ci permettono di vivere come vogliamo: libri, cibo e anche abiti”.
Lei scrive ancora: “Le case sono santuari privati di un inconsapevole culto animista segreto. Sono musei personali che ci permettono di scoprire e contemplare la nostra anima mentre vive al di fuori del nostro corpo”. Un po’ come nel Museo dell’Innocenza di Orhan Pamuk.
“Quando affittiamo un appartamento su Airbnb o entriamo in case di persone che non conosciamo bene, percepiamo immediatamente qualche indizio di personalità. Questo è un primo esempio di come, nelle case, le cose siano un corpo extra anatomico della persona che le abita, sono più di semplici oggetti, sono un’esistenza non carnale di soggetti. In questo senso parlo di animismo”.
E rispetto al museo?
“Il parallelo con il museo proviene da un antropologo inglese, Alfred Gell, secondo il quale chiamiamo ‘arte’ la sfera in cui, in Occidente, riconosciamo alle cose un’esistenza quasi analoga a quella umana. Eppure la nostra civiltà si basa su una distinzione radicale tra oggetti e soggetti, che non è in realtà così chiara”.
Per quale motivo?
“Io abito a qualche centinaio di metri dal Louvre e basta pensare a come milioni di persone contemplino per ore pezzi di materia – lino coperto di pigmenti, legno, bronzo – certe di potervi riconoscere i pensieri di chi li ha prodotti, di Leonardo, Rubens e Paolo Uccello senza averli mai incontrati. È qualcosa di illogico eppure ci fa sentire vivi”.
E lo stesso avviene nelle case?
“Sì, è come se la casa ci desse la possibilità di estendere l’anima. È per questo che costruiamo case: per arrivare a dire ‘io’ più lontano dal limite che il nostro corpo ci impone. Entrando dentro casa, quando si coabita, accettiamo inoltre di diventare una parte dell’io e del corpo altrui. Per questo la coabitazione può essere un sogno o un incubo”.
La casa è infatti lo spazio per vivere l’amore. “È impossibile amare senza fare casa”, sostiene. Perché per lei questo è il tratto più profondo della modernità occidentale?
“I due cardini su cui si fonda la costruzione dell’individuo nella modernità sono il lavoro e l’amore: il primo riservato alla città e il secondo allo spazio domestico. Ma non è sempre stato così. Nel Medioevo non esisteva l’idea di andare a vivere in una casa con chi amavi: le case precedevano gli amori, anzi, spesso li decidevano”.
Eppure ancora oggi, quella negligenza sulla casa che citava all’inizio sembra sia diventata anche una negligenza sull’amore.
“A parte i grandi romanzi, la letteratura e la psicanalisi, di questo aspetto, che riempie completamente la nostra vita, sappiamo parlare poco. Siamo ossessionati dall’incontro, dall’innamoramento, però non abbiamo voluto creare un sapere su cosa sia un amore duraturo. In questo la nostra modernità è monca”.
Non c’è speranza?
“Il grande laboratorio dei prossimi anni è iniziato paradossalmente con la pandemia, che ci ha imposto di scegliere con chi vivere. Pensiamo alle polemiche nate attorno al termine ‘congiunto’: è un sintomo interessante che l’idea di amore in senso lato non può più essere definita genealogicamente, ma come un’intimità più aperta, come uno spazio di congiunzione in cui l’amicizia avrà un ruolo chiave”.
Un po’ come le comuni degli anni Settanta?
“No, quelli erano posti utopici, pieni di malintesi e per questo forse sono crollati. Dovremo trovare una terza via alternativa, tra quella di una casa minerale in cui vivono assieme tre persone al massimo e quella di una casa digitale in cui entrano tutti indiscriminatamente. Sarà l’amore a definire sempre di più l’architettura delle case e delle città: il modo in cui daremo forma a questa intimità sarà molto più capillare e diffuso”.
Lo spazio domestico ambisce alla felicità, intesa come “un’armonia arbitraria ed effimera che stringe per un attimo cose e persone in una relazione di intimità fisica e spirituale”.
“Sì, la casa è una grande macchina che ritaglia dal mondo una porzione di realtà che possiamo scambiare con noi stessi. Un cerchio magico fatto di atmosfere, persone, eventi e oggetti in cui possiamo anche dimenticarci di noi. L’intimità precede l’identità: attraverso ciò che decidiamo che ci è intimo arriviamo ad essere ciò che siamo. E lì sta la felicità”.
Eppure per lei l’esperienza più radicale per fare casa resta la scrittura, “una delle sostanze psicotrope più potenti che esistano”.
“Io vivo per scrivere, è il perno attorno a cui quasi tutto ruota e ciò che mi dà accesso a quasi tutto. Sebbene per un disgrafico come me sia spesso dolorosa, è l’equivalente di un’esperienza lisergica e di visione senza troppi effetti collaterali. E poi è possibile ottenerla a ripetizione con un minimo di controllo. La scrittura significa aprire le porte della percezione, come scriveva Huxley, spalancare lo spazio-tempo. Una casa è lo stesso, è scrittura”.
Foucault parlava di eterotopie, circoscrivendole però a luoghi come teatri, cinema, camere d’albergo, persino cimiteri, senza però citare le case.
“E non citava nemmeno la parola, che è la prima eterotopia, intesa come ciò che più di ogni altra cosa e con semplicità ci proietta verso un altro spazio-tempo”.
A proposito di spazio-tempo, lei paragona la casa del futuro alla pietra filosofale. Che cosa intende?
“Dobbiamo ripensare materialmente le case come dei videogiochi, spazi di mescolanza in cui l’immaginazione definisce la materia e non il contrario, capaci di trasformarsi rapidamente, come rapidamente può cambiare il clima o il tempo. Oggi non c’è più un fuori casa perché viviamo in un mondo in cui non c’è più uno spazio ulteriore a quello domestico”.
Il Pianeta stesso è diventato casa.
“I nostri coinquilini non sono più solo mariti, mogli e figlie, ma pinguini, foche, leoni, batteri e virus. Le case sono state sempre esercizi di umanismo radicale, ma la casa-mondo deve allargarsi per accogliere sempre di più anche non umani. L’ecologia è una scienza assieme imprescindibile e molto ambigua: è l’unica forma di universalismo che ci resta e la sola politica possibile oggi. Tutto il resto è folklore”.
E allora perché l’ecologia non basta?
“L’ecologia come ‘economia della natura’ ha una scarsissima memoria storica e poco senso critico, soprattutto nel continuare a operare l’opposizione tra umano e non umano, tra naturale e artificiale. Si pensa che il gesto più vero dell’ecologia sia immaginare uno spazio terrestre in cui l’uomo non entri, ma è surreale. Il problema non è come l’uomo possa ritirarsi, ma costruire uno spazio di negoziazione in cui stabilire dei legami di intimità e di co-inquilinato tra le diverse specie. Questo significa accettare davvero a casa gli altri. È attraverso questa nuova chimica che potremo salvarci”.





