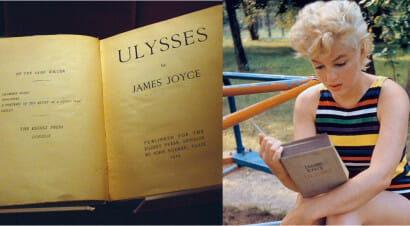Grazie a Safarà, editore curioso di imprese impossibili, è possibile leggere oggi “Il peso delle cose”, opera complessa, misteriosa, labirintica e, soprattutto inquietante, firmata di Marianne Fritz (1948 – 2007), scrittrice per pochi, forse pochissimi, semisconosciuta persino nella sua Austria. La racconta su ilLibraio.it Mario Baudino
Marianne Fritz è scrittrice per pochi, forse pochissimi, semisconosciuta persino nella sua Austria, dove visse auto-reclusa in una appartamento pieno di libri, vinse qualche premio e morì nel 2007. Ha pubblicato, dopo il romanzo d’esordio, molte migliaia di pagine in due enormi volumi cui è seguito un terzo incompleto, tutti di fatto non disponibili in commercio, e dei quali ha venduto qualche centinaio di copie.
È una sorta di fantasma, amatissimo da un pugno di studiosi non solo – ma in gran parte – accademici, e apprezzato a suo tempo almeno da W. G. Sebald; altri scrittori furono molto più freddi; talvolta, come Thomas Bernhard, feroci. Ha una bibliografia critica abbastanza ridotta, che tuttavia vede in lei una sorta di genio, un’autrice che ha portato al limite estremo la riflessione sulla parola, che anzi quel limite l’ha superato, forse naufragando.
Le monumentali edizioni della sua opera matura sono quasi illeggibili perché la violazione consapevole di sintassi e grammatica e la creazione di parole composte si spinge fino a stravolgere la linearità della scrittura con collage di frasi, parole e disegni, immagini più che testi, che possono di volta in volta riprodurre lo schema di un protocollo, di un registro contabile o di una poesia visiva, o ancora di un brogliaccio dattiloscritto, reinserendo magari più volte il foglio sul rullo della macchina da scrivere.
Ma il primo romanzo, questo che ora viene pubblicato da Safarà, editore curioso di imprese impossibili (la traduzione è di Giovanna Agabio), col titolo Il peso delle cose, è un’opera complessa e soprattutto inquietante: è l’inizio di tutto, già sembra contenere ciò che accadrà alla scrittrice, e tuttavia nello stesso tempo ha un’aura di (spaventevole) perfezione.
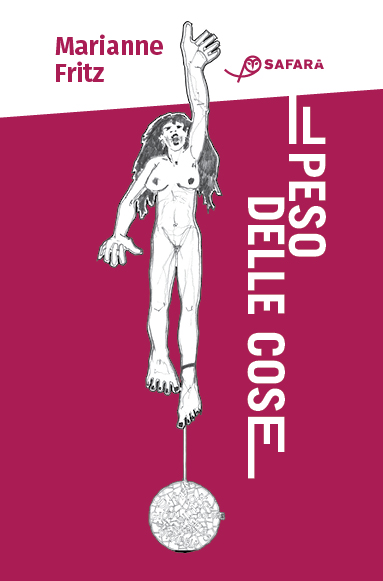
Come nello lo sguardo della Medusa contemplato agli Uffizi verso la fine del 1819 da un P. B. Shelley rapito da “orrore e bellezza”, e destinato a influenzare un secolo di letteratura romantica, anche per questo romanzo – che è del 1978 – si potrebbe parlare di quella “tempestosa leggiadria del terrore” evocata dal poeta in un suo testo celeberrimo, Sulla Medusa di Leonardo da Vinci, dove ci descrive peraltro un quadro la cui attribuzione è da tempo caduta: ed è questo un particolare forse non secondario, perché nel romanzo scatta, leggendolo oggi, quasi una discrasia temporale, una sorta di vortice della contraffazione, inconsapevole e a posteriori.
È come se la storia non ci venisse veramente da lei, ma da qualcosa (qualcuno, un pittore che non è Leonardo) di sconosciuto; come se l’autrice fosse per così dire implicita e assente al tempo stesso in questa scrittura in apparenza del tutto spoglia (la traduttrice americana ha parlato di “parole prigioniere”), quasi afona e tuttavia sorprendente, anzi diciamola tutta, non poco sconvolgente nella sua terrificante innocenza, che ci riporta in modo quasi inevitabile al ricordo di un avvenimento italiano e recente (vedremo quale). Ma intanto sarà da sottolineare come una inquietante forma di leggiadria sia innegabile.
Il romanzo narra una storia per così dire semplice: un doppio infanticidio, apparentemente immotivato. Berta, la protagonista, la madre omicida, nella sua ingenuità un po’ stuporosa è come una bambina, ha qualcosa di davvero leggiadro e di arreso. Ma uccide crudelmente i suoi due figli, il primo avuto da Rudolph, militare in licenza morto poco dopo sul fronte, il secondo da Wilhelm, il commilitone che le portò la notizia e le ultime parole del caduto.
Siamo nell’Austria post-bellica degli anni Cinquanta, in una (immaginaria?) cittadina che si chiama Donaublau, trasparente riferimento al celebre valzer di Strauss, che peraltro Berta, per il resto “sempre con la testa altrove, mai nel presente”, ama moltissimo. Non c’è nulla in lei e nella sua vita, però, dello spensierato “bel Danubio Blu”: al contrario i personaggi si muovono in un’atmosfera del tutto penitenziale, in un contesto di accettazione passiva (e di prosa impassibile), di resa a un’esistenza insopportabile perché “la vita, così dicono i saggi, sembra un male inguaribile”. Rovesciando i termini del praghese Kundera, che pure di questa cultura fa parte, siamo a una insostenibile pesantezza dell’essere.
Può interessarti anche
Strauss è l’elegiaca colonna sonora di una serie di tragedie senza lacrime. Berta parla pochissimo, reagisce pochissimo, sembra non tradire emozioni. Al massimo, il suo commento è un distratto “ecco, ecco”. Subisce le dolciastre vessazioni dell’amica più cara, che le succederà nel ruolo di moglie; non chiede nulla al marito, oltretutto anche lui decisamente passivo rispetto alle scelte della vita; resta chiusa in se stessa, non necessariamente in una malattia mentale; cerca disperatamente di educare i figli, non ci riesce. E uccide. Perché? Com’è ovvio l’autrice non risponde, lasciando la morte dei bambini stagliarsi nell’universo non emozionale dei personaggi – o forse là dove le emozioni sono troppe profonde e devastanti per essere verbalizzate.
L’amica implacabile e persecutrice sembra ripetere come un mantra la voce della società o della vita stessa, ipocrita, mielata e violenta; le recita sinistre consolazioni, luoghi comuni da cui Fritz trae risonanze feroci: “Tu eri già da sempre un po’ disgraziata. Già da bambina, no? Adesso finalmente tutto questo non c’è più. Te lo sei ben meritato”. E mentre “Berta ridacchiava” continua il suo rosario feroce: “Già. Già. Questa malefica malattia. E i tuoi figli adesso stanno anche meglio lassù presso il Signore Iddio. Perché erano proprio dei poveracci, troppo fragili”. Ancora: “Ci penserà il Signore Iddio. Lui sa che non ne hai colpa. Lui se ne intende. Povera, povera piccola! Povera, povera Berta! Com’è possibile essere così disgraziata”.
Può interessarti anche
Ma veniamo, a questo punto, in Italia: dove il romanzo così claustrofobico, variamente accostato a esempi quasi d’obbligo come Musil o Joyce, potrebbe avere inattese risonanze. La storia non può infatti non richiamare alla mente il caso di una madre infanticida – e di un padre che proprio come Wilhelm, ma si direbbe con maggiore consapevolezza, continua a esserle vicino anche dopo la condanna – che ebbe anni fa un’eccezionale copertura mediatica, con tanto di plastico della scena del delitto (la celebre “villetta di Cogne”) esibito e studiato in un noto talk televisivo in un delirio di insistenza parossistica. Quel delitto, come altri, al limite delle follia ma di una follia inspiegabile e priva di connotazioni manicomiali (in fondo decidere che qualcuno è “pazzo” procura pur sempre agli altri una sorta di sollievo), una follia quieta, sbiancata, non cessa di interrogarci sulla nostra e altrui illusione di “normalità”. Marianne Fritz ce ne propone, nel suo misterioso e labirintico libro, un’immagine spaventosa ed esatta – l’occhio pietrificante della Medusa.
Quanto al paragone con Joyce – che da Gente di Dublino passa attraverso Ulisse all’elettrolisi verbale di Finnegans wake, l’accostamento è suggestivo ma sembra davvero poco convincente, trattandosi da una parte di un’esplosione della materia verbale, dall’altra, qui, di un’implosione, nonostante le migliaia di pagine a venire: ma è interessante per quanto riguarda i racconti di Gente di Dublino, dove una scrittura scarnificata evoca una paralisi (morale, sociale, economica). Anche in Marianne Fritz siamo in una zona tematica simile, in una esplicita storia della paralisi che, anche attraverso una sintassi narrativa niente affatto lineare, coinvolge le parole stesse con le quali si cerca, riuscendoci talvolta magistralmente, di affrontarla a viso aperto: ovvero, rischiando molto (rischiando tutto?), di fissare lo sguardo su ciò che si sottrae.