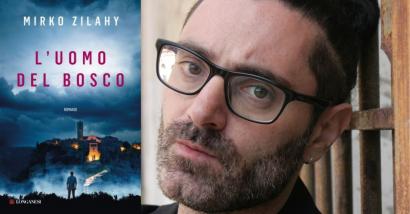“Cosa ci facevo io, una ragazza a malapena trentenne che da due anni viaggiava per il mondo senza una casa, con due figli e un compagno che dormivano insieme su un matrimoniale a qualche centimetro da me, seduta all’alba davanti una vetrata a New Delhi?” – In occasione dell’uscita del suo primo romanzo, “Se due che come noi”, su ilLibraio.it l’autrice Micaela Miljian Savoldelli (@likemiljian) racconta delle primissime righe che ha scritto della sua storia, una mattina in cui si trovava in un albergo in India…
Accadde una mattina a New Delhi. Mi svegliai molto presto, prima degli altri. Socchiusi gli occhi e la camera era buia. Un solo fascio di luce filtrava dalla tenda spessa e senza nemmeno farlo apposta illuminava i bagagli lasciati aperti sul pavimento dalla sera prima.
Eravamo atterrati all’aeroporto Indira Gandhi nel tardo pomeriggio, dopo un paio di voli cancellati e di vicissitudini inattese. Avevamo preso i bambini in spalla e ci eravamo fatti strada tra la folla di gente ammassata agli arrivi – donne con sari colorati sulla testa che tenevano in braccio figli dell’età dei nostri, autisti con il cartello, intere famiglie accampate a terra che ci fissavano con occhi scuri e profondi.
Eravamo saliti sul primo taxi. Chiusa la portiera l’auto era sfrecciata lungo una strada larga e asfaltata. Poi eravamo rimasti imbottigliati nel traffico, tra carri di animali, rickshaw, motorini con a bordo due, tre, quattro persone. Eravamo in India, e ogni nostro senso lo imparava insieme a noi. Ancora oggi se chiudo gli occhi riesco a risentire quell’odore unico, acre e penetrante, capace di riportarmi subito lì.
Può interessarti anche
La prima cosa che facemmo appena arrivati in hotel fu tirare la tenda e guardare fuori. Un gesto automatico diventato abitudine durante il nostro viaggio, dopo ogni check-in. Ma era già notte, e della città al di là del vetro non si vedeva quasi nulla. Dall’esterno giungevano attutiti i rumori della strada, la musica, i clacson. Riuscivamo a scorgere solo i movimenti nello spiazzo ai piedi del hotel, dove nell’arco di poco più di dodici ore vennero montati e smontati interi palazzi, tavoli e carrozze; tutto l’allestimento per un matrimonio.
Quella notte, la nostra prima in India, fu come dormire dentro un film di Bollywood.
Può interessarti anche
Ma ancora non avevamo scoperto niente. Per questo la mattina seguente, preparato un caffè in polvere, di quelli in busta che si trovano negli hotel, mi infilai dietro la tenda, accompagnata dal ritmo dei respiri di Julien e dei bambini. Rimasi a contemplare quello che si vedeva al di là della vetrata immensa che divideva la nostra camera al ventesimo piano della periferia di Delhi con il resto del mondo. La risposta fu quasi paradossale. Niente.
Non si vedeva niente. La città era coperta da una nuvola bassa e densa, color ocra, fatta di smog e nebbia. Come la sera precedente, l’unica cosa che riuscivo a vedere erano i resti del matrimonio. Carte, tabelloni, rifiuti colorati: una sorta di dipinto incompiuto. Non avevo idea di dove mi trovassi. Non c’era niente che potessi riconoscere. Eppure, sapevo che lì sotto c’era una città. Mi sentii persa, quasi frastornata. Rimasi così per un po’ a guardare fuori con le mani strette sulla tazza bollente.
Così accadde. Quella sensazione mi avvolse, la sentii dentro, come un brivido ghiacciato.
Può interessarti anche
Dov’ero? E perché ero lì? Cosa ci facevo io, una ragazza a malapena trentenne che da due anni viaggiava per il mondo senza una casa, con due figli e un compagno che dormivano insieme su un matrimoniale a qualche centimetro da me, una lattina di Coca-cola e dei pastelli a cera accanto ai passaporti, nell’aria l’odore secco e artificiale dell’aria condizionata, seduta all’alba davanti una vetrata a New Delhi?
Decisi che il mio libro volevo cominciarlo proprio da lì. No, non dall’India. Non da New Delhi. Dalla sensazione che provavo in quel momento. Dal completo spaesamento.
Volevo scoprire come era possibile, e perché lo era stato. Sentii una storia che mi chiamava: sarei partita da lì. Così infilai la mano tra la tenda e la finestra, presi dalla scrivania il primo pezzo di carta che mi capitò sottomano – decisamente poco affascinante, era lo scontrino di un pacchetto di patatine comprato in aeroporto – e scrissi le prime tre cose che mi vennero in mente.
“La scrittura è l’ignoto. Prima di scrivere non si sa niente di ciò che si sta per scrivere e in piena lucidità” diceva Marguerite Duras, una delle mie autrici preferite. Quando cominciai a scrivere Se due che come noi, però, non le credetti. Pensavo che non ci potesse essere niente di sorprendente in una storia ispirata alla mia. Sapevo già dove andava a finire.
Può interessarti anche
Poi ho incontrato il flusso della scrittura. Spettatrice del suo potere mistico, tanto formidabile da spingermi al limite dell’assurdo, ho visto rinascere Selvaggia e Jules sotto le mie dita, senza che davvero io potessi fare nulla per impedirlo. Quella era la loro storia. Io ero giusto l’amanuense, lo scribacchino, la dattilografa seduta alla scrivania. Loro si raccontavano a me, e io, raccontavo di loro, scoprivo universi inesplorati di me stessa.
Se due che come noi è stato scritto in uno slancio intrattenibile. Di notte appuntando idee su un taccuino, per ore seduta su una poltrona in rattan in un warung tra le risaie di Bali, allattando, seduta su qualche marciapiede guardando il traffico, con i miei bambini sulla schiena e i loro giocattoli ai piedi.
Le risposte alle domande che mi guidavano nella scrittura della storia arrivavano all’improvviso, chiacchierando in cucina con Julien, preparando i bambini, osservando la gente, osservando la nostra maniera di osservare. Ascoltando la musica, cercando tra vecchie fotografie, nei libri.
Può interessarti anche
Cosa accade quando due ragazzi a malapena ventenni si incontrano una sera, si cadono quasi addosso e si stravolgono? Lo spaesamento, ecco cosa accade. Da lì doveva cominciare la storia che mi bruciava dentro, che bussava.
Cosa succede se la vita scorre come un treno e dal finestrino si vedono solo panorami sfuggenti, e per afferrarne uno bisogna tendere il braccio e sfondare il vetro, a costo di farsi male?
Succede che si vive. E le immagini si succedono come scenografie sullo sfondo di un palcoscenico. Una dopo l’altra, si fanno spazio, anche nella densa nebbia di New Delhi.
L’AUTRICE E IL LIBRO – Micaela Miljian Savoldelli, classe 1988, è italiana di nascita, parigina d’adozione e cittadina del mondo per vocazione. Per tre anni ha fatto il giro del mondo con il suo compagno di vita e due figli, diventati tre lungo il percorso. Autrice, direttrice creativa e imprenditrice, è la penna del profilo social @likemiljian. A breve lancerà la sua linea di abbigliamento etico e sostenibile ispirata alle donne e al viaggio. Ora vive a Bali.
Se due che come noi (Vallardi) è il suo primo romanzo, ed è ispirato a una storia vera d’amore e di rinascita, fino ai confini del mondo. Un’ode generazionale al coraggio di cambiare vita, anche quando sembra impossibile.
Quando Selvaggia arriva a Firenze, infatti, ha vent’anni e un passato scomodo. È scappata portando con sé solo un bagaglio di dilemmi e irrequietezza, per vivere appieno quelli che è convinta saranno gli ultimi anni della sua vita. Jules è francese, ama suonare la chitarra di notte a cavalcioni sul terrazzo e ogni giorno cambia itinerario, alla ricerca dell’inaspettato. Che puntualmente arriva, per entrambi, la sera del 24 ottobre 2009, in una serata tra amici, musica e blackout.
Selvaggia e Jules non sanno cosa li aspetta, ma il destino ha già deciso per loro. E quando la vita li metterà di fronte alla prova più dura, proprio nel momento che per tutti gli altri è il più sbagliato, Selvaggia e Jules decideranno di seguire il proprio istinto e partire per realizzare quello che devono a se stessi, un’avventura schietta e dolce, nata da una promessa scambiata all’alba: qualsiasi cosa accadrà, non smetteranno mai di credere alla magia di quella sera…