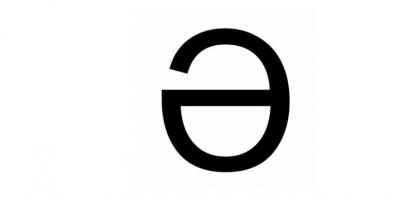“Per provare a ragionare su come si costruisca letterariamente una voce non binaria, ho interrogato il mio corpo. Come si muove nello spazio sociale il corpo di una persona queer. È un corpo che si muove fluido e scattoso, invisibile e costantemente additato, aggredito dagli sguardi e dagli sguardi accarezzato, è un corpo solo e fragile, si muove con timore, si muove con spavalderia, si muove con rabbia, si muove senza grazia. È un corpo sempre fuori contesto, è un corpo indisposto, cioè posto nel posto sbagliato, perché un posto giusto, per questo corpo, non c’è. E poiché la lingua è innanzitutto voce, è visione che si fa vibrazione per riempire l’aria e incontrare l’altrə, una soggettività non binaria non può che narrare il mondo al modo in cui il suo corpo ci vive, in questo mondo”. Su ilLibraio.it la riflessione di Simone Marcelli Pitzalis, al suo esordio con “Questo è il corpo”, un romanzo raccontato da una voce narrante di genere non binario
Dalla lingua che crolla nasce un mondo
Sperimentare una voce narrante di genere non definito
Una voce è un mondo generato da un’esperienza calata nel corpo. La domanda “come si costruisce una voce narrante non binaria?”, frequentemente posta, è mal posta. L’unicità dei corpi rende inverosimile qualunque categorizzazione censoria delle voci narranti: le esperienze e le identità delle persone non binarie sono troppo variegate e mutanti perché se ne possa istituzionalizzare un codice narrativo. Del resto, quella non binaria è un’esperienza identitaria che si dà per negazione: è il gesto di disconoscimento del binarismo, artificio ideologico che informa e norma la realtà sociale, generando l’illusione – per alcune persone confortante, per altre angosciante, ma per tutte opprimente – di vivere in un mondo schiacciato su due dimensioni. In quanto ideologia, il binarismo ha la capacità di produrre codici e stilemi, rispetto ai quali le voci non binarie si pongono in rottura. Senza generare una norma alternativa, ma aprendo il varco sul vasto.
Come la costruisco una voce narrante non binaria. O meglio: come manifesto nel dispiegarsi di un mondo narrativo, costituito di e nella lingua, l’esperienza di una soggettività di genere non definito binariamente. Pormi questa domanda mi indispone, riceverla lo fa sempre. Ma ciò che ci indispone ci svela che siamo nel posto sbagliato. E in effetti ogni volta mi accorgo di trovarmi in un luogo errato del pensiero: quel posto comodo in cui ci infiliamo perché ci pare che lì queste domande non ci arrivino, che disperdano mute nell’amalgama vocale della comunità maggioritaria alla quale trasversalmente e parzialmente pure apparteniamo, ma ancora di più vorremmo appartenere. Il posto del pensiero in cui queste domande non risuonano è un posto sbagliato in cui pensare. Cos’è che mi indispone, appena prima di questa ri-presa di coscienza: l’idea che qualcosa da costruirsi sia più artefatto e posticcio, meno autentico. Ce l’abbiamo dentro, questa idea. E in definitiva che, se si tratta della mia voce narrante, in qualche modo a essere posticcio e non autentico sia anche io.
Può interessarti anche
Ricordarsi che qualcosa è da costruire addossa la fatica dell’arbitrarietà, e dunque timori di insensatezza e finzione. Viceversa, vorrei chiudere gli occhi e illudermi che ciò che dico è legittimo e naturale, non soggetto al mio arbitrio, non a quello altrui. C’è in effetti questo pregiudizio diffuso e orrendamente idealista che ciò che è frutto di artificio sia meno legittimo di ciò che è naturale, che ciò che è naturale sia garantito da una sorta di ufficialità ontologica. Fortunatamente la Natura non esiste, ma la civiltà nella quale siamo finge di non saperlo. La naturalizzazione delle soggettività sociali è funzionale a questo scopo: mettere al riparo dal dubbio i costrutti sociali, conservarne le strutture dotandole di un significazione inviolabile. E può capitare di dimenticarsi che, come strumento di conservazione, il principio di naturalizzazione è in mano al gruppo dominante: assolutizza il loro dominio, e inchioda ogni soggettività minorizzata alla propria sorte di minorizzazione.
Sono le lusinghe di uno spettro conservatore e ontologista. Mi dice, lo spettro: rilassati in questa notte docile, in cui ciascuno è chi pensa di essere, e i corpi non gettano ombre. Sono le lusinghe della naturalizzazione del proprio sé sociale. E allora mi risveglio. Aprendo gli occhi, la scena si ribalta: non solo il fatto che una voce vada costruita non la priva di senso o valore, ma anzi è ciò che la rende uno strumento reale di liberazione. Così, finalmente, questa domanda indisponente mi ricorda la natura performativa di ogni identità. Non solo delle identità delle soggettività minorizzate, ma di tutte le identità, anche di chi ricade nella fattispecie dell’essere umano prototipico: maschio, bianco, cisgender, eterosessuale, neurotipico e senza disabilità, borghese. Identità che del resto non sono mai entità solitarie e solipsistiche. L’identità è viceversa una verità relazionale: la mia identità a me è data dalla constatazione della mia non identità all’altrə, con cui contratto immagini reciproche prodotte dall’interazione delle nostre performance sociali. Ogni identità non è mai solo nostra, dunque, è vera e finta allo stesso tempo e ci costa sempre la rottura della totalità innominabile che ci tempesta dentro. Ogni identità è un’esperienza di alienazione.
Eppure, c’è qualcosa che non si trova nel mezzo, nella distanza tra me e te. Qualcosa di solo mio, di solo da questa parte, e non soggetto a contrattazione e alienazione. Il corpo. Il più potente strumento di affermazione, la nostra casa fragile. Tutto è costruzione, arbitrio e in ultimo architettura, ma in principio non era il verbo. In principio era il corpo. Da questo partiamo, a questo torniamo.
Può interessarti anche
Dunque per provare a ragionare su come si costruisca letterariamente una voce non binaria, ho interrogato il mio corpo. Come si muove nello spazio sociale il corpo di una persona queer. È un corpo che si muove fluido e scattoso, invisibile e costantemente additato, aggredito dagli sguardi e dagli sguardi accarezzato, è un corpo solo e fragile, si muove con timore, si muove con spavalderia, si muove con rabbia, si muove senza grazia. È un corpo sempre fuori contesto, è un corpo indisposto, cioè posto nel posto sbagliato, perché un posto giusto, per questo corpo, non c’è. Non c’è spazio libero in cui liberamente possa armonizzare i propri movimenti.
E poiché la lingua è innanzitutto voce, è visione che si fa vibrazione per riempire l’aria e incontrare l’altrə, una soggettività non binaria non può che narrare il mondo al modo in cui il suo corpo ci vive, in questo mondo. È una lingua che si muove fluida e scattosa, fugge come aggredita e sempre aggredisce, rancorosa; è una lingua sola e fragile, si muove con timore, si muove con spavalderia, si muove con rabbia, si muove senza grazia. È una lingua sempre fuori contesto, è una lingua indisposta, cioè posta nel posto sbagliato, perché un posto giusto, per questa lingua, non c’è.
È proprio la lingua che dovrà provare a smarcarsi da questa esperienza tutta al negativo, per creare un mondo di affermazione. Ma la lingua nostra è la lingua comune, è la lingua a noi inutile, è la lingua che ci esclude. Questa abbiamo, nostro malgrado. La lingua per affermare un mondo nuovo, come ogni lingua genera ogni mondo, non esiste ancora. Tentiamo di crearla in uno spazio già saturo di traumi, violenze e negazioni: di questa materia si compone, per ora, questo linguaggio. E di speranza e di rancore, e di gioia, anche, della gioia che suscita il mollare gli ormeggi. È una lingua mostruosa.
Può interessarti anche
Gioia, dicevo. La gioia riservata a chi riceve in sorte un’esistenza minorizzata. È croce ed è grazia: perché chi è scacciato da ogni luogo può abitare qualsiasi luogo, perché chi è privato di spazio lo può possedere tutto, lo spazio, invadendolo. In altri termini, la privazione di identità può essere condizione di libertà, se al di là della cella umida che il potere ci riserva fluiamo liberamente in ogni dove. Tutto diventa campo di battaglia, tutto è mare aperto, seppure in burrasca, e orizzonte di sperimentazione. Invisibilizzazione, silenziazione, scherno, minaccia, paura, violenza, questi e altri demoni ci tormentano ma ci costringono a percorsi di consapevolezza e liberazione che sono la grazia inestimabile di poter vivere attivamente i processi performativi che sono alla base dell’esistenza di ciascuna soggettività, minorizzata o meno. Viverli coscientemente, da protagonistə.

Simone Marcelli Pitzalis
E la letteratura, dunque?
La letteratura è funzione generatrice di mondi e immaginari. Come tale, è sempre e intrinsecamente performance di una soggettività, individuale e collettiva, che dispiega valori, paure, desideri. Se è così, il linguaggio e i suoi prodotti sono primario terreno di conflitto ed esplorazione. La soggettività non binaria o di genere non definito, infatti, vive una condizione tragica: la verità del suo corpo e della sua esperienza più intima non è pronunciabile dalla lingua che la comunità le consegna. L’insieme di desideri, funzioni e pulsioni che informano il suo corpo e la sua identità sono un mondo in potenza che spinge per essere manifestato, ma a questa soggettività sono negati gli strumenti cognitivi e simbolici per farlo. Del resto, la lingua è fatto comunitario: serve che intorno al fuoco si raccolga una comunità che condivide una storia, affinché il prodigio della narrazione manifesti attraverso le parole un orizzonte di senso che rinnovi l’esperienza della relazione con il buio che li circonda, pochi passi oltre il cerchio di luce del falò, e con l’alba che ne seguirà. Se una comunità queer esiste – ed esiste e la sua voce si alza sempre più chiara – è lo spazio per l’adunanza a mancare. Manca perché ci è sottratto: ogni spazio – cognitivo, linguistico, sociale, urbano – è già occupato dal patriarcato borghese, binario ed eteronormativo, bianco, abilista. Sua è la lingua, sua è la scena. Questa stessa lingua noi parliamo, con questa stessa lingua noi generiamo i nostri pensieri: ma è una lingua ormai morta, imputridita e inutilizzabile.
Può interessarti anche
Con uno strumento così povero e corrotto, come possiamo manifestare in positivo in un orizzonte di immaginario condiviso questa nostra esperienza?
Se la letteratura ha una funzione, o delle funzioni, ha di certo quella di riabilitare la lingua al linguaggio, cioè a formulare ipotesi di mondo condivise. Una voce narrante di genere non definito, col suo tartagliante e ossessivo masticare ciò che narra, con il suo lanciarsi e inciampare e lanciarsi e inciampare, agisce come dispositivo di autodistruzione della lingua che gli è stata concessa. Come funzione tumorale del linguaggio, che dall’interno fiorisce in metastasi che rendono evidente la patologia della lingua convenzionale e ineludibile la nostra consapevolezza che qualcosa di alternativo s’ha da fare, affinché i confini di ciò che la lingua sa agire siano finalmente resi più vasti. Il lavoro letterario è spazio privilegiato di frattura di uno stato di oppressione, così come lo sono i nostri corpi. In principio è la carne.
In questo processo, è possibile che siano formulate delle ipotesi operative. Per esempio lo schwa. Può (già) avere un utilizzo letterario? Personalmente, lo utilizzo convintamente e in modo militante negli altri registri comunicativi, ma non (ancora) in quello letterario. E non perché non ne abbia dignità. Un mondo letterario è la sua lingua, e la sua lingua è il suo punto di vista: questa sostanza letteraria complessa chi narra la genera relazionandosi a quell’esperienza linguistica e culturale comunitaria cui ancora non ha accesso. Si tratta appunto del presupposto mancante del mondo linguistico che ho tentato di generare, come è mancato nel mondo in cui chi scrive è cresciutə, facendo un’esperienza identitaria tutta al negativo. E quindi la forza letteraria messa in campo ora è una forza gioiosamente e dolorosamente distruttiva, che si esalta alla vista del crollo della propria prigione. Su queste macerie ci raccoglieremo, accenderemo un fuoco, e continueremo a narrare. Ne nasceranno cose nuove, e nuovi spazi che riempiremo con la lingua di domani. Questa lingua saprà dirci tuttə, magari utilizzando schwa, o chissà quale altra soluzione inclusiva. Racconteremo nuove storie e nuovi mondi, vedremo la luce di nuovi giorni.

L’AUTORE E IL LIBRO – Simone Marcelli Pitzalis è nato a Cagliari nel 1991, e scrive in prosa e in versi. Tra i suoi lavori poetici, Archivio privato (Zona, 2018), vincitore del Premio Nazionale Elio Pagliarani, mentre i suoi racconti sono usciti su varie riviste letterarie e pubblicati nell’Almanacco 2017 (Quodlibet) e nella raccolta La Grande Estinzione del collettivo TINA (Aguaplano 2021).
Il suo primo romanzo, Questo è il corpo (effequ), è raccontato da una voce narrante di genere non binario, in una costante riflessione sull’identità e sul corpo.
La protagonista è Veronica, giovane ragazza transgender, che si è stabilita a vivere con altre persone in un capannone occupato, ai margini di una città ormai del tutto votata al turismo e popolata da un’umanità meschina. In uno scenario italiano subtropicale, fatto di curiose specie animali e vegetali, nuove persone venute da lontano, nuovi modelli di vita, un giorno Veronica viene trovata in stato catatonico: non ci sono segni di violenza sul suo corpo, soltanto assenza sul suo viso, e nessuna traccia utile a dare spiegazioni.
Si indagano le ragioni dell’accaduto, ma il violento equilibrio del paese sta per crollare, e il mistero del martirio della ragazza è nelle mani delle Matrone, sacerdoti di un misterioso e spietato culto che promette di preparare il terreno per un mondo nuovo.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it