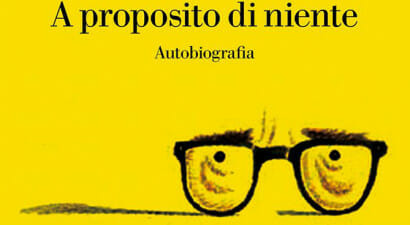Woody Allen, alla soglia dei 90, lavora, nel suo primo, tardivo romanzo (dopo una vita prolifica di sceneggiatore e regista, autore di racconti comico-filosofici, nonché di un recente memoir), sugli ambienti e i registri del suo cinema, che siamo ormai abituati a ri-conoscere, e ad “abitare” comodamente: la maschera autobiografica di un sé, giusto un po’ più giovane e meschino, “nel mezzo del cammin della sua vita”, dalle ambizioni artistiche frustrate, misantropo, con moti depressivi cosmici e una vita sentimentale incastrata in schemi di nostalgia e frustrazione. “Che succede a Baum?” ha per protagonista uno scrittore in crisi, assalito da un’ansia pervasiva, ipocondriaco per principio, soffocato dall’invidia per il successo altrui…
Asher Baum è a pezzi. La cover originale segue alla lettera, a differenza dell’elegante cover grafica italiana di La Nave di Teseo, le parole del protagonista, figurandone l’esistenza (non proprio) da urlo: “si immaginò […] in un a quadro di Edward Munch, con le mani sulle orecchie e la bocca spalancata”.
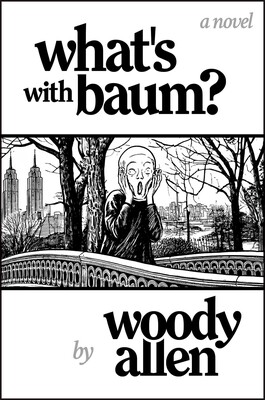
La copertina dell’edizione americana
Passati da poco i cinquanta, scrittore fallito e velleitario (ma “tetragono nel rifiuto di svendersi”), con la vocazione per temi grandiosi e la propensione per il lamento, Baum vede il suo matrimonio, oltre che la carriera letteraria, in netta crisi, con la moglie Connie disillusa rispetto alla fascinazione mal riposta in questo intellettuale newyorkese pessimista, insoddisfatto e risentito.
Baum trattiene a stento l’invidia per il figliastro Thane, che lei al contrario adora e che sta conquistando, con il suo esplosivo romanzo d’esordio, critica e lettori. Inutile dire che lui trova il giovane astro nascente adulato da tutti pretenzioso, superficiale e insulso, e il trasporto materno una questione di cecità pressoché edipica. La realtà s’incaricherà di dargli qualche ragione ma non molte soddisfazioni.
Può interessarti anche
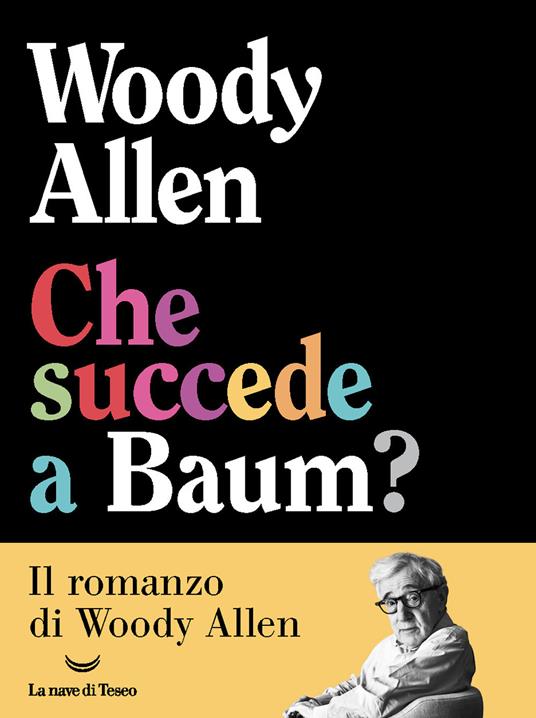
Può interessarti anche
Lo scrittore in crisi di questo Che succede a Baum? è assalito da un’ansia pervasiva, ipocondriaco per principio, soffocato dall’invidia per il successo altrui, assediato da fantasmi di gelosia per la moglie (che immagina a letto con suo fratello e ogni maschio nei paraggi) e, nello stesso tempo, perseguitato dalle ombre di amori passati e idealizzati, che gli sembra di riconoscere nelle giovani donne che gli capita di incrociare e sulle quali fantastica fughe romantico-regressive (peccato che la giornalista culturale con cui flirta legge le sue attenzioni come molestie, e la fidanzata del figliastro, che pare la copia di una vecchia fiamma, per quanto ben disposta nei suoi confronti, ne coglie in pieno il tratto invidioso).
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
Woody Allen, alla soglia dei novanta, lavora, nel suo primo, tardivo romanzo (dopo una vita prolifica come sceneggiatore e regista, autore di racconti comico-filosofici, nonché di un recente memoir), sugli ambienti e i registri del suo cinema, che siamo ormai abituati a ri-conoscere e “abitare” comodamente. La maschera autobiografica di un sé, giusto un po’ più giovane e meschino, “nel mezzo del cammin della sua vita”, dalle ambizioni artistiche frustrate, misantropo, con moti depressivi cosmici e una vita sentimentale incastrata in schemi di nostalgia e frustrazione, esprime un desiderio mai soddisfatto di tornare a un passato mitizzato e un nichilismo stemperato dall’ironia di fondo che non possiamo non identificare con l’humus ebraico-psicanalitico che ben conosciamo (dice del protagonista, nell’ottima traduzione di Alberto Pezzotta: “l’unica cosa che Baum fosse disposto a cambiare era l’analista“) .
Tutti i topoi del Woody Allen autore cinematografico – l’amore per una New York da sogno, “una città carismatica che lo teneva ancora nella sua morsa”, e l’avversione per la stagnazione annoiata della campagna, le mappe sentimentali dell’Upper East Side e quelle dei riferimenti culturali mitizzati, da Kafka a Parigi, da Kant agli scrittori russi dell’800, la paura di tutto e l’eros della conquista, le ambizioni artistiche e lo sguardo al modello europeo e alle età dell’oro – tornano in queste pagine confortevoli e divertenti, anche se non sempre geniali, che rievocano gli splendori e le atmosfere della sua filmografia ricchissima, con molto mestiere e un filo di maniera.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
Se la vena autoriale alleniana filmica sembra essersi un po’ ridimensionata con l’età e l’iperproduzione, dando luogo a esiti in sala non sempre all’altezza della sua stagione migliore, nelle conversazioni/soliloqui di Baum, che parla da solo (“Non posso più confidarmi con nessuno. Solo con me stesso“) ed esprime insoddisfazione, desideri e fantasmi, ansie e ideali, con humor e acume, ancora si rinviene il senso preciso della battuta (i one-liner che hanno reso Allen famoso, derivato ed eredità della sua gavetta stand-up comedian), la capacità di raccontare con brio i waltzer amorosi e le impasses intellettuali di una New York che (r)esiste ancora, con un retrogusto che è inventato e credibile insieme.
Dietro la montatura degli occhiali di questo cineasta divenuto aggettivo, al quale per molti non è mai difficile ancora volere bene, si nasconde l’attitudine di uno scrittore capace di autoironia e disillusione (“La gente non legge più, e di certo non libri di narrativa”), che gioca coi suoi limiti (“l’inerzia è una delle forze più potenti della fisica”) e riesce ancora a fare delle sue nevrosi un racconto in cui specchiarsi. Il tutto con un finale “scoppiettante” dagli echi cechoviani, diciamo (senza troppo spoilerare), a colpi di pistola.
Pallottole su Broadway fischiano ancora, dunque.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati