Con “Atti di un mancato addio”, Giorgio Ghiotti ritorna alla prosa con una narrazione che si dimena tra legami e solitudini. Quelle di Massi, Cecchi, Trottola, Fabrizia e Mastino, infatti, sono esistenze appena sbocciate fatte dei sogni puri e violenti della giovinezza, per lo meno fino a un preciso momento, quello in cui Giulio, uno di loro, scompare – Su ilLibraio.it un estratto
Il cielo di Roma è così azzurro da ferire gli occhi, è una madre a cui fare ritorno, una lupa che sfama un gruppo di giovani appena ventenni.
Con Atti di un mancato addio, in uscita per Hacca Edizioni, Giorgio Ghiotti, autore classe 1994, ritorna alla prosa dopo Gli occhi vuoti dei santi (Hacca Edizioni, 2019), che lo aveva portato in finale al Premio Flaviano, con una narrazione che si dimena tra legami e solitudini.
Quelle di Massi, Cecchi, Trottola, Fabrizia e Mastino, infatti, sono voci giovani e affamate di vita: uomini e donne, affacciati all’età adulta e giunti nella Capitale da provenienze diverse, che si muovono tra scorci urbani della città e sconosciuti paesaggi intimistici.
I protagonisti di questa storia crescono come fanno i lupi, oscillando tra l’istinto del branco e il bisogno di solitudine. Esistenze appena sbocciate fatte dei sogni puri e violenti della giovinezza, per lo meno fino a un preciso momento, quello in cui Giulio, uno di loro, scompare.
Sarà proprio questa assenza e il suo mistero a costringere i protagonisti a mettere in pausa le proprie vite e, solo per un attimo abbicinante, provare a cercarlo, almeno nella loro memoria. Ghiotti stabilisce così un fitto dialogo tra i luoghi geografici e quelli interiori, avviluppati in una narrazione in cui la giovinezza e le presenze vengono comprese attraverso le mancanze.
Fra le pagine del romanzo, si esperisce quindi il tentativo di riconciliazione con la perdita: il tempo delle ricerche diviene un viaggio a ritroso, una perlustrazione della memoria che riporta alla luce fantasmi e paure. Così, il tempo dell’attesa si sfilaccia a poco a poco in immagini e sequenze, in ricordi sempre meno nitidi…
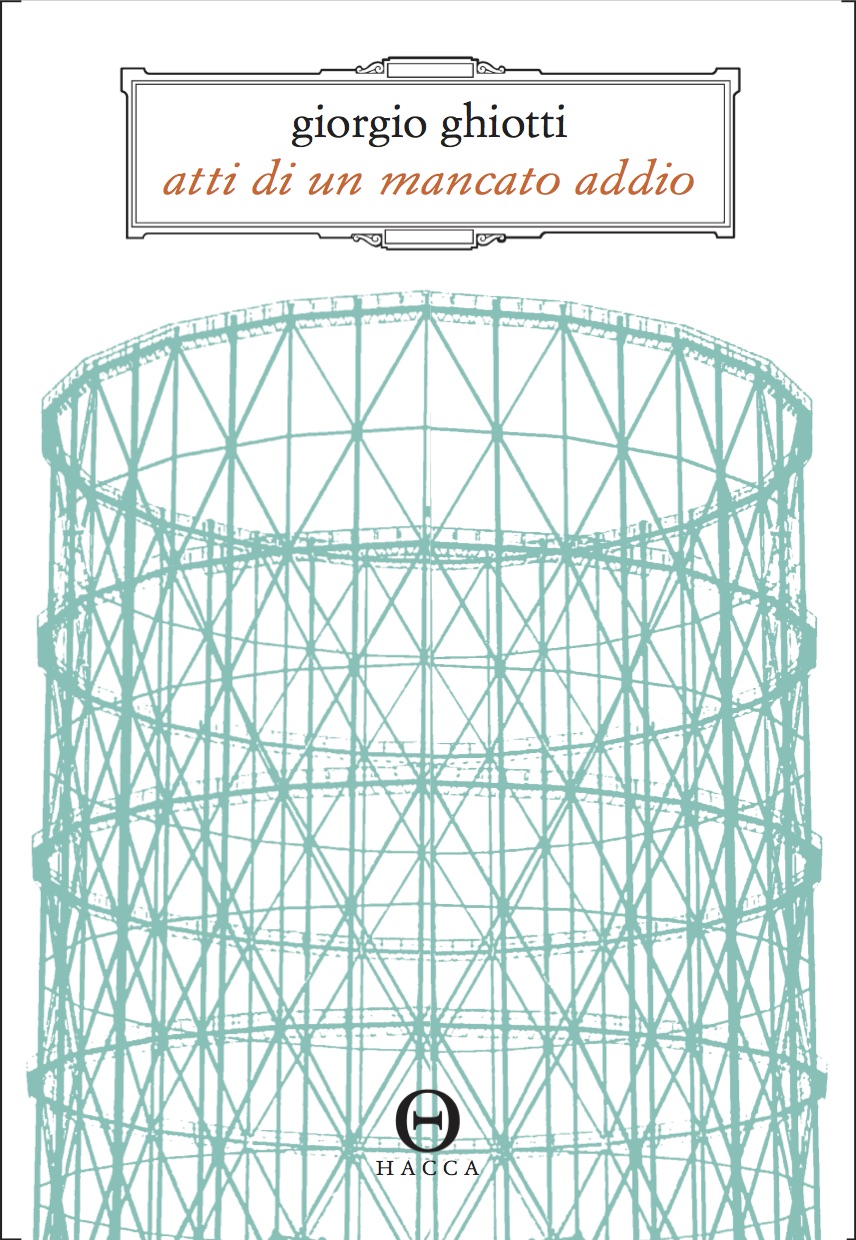
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un estratto:
Vissi un’estate oziosa lontana dal breve incubo delle telefonate notturne dei tredici anni, archiviate dalla memoria del mondo come una bravata di ragazzi.
Passammo le vacanze nella villa al mare. Ozioso com’ero potevo dedicarmi ad ardimentose passeggiate sugli scogli, esercitandomi nel saltare dall’uno all’altro come un gatto espertissimo, una fede totale nell’equilibrio. Mia madre scendeva poco in spiaggia per via di quelle sue gambe sceme sempre imbrigliate in calze spesse come tavolette di burro. Mio padre aveva in odio la crema, la sabbia, il vociare dei ragazzini e dei venditori con quelle torri di venti cappelli impilati sulla testa bracciali e orecchini di conchiglie, e metteva il naso fuori casa solo dopo le sei del pomeriggio, per passeggiare lungo la ciclabile fino al castello, le mani intrecciate dietro la schiena.
In tutto quell’ozio però mi capitava di cadere senza un motivo, spinto al suolo da lacci invisibili o spiriti dispettosi. Tornavo a casa con dei graffi sui palmi delle mani e dei lividi scuri alle gambe, alle braccia. Mio padre diceva che ero un rincoglionito, pieno di distrazioni e per questo inciampavo di continuo, e non escludo sia vero perché a sedici anni, ricordo, pensavo moltissimo a delle cose enormi e fondamentali, almeno a me sembravano enormi e fondamentali, cioè il destino dio la natura e sopra ogni cosa l’amore, chiedendomi dove mai si nascondesse, e cosa volesse dire, se una felicità sotterranea e lunghissima o un brivido solo, un picco, di notte davanti al mare con i piedi affondati nella sabbia e l’uccello in un corpo caldo di voglia e di sole accumulato come una serra. E il pensare a tutte quelle cose enormi e fondamentali mi procurava un benessere segreto che per un mese pensai “Studierò Filosofia”, ma i desideri sono desiderabili solo se momentanei, e tanto più urgenti se brevi. Non avevo ancora fatto all’amore e pretendevo di capire la vita.
Può interessarti anche
Mia madre, per quel mio cadere senza un motivo mi portò a fare delle analisi del sangue al laboratorio in via San Rocco, sul lungomare. Era una cosa strana vedere in una sala d’attesa tutte quelle ciabatte da villeggiatura, infradito o a fascia e tra le dita granelli di sabbia che grattavano sul pavimento a camminare nella saletta spoglia, una pala sul soffitto a girare lentissima.
La dottoressa del prelievo fu un piccolo miracolo, forse islandese, di una bellezza proprio islandese, da chiederti “Che c’entra lei con questi stronzi seduti in sala d’attesa, che c’entra coi loro corpi puzzolenti di acqua di mare e creme, pelli grasse e scottate, e cosa c’entro io con te, angelo del sangue” – e fu così che entrò a far parte anche lei di tutto quel mio ragionare dei sedici anni, sull’amore la vita e i sogni che speri sempre accadano e invece dopo un certo tempo non ci speri più, e a poco a poco dimentichi.
Ero sano e ozioso più che mai, ora che pure l’ombra di una potenziale malattia s’era diradata. Mi occupavo del cielo, studiando il vento e le traiettorie degli uccelli, chiedendomi se invecchiare sarebbe stato così: un ragionare continuo senza coda, le notti più brevi, il sonno leggero rotto da un sogno trasformato in pensiero.
Una settimana dopo le analisi mi spinsi fino alle rocce rosse a picco sul mare, con spiagge isolate di sassi ed erbe selvatiche seccate dal vento e dal sale. Mi arrampicai su uno scoglio basso, piatto, un gioco da ragazzi non fosse stato per le alghe che lo ricoprivano quasi per intero, perfettamente mimetizzate. Scivolai e presi una storta al piede, mi sbucciai le ginocchia. Mi veniva da ridere e da piangere insieme, da piangere per il dolore e l’umiliazione di quella natura che mi pareva di conoscere bene e d’esserci amico, e da ridere perché ero proprio così da ragazzino, i ginocchi eternamente colorati da quelle toppe di sangue e carne viva, poi marroni di croste.
Zoppicando raggiunsi la spiaggetta accanto dov’era più facile buttarsi in acqua perché una striscia di sabbia finiva dritta nel mare e formava una secca. Avanzai fino alle caviglie per disinfettarmi i ginocchi e vidi una vecchia in un costume intero, piegata, a riempirsi le mani di acqua e portarle alle ginocchia per disinfettarsi due ferite aperte proprio identiche alle mie. Sembrava una bambina, vergognosa di farsi vedere debole, sbucciata, stringeva i denti per il bruciore del sale. Allora anch’io ho preso a sciacquarmi le mie ferite e a stringere i denti, ma lo stesso mi uscirono dei lamenti mezzo comici dalla bocca. Abbiamo riso entrambi, lei con una risata da bambina io con una risata da adulto, e subito mi è venuto da pensare, per quel mio ragionare continuo, che l’avrei potuta invitare a cena come una fidanzata, e farci dei discorsi enormi e fondamentali, per esempio sulla vecchiaia e la morte, ma era un tramonto così bello e struggente quello che ci colpiva la fronte che lasciai perdere e mi tuffai nel mare nuotando per dei minuti interi che quando sono riemerso, ed era scomparso anche il dolore per le ferite, la vecchia non c’era più. Forse era una sirena, doveva trattarsi di una sirena.
Può interessarti anche
Giulio, Massi, Cecchi e Trottola li ho conosciuti qualche anno più tardi, all’università “La Sapienza”. Meglio: fuori dall’università, perché pure se eravamo tutti iscritti a una facoltà (Cecchi, già prima di dare microeconomia, amministrava alacremente il suo conto Posta per via di Fatima e del loro futuro insieme, Trottola Scienza Politiche, Massi sarebbe diventato un biologo perché a Medicina non aveva passato il test e “un biologo ci vuole sempre!”, Giulio fermo al quarto esame di Matematica io sulle scale di Lettere a sfumacchiare con un libro aperto sulle ginocchia), anche se eravamo già iscritti a una facoltà, dicevo, preferivamo passare il tempo nella camera di Giulio. Una casa di studenti, tre, lui e altre due ragazze che ci hanno sempre guardati con disprezzo. Soprattutto Roberta, e non ne aveva il minimo diritto, fidanzata con un buttafuori iscritto a CasaPound.
In molti ci siamo chiesti, anche quando questa storia trovò il finale assurdo che ebbe e la faccenda venne archiviata, perché Giulio avesse scelto Matematica. Non ho tesi al riguardo da esporre. Se non questa: che Giulio non era in grado di ragionare fuori dalle certezze e le certezze sentimentali erano in lui più solide di quelle matematiche. Per questo anche ora non mi abbandona il sospetto che lui sapesse già tutto, che per quanto negasse a sé stesso un coinvolgimento emotivo si era già accorto da prima che la cosa gli era sfuggita in un certo senso di mano, e questo era così distante dalle sue attitudini. Perciò aveva scelto di studiare Matematica, perché la matematica dice “esiste la felicità” e la poesia “probabilmente esiste un mondo in cui noi potremmo essere felici.” Fallire quella possibilità era la sua ossessione.
Viveva in affitto in una palazzina costruita poco dopo che il quartiere aveva sventato il pericolo delle bombe scese su San Lorenzo, e da allora non era mai stata ristrutturata anche se qualcuno giurava di sì. La notte del terremoto si aprì una crepa sulla parete per tutta la lunghezza del corridoio. Sta ancora qui, sul muro umido e gonfio, a memoria di noi. Certe mattine è talmente bella, la crepa, un tatuaggio sul corpo. Si potrebbe cancellare, rimuovere. Se ne dovrebbe avere la forza. Quanto sono pigre queste vecchie case che ci hanno abitato.
Giulio?
Chi?
Giulio.
Ah, quello che un giorno ha camminato sulla Tiburtina, camminato camminato e non è tornato più indietro.
(continua in libreria…)
Fotografia header: GettyEditorial 23-08-2021





