“In altre parole” è un saggio che spiega quanto sia importante curare il linguaggio, dedicare attenzione alle parole quando si tratta di inclusione. Partendo dalla neurodiversità, di cui l’autore Fabrizio Acanfora, autistico, è profondo conoscitore e divulgatore, si esplorano le parole che costellano tutte le forme di diversità: culturali, religiose, sessuali e di genere, legate alla differente funzionalità fisica – Su ilLibraio.it un estratto, dedicato all’autorappresentanza
Curare il linguaggio, dedicare attenzione alle parole quando si tratta di inclusione è fondamentale. Lo spiega dettagliatamente Fabrizio Acanfora, napoletano classe ’75, nel suo saggio In altre parole (effequ).
Dopo aver vinto il Premio nazionale di divulgazione scientifica del CNR nel 2019 con Eccentrico (sempre effequ), l’autore, che collabora con l’Istituto catalano di Musicoterapia allo sviluppo di nuove metodiche terapeutiche per persone con autismo ed è coordinatore e docente presso il Master in Musicoterapia all’Università di Barcellona, scrive un dizionario emotivo per mostrare le conseguenze che il linguaggio ha sulla visione della diversità.
Può interessarti anche
Termini come esclusione o uguaglianza, vocaboli come desiderio, aspirazione o autodeterminazione, sono comuni a tutti gli esseri umani e particolarmente importanti per chi fa parte di una qualsiasi minoranza.
Partendo dalla neurodiversità, di cui l’autore, autistico, è profondo conoscitore e divulgatore, si esplorano le parole che costellano tutte le altre forme di diversità: culturali, religiose, sessuali e di genere, legate alla differente funzionalità fisica.
Questo saggio fornisce uno stimolo all’apertura, alla comprensione delle diversità e di quanto esse siano indispensabili in una società evoluta, laddove la vera uguaglianza può avvenire esclusivamente attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e delle caratteristiche uniche di ciascun individuo.
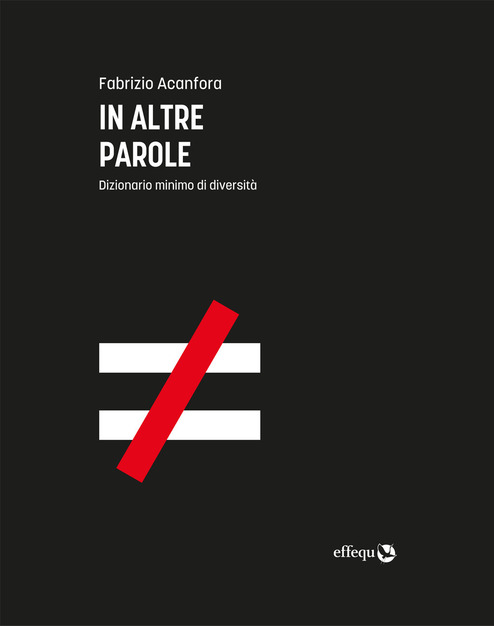
Per gentile concessione della casa editrice, su ilLibraio.it un estratto sull’autorappresentanza:
Prendiamo la categoria delle persone con gli occhi blu. Immaginiamo che la narrazione riguardante le persone dagli occhi blu venga effettuata esclusivamente da persone dagli occhi marroni (1). Immaginate, voi con gli occhi blu, come potreste sentirvi ascoltando una persona dagli occhi marroni che, con tono disinvolto, in televisione spieghi come le persone dagli occhi blu abbiano un difetto genetico che risulta, da un punto di vista esteriore, nel colore azzurro degli occhi. Andiamo oltre e immaginiamo che sui giornali e nelle discussioni sulle reti sociali le persone dagli occhi blu vengano descritte come apatiche perché hanno uno sguardo poco penetrante, e che questo sia il risultato di quell’anomalia genetica che, tra le altre cose, le rende anche particolarmente chiuse, scontrose e tendenti alla depressione.
Supponiamo inoltre che, in questa narrazione immaginaria, le persone dagli occhi blu non vengono interpellate sulla loro condizione perché, nella visione della categoria socialmente dominante delle persone dagli occhi marroni, sono considerate inferiori e quindi incapaci di parlare e decidere per sé.
Questo è quello che accade in moltissimi casi quando si parla di diversità, di persone con caratteristiche fisiche, mentali, sensoriali, di genere, etniche, culturali o comportamentali differenti dalla media di una determinata popolazione.
A parlare di disabilità nella maggior parte dei casi ci sono persone non disabili. Allo stesso modo, la narrazione della neuroatipicità (che include condizioni come autismo, disturbo di iperattività e deficit di attenzione, dislessia e altre) viene portata avanti da specialisti, insegnanti, giornalisti che osservano le persone neuroatipiche dal punto di vista neurotipico. E il discorso vale anche per le persone con trisomia 21, sindrome di William e altre condizioni che, dall’esterno, vengono ritenute incapaci di sapere chi sono, in che modo desiderino essere rappresentate, o cosa desiderino per il proprio futuro: quando si appartiene a una minoranza, soprattutto se questa minoranza è caratterizzata da disabilità fisica o cognitiva, si è costrettə a osservare una narrazione di sé filtrata dalla lente deformante della normalità, che stigmatizza qualsiasi differenza come un guasto, un marchio di inferiorità.
Può interessarti anche
Per la maggioranza delle persone il diritto di autorappresentanza – ossia la possibilità di parlare per sé stessə – e quello di autodeterminazione (il diritto di decidere autonomamente della propria vita) sono scontati. D’altra parte è anche normale che ci si accorga di alcune cose quando queste ci vengono sottratte o non ci vengano concesse.
Il diritto di autorappresentanza e quello di autodeterminazione sono fondamentali perché sono alla base della dignità della persona. Nonostante la suddivisione della società in categorie chiuse ermeticamente sia innaturale e deleteria quando usata per discriminare, non c’è dubbio che sia fondamentale potersi riconoscere in un gruppo col quale condividere le proprie caratteristiche, esperienze, modalità sociali, e l’identità individuale si forma anche attraverso l’appartenenza e il confronto con tali gruppi. Ma questo aspetto positivo della nostra naturale tendenza a categorizzare è messo in ombra dal fatto che troppo spesso alcune categorie non nascono dalla narrazione che di esse fanno i propri membri, bensì dal racconto di chi le osserva dall’esterno giudicandole in base a parametri che sono sfavorevoli in partenza.
Ad esempio, per una giovane persona autistica che cerca di crearsi una propria identità tra individui con cui condivide alcune delle caratteristiche che l’hanno portata alla diagnosi, questa narrazione risulta problematica perché può portare a identificarsi con modelli inesistenti che creano senso di inferiorità e frustrazione. Certo, se la comunità autistica fosse considerata una parte integrante e fondamentale della narrazione che la riguarda, probabilmente oggi le persone autistiche non sarebbero viste come un crogiolo di deficit ma semplicemente come individui con un funzionamento neurologico differente dalla media.
L’autorappresentanza inoltre apre le porte all’autodeterminazione, perché solo riconoscendo il valore della narrazione in prima persona della diversità è possibile prenderne in considerazione la volontà circa le scelte che la riguardano. Un esempio pratico è la sessualità delle persone con disabilità. Una delle caratteristiche della narrazione che la maggioranza fa della disabilità è la sua infantilizzazione; e di conseguenza la rimozione del diritto di provare sentimenti come la rabbia, l’odio, la vendetta. La persona disabile, nella narrazione che ne fa la maggioranza abile, non ha nemmeno desideri sessuali. Poiché questa narrazione, che è parecchio lontana dalla realtà, domina l’immaginario collettivo sulla disabilità, allora l’argomento della sessualità in questo ambito non viene affrontato (2). Sei disabile? Non trombi. E non solo non puoi farlo, ma nemmeno dovresti pensarci. Ecco una delle assurdità a cui la mancanza di una reale autorappresentanza può portare, ecco un esempio pratico di diritti negati.
Tornando al nostro esperimento iniziale: cosa pensereste, voi persone dagli occhi azzurri, se non solo veniste descritte dalla maggioranza in modo impreciso ma, dato che da quella descrizione ne uscite come inferiori e in qualche modo incapaci, vi fosse tolto anche il diritto di decidere della vostra vita?
Può interessarti anche
C’è poi un altro aspetto che trovo fondamentale riguardo all’autorappresentanza. Quando per strada un bambino fissa una persona disabile, esiste una ragionevole possibilità che la mamma prontamente lo rimproveri dicendo che non si fa, non si fissano quelle persone perché, poverine, sono state sfortunate. Quelle persone, che nel frattempo sono già divenute altro rispetto al noi persone non disabili (ma possiamo scegliere una qualsiasi differenza, non necessariamente la disabilità) e, soprattutto, sono sfortunate perché hanno qualcosa in meno.
Di quelle persone inoltre non si sente tanto parlare in televisione, e quando accade è solo per rinforzare l’idea che poverine, da sole non ce la fanno e hanno bisogno di essere guidate, accolte, istruite, assistite. Quelle persone devono essere aiutate a stare nella società, come se in un momento preciso della loro esistenza – dopo esservi nate, nella società – fosse stato loro ritirato il passaporto dell’umanità.
Come pensate che cresceranno una bambina o un bambino che subiscono esclusivamente una narrazione della realtà fatta da persone uguali a loro? Cosa credete che penseranno di chi appare diverso o si comporta in modo differente? E ancora, quale idea distorta della realtà si saranno formatə? Forse di una realtà in cui le persone sono tutte uguali tra loro e quelle diverse o sono sfortunate e vanno guardate con compassione, o sono pericolose e allora bisogna sospettare di loro?
Eppure, se avessero potuto convivere con quelle persone ascoltando la loro voce, il racconto delle loro vite, avrebbero scoperto che quelle persone non vedono sé stesse necessariamente come sbagliate o difettose, ma che il loro essere differenti può diventare un problema quando si scontrano con una società che non prende in considerazione o non vuole vedere le loro caratteristiche.
Dare voce alla diversità garantendo il diritto di autorappresentanza è il primo passo per creare una società in cui le differenze possano convivere con pari dignità e l’identità di ciascunə sia considerata al pari delle altre.
(1) Nel 1968 Jane Elliot, un’insegnante dello Iowa, realizzò un controverso esercizio di sensibilizzazione verso le differenze con ə alunnə della sua classe. Divise loro in due gruppi in base al colore degli occhi, creando una narrazione che vedeva ə alunnə dagli occhi blu come inferiori, e utilizzando una serie di loro caratteristiche fisiche e comportamentali, che non avevano alcun legame col colore degli occhi, come dimostrazione che tutte le persone dagli occhi blu fossero ad esempio distratte, disordinate, meno intelligenti di quelle dagli occhi marroni. L’esperimento è visibile su youtube in un documentario intitolato A Class Divided.
(2) È possibile inoltre che, essendo la sessualità uno dei modi storicamente più efficaci per controllare le persone, questa necessità di controllo sul corpo disabile venga percepita come superflua dalla maggioranza, in quanto la condizione di dipendenza che può caratterizzare la disabilità rende la persona disabile più facilmente controllabile. Oppure, come suggerito da Sofia Righetti, filosofa e attivista per i diritti delle persone disabili “Ti desessualizzo perché voglio controllarti. Ti tolgo lo status di adultə e la validità sessuale perché voglio controllare ancora di più te e il tuo corpo”. In entrambi i casi, si tratterebbe di un utilizzo della sessualità (o la sua privazione) per aumentare il controllo su una persona.
(continua in libreria…)





