Il panorama letterario latinoamericano si regge su fondamenta labirintiche e speculari che da un secolo si preoccupano di erodere tutto ciò che, ordinariamente, viene dato per saldo. E nell’ambito dell’erosione si pone anche l’operazione letteraria di Juan José Saer (1937-2005), le cui opere gravitano attorno al dato esondante e implacabile di un fiume, che è tanto elemento geografico (il Río de la Plata) quanto procedimento linguistico. Duplice la funzione, duplice la costruzione di un territorio terribile e neutro: il dato reale non è più dato. Ogni apparenza viene rifiutata, dal momento che ne nasconde una ulteriore; e la sintassi, fatta di sedimenti e detriti, diventa strumento di confusione e allucinazione. Per Saer, d’altra parte, l’unico scopo – o, forse, l’unico possibile esito – della ricerca di una realtà, è l’immersione non in un oggetto, ma in un processo che è un “discendere, infruttuoso, come in un sogno, nel proprio fiume” – L’approfondimento sulle opere del grande (e ancora poco riconosciuto) scrittore argentino (se ai grandi libri chiediamo di mettere la testa nell’abisso, Saer elabora un metodo)
Da un pezzo il passato della letteratura latinoamericana rappresenta quanto di più simile a un serbatoio di futuri per tutte le altre.
In principio, naturalmente, furono Macedonio Fernández e il suo discepolo, Jorge Luis Borges.
Nei controviali di certe periferie postindustriali europee, ai margini di una stagione di sviluppo nordamericano che incontra l’autunno come si incontra una catastrofe, la forma della biblioteca, la forma del labirinto, la forma dello specchio sono proliferate come microrganismi in grado di contaminare tutto il resto, erodendo architetture, saperi e sensi della vita.
Solo un argentino d’adozione come Witold Gombrowicz, perciò, poteva abbandonare quel continente intimando a chiunque di ucciderlo, Borges, e poteva spaventare a grida la vita ogniqualvolta questa abbia provato a maturare in una forma; un gesto che abbiamo imparato a riconoscere come nostro, senza peraltro avere un grammo del suo coraggio.
Poi, Gabriel García Márquez, la sua capacità da sciamano di sospendere l’incredulità nei confronti del realismo e attingere alla meraviglia dell’affabulazione spingendo sul pedale inverso; inconcepibile a certe latitudini.
Roberto Bolaño, che costruiva cattedrali nella notte opponendo al vuoto delle fondamenta l’energia di una dispersione. Eccetera, eccetera: ci si potrebbe riempire una biblioteca.
Che dire, però, del meno conosciuto tra i giganti, di chi, dopo un lungo esilio di marginalità e solitudine, è stato definito come “il più importante scrittore argentino dopo Borges” (Beatriz Sarlo), “uno dei migliori scrittori in qualsiasi lingua” (Riccardo Piglia – con cui si gioca l’eredità di Borges)?
Vale a dire: quando saremo davvero pronti ad ascoltarlo, in quale foresta, in quale fiume, in quale nebbia ci condurrà il magistero di Juan José Saer?
Può interessarti anche
Saer nasce a Serodino nel 1937 da immigrati di Damasco (soprannome: El Turquito), vive fino a trent’anni a Santa Fe, città argentina che si consuma nella distanza con Buenos Aires, accomodata sulla regione di anse e di eventi del Río de la Plata. Qui alcuni incontri fondamentali, a cui fu per sempre fedele. Juan L. Ortiz, poeta, che inventò il “color leone” cui il nostro sottrasse le ossessioni; Antonio Di Benedetto, torturato, esule in Spagna, vincitore di premi provinciali, noto come personaggio di finzione con il nome di Luis Antonio Sensini; Hugo Gola, esule in Messico, che sceglieva parole con cura, “come armi”, e scriveva poesie che non emettevano messaggi, ma lampi o radiazioni; Paco Urondo, che non conobbe le asperità dell’esilio perché nell’estate del ’76 al piombo preferì il cianuro.
Grazie a una borsa di studio nel 1968, Saer finisce a Parigi, dove resterà per tutta la vita insegnando letteratura. Forte fumatore, muore l’11 giugno del 2005 di tumore ai polmoni.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
Juan José Saer ha letto tutti i libri e ha scritto. Ma una vita non è sufficiente a cancellare un’origine: nelle prime pagine de Il fiume senza sponde. Trattato immaginario (1991, trad. Gina Maneri, con le allieve della scuola di traduzione Tuttoeuropa, La Nuova Frontiera, 2019), pur riconoscendone i vantaggi materiali (“peraltro molto modesti”), scriverà che l’Europa ha rappresentato per lui un continente irreale (“mi sfuggono gli atti e le intenzioni che la governano”) e la sua vita europea quella di un usurpatore, cui un giorno verrà chiesto il conto. Atterrato a Buenos Aires la prima cosa che annota è “una sensazione di realtà”.
Forse è per questo che della storia di Saer l’essenziale è la geografia. La geografia concreta di un dato che facilmente precipita nell’astratto, nell’indistinto, nell’onirico: quel Río de la Plata che sconfigge ogni empiria (un fiume il cui estuario si estende quanto la superficie dell’Olanda facendone scomparire la forma nell’orizzonte e negando “l’archetipo stesso del concetto di fiume: la sponda opposta”) e ogni incrostazione di significato e immaginario (un fiume il cui nome costituisce “un flagrante abuso verbale” poiché, nonostante gli auspici dei nomenclatori spagnoli, di plata in Argentina manco l’ombra).

Attorno al Río de la Plata converge la sua immaginazione (nella regione rioplatense sono ambientati tutti i suoi libri), ma soprattutto si addensa il nucleo intimo e intransitivo che maledice un’esistenza rendendola la vita di un uomo che traffica senso con sillabe e lettere. Quella di uno scrittore: un certo modo di osservare il mondo, e da questo, di desumere una serie di procedure per attraversarne l’enigma e una serie di problemi nel rappresentare quanto si è visto. Quando Saer affronta di petto il problema degli elementi che costituiscono la realtà, non può fare a meno di descrivere con una lingua di rivoli, sedimenti e detriti, una lingua fatta di orografia, “la massa melmosa dell’empirico e dell’immaginario, che altri hanno l’illusione di scomporre a piacimento in fette di verità e falsità”, e lo scopo della sua ricerca: “immergersi in essa”.
Saer maturava queste convinzioni in un saggio nel 1989, contenuto oggi ne El concepto de ficción (Rayo Verde, 2016). Prima che la cultura occidentale, tra gli scioperi degli eventi degli anni Novanta, e lo shock di realtà nel decennio successivo, assalita dall’ansia di non avere alcuna alternativa all’imitare la vita, perimetrasse il campo della letteratura come quello in cui si verifica la tenuta di opposizioni quali verità e finzione, realtà e rappresentazione, convenzione ed esperienza, stereotipo e autenticità, particolare e universale, Saer consumava il dorso della sua mano senza distogliere lo sguardo dall’unica sponda di un fiume per riformularne prima e meglio di altri i rapporti.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
Polemico contro ogni idea ornamentale o nichilista della letteratura e del suo contenuto di verità, si è reso conto presto che il vero e il falso, in letteratura, non si escludono: “questo intreccio critico tra verità e falsità, questa tensione intima e decisiva, non esente né da comicità, né da gravità, è presente come ordine centrale di tutte [le opere], a volte come tema esplicito e a volte come fondamento implicito della loro struttura”. Secondo Saer, nessuno di fronte alle opere di Kafka o Flaubert cerca di sciogliere il nesso di verità e finzione: i loro testi vogliono essere presi alla lettera. “La finzione non chiede di essere creduta come verità, ma come finzione. […] la narrativa è un trattamento specifico del mondo, inseparabile da ciò che tratta”.
Ma come trattare il mondo? Come immergersi? Dove? A che ora apre?
La cosa non è esente da problemi. Il che ci spinge al centro del segreto della sua letteratura, che, dopo timide apparizioni nei decenni precedenti, da qualche anno è in larga parte disponibile in Italia grazie all’attenzione de La Nuova Frontiera.
Quando lui chiama, il Río de la Plata risponde. Saer sa bene che è dai tempi Eraclito che si discute di come sia impossibile discendere due volte nel medesimo fiume, o, peggio, che nessuno sia mai disceso in un nessun fiume. Il dato di realtà, il fiume, il mondo non è qualcosa che viene dato una volta per tutte, non è un oggetto stabile da esprimere, ma “una materia imprecisa, fluttuante, instabile, che cambia continuamente forma, valore, posto”. Qualcosa che, in ultima istanza, è imprendibile e irrappresentabile; vuoto, enigma o segreto. Il mondo come scatola nera di cui non si può che rendere il “ritratto immaginario di un terrore immobile”.
“Ci ostiniamo a parlare di temi, ma dovremmo parlare di procedimenti […] l’esaurimento della realtà a partire da una menomazione”, ha scritto Luciano Funetta in un volume pieno di armoniche saeriane (Domicilio sconosciuto, Perdersi nella letteratura latinoamericana, Utet, 2023), discutendo della trama nel tappeto della letteratura latinoamericana. La letteratura di Saer esaurisce ed evoca una realtà irrappresentabile, che forse nel suo caso significa la stessa cosa, con un doppio procedimento, fatalmente intrecciato. Due movimenti, con cui attraversa i più grandi con l’aria di chi non ha alcun timore di guardarli in faccia, da pari a pari.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
Il primo, gombrowicziano, consiste nel rifiuto di ogni apparenza, di ogni forma, di ogni “essenza anticipata” (“la mia prima preoccupazione come scrittore è quindi questa critica di ciò che viene presentato come reale a cui il resto deve essere subordinato”). Il secondo, borgesiano: il doppio come principio di composizione, come sintassi, strumento di moltiplicazione, metodo di confusione, metodo di allucinazione (“Il mio sistema tende a essere una serie indefinita di frammenti che si modificano e si rispecchiano reciprocamente”, “il centro […] sembra spostarsi in tutte le direzioni e, poiché ogni dettaglio prende corpo nell’insieme, e a mano a mano che quel dettaglio cresce compaiono altri dettagli dimenticati, si moltiplicano e a loro volta crescono, provo una certa desolazione e dico a me stesso che non soltanto il mondo è infinito ma che ciascuna delle sua parti è infinita e che infiniti sono i miei ricordi.”).
Valga da esempio L’Indagine (1994, trad, Gina Maneri, La Nuova Frontiera, 2014) dove l’inchiesta su una serie di omicidi raddoppia in due inchieste. La trama si attorciglia, si sdoppia, accumula rispecchiamenti, ipotesi, prospettive, mentre la sintassi di Saer inanella le sue virgole leggendarie, finché il suo filo tenue collassa in un’unica vicenda di violenza in cui il detective e l’assassino si corrispondono, una città di pioggia e crepuscoli si scopre votata al dio dell’indifferenziato, il poliziotto, Morvan, si accorge che mancano vasti frammenti della sua vita per cui la verità più intima su di sé diventa “più inafferrabile e oscura della faccia nascosta delle stelle”, e il mondo intero, “contiguo a quello delle apparenze”, appare un enigma indecifrabile “in cui ciascun atto, ciascun oggetto e ciascun dettaglio occupavano il posto esatto accordatogli nell’insieme dalla logica del delirio, valida solo per colui che aveva elaborato il sistema e intraducibile in alcuna lingua conosciuta”.

In Cicatrici (1969, trad. Gina Maneri, La Nuova Frontiera, 2012) Saer prende a pretesto un fatto di sangue e crea una spirale in cui quattro storie precipitano in un singolo omicidio. Se vivere e scrivere significano immergersi nella materia melmosa del reale, qui, mentre Angelito rincorre il suo doppio, Saer scopre il nodo che lega abisso e scrittura (“non è strano che, risalendo da un pozzo nero, ci ritroviamo i vestiti da esploratore incrostati di merda”). Crosta, cicatrice che sigilla una ferita, o Glossa (1986, trad. Gina Maneri, La Nuova Frontiera, 2019) a margine della porzione di vuoto che recinge; qui, il racconto lungo ventisette isolati di una certa festa accumula descrizioni di descrizioni in così tante prospettive che la realtà si frantuma in una foresta di piani discordanti e versioni contraddittorie.
Nessuno potrebbe opporsi alla sua natura enorme, inesauribile, incongrua, ma la frugano parole sussurrate nella notte. Certo, siamo nei territori del rischio, l’ossessione di conoscere la polpa brumosa dell’indistinto essendo sorella dell’esclusione e del delirio: basti chiedere a Blanco, protagonista de L’occasione (1988, trad. Gina Maneri, La Nuova Frontiera, 2021) o al nutrito popolo di folli che accompagna il dottor Real (un nome, come dire, parlante) nel peregrinare de Le nuvole (1997, trad. Gina Maneri, La Nuova Frontiera, 2017).

Nessun’opera, però, è più essenziale, più verticale nell’affrontarne il nocciolo duro, de Il Testimone (1983) riproposto (2023) da La Nuova Frontiera nella traduzione di Luisa Pranzetti, con una postfazione di Paolo Pecere.
Il Testimone prende spunto dalla vicenda di Francisco del Puerto, mozzo al soldo di Juan Díaz de Solís, piloto mayor della flotta spagnola che, avviato lungo la rotta di Vespucci, per errore incontrò insieme il Río de la Plata e la morte. Lì, infatti, annotò Borges, “digiunò Juan Dìaz e gli indios mangiarono”. Secondo le testimonianze, quando il contingente scese a terra in esplorazione, gli indios li uccisero e se li mangiarono seduta stante, crudi, di fronte ai marinai rimasti sulla nave (“come cacciagione”, precisa Saer ne Il fiume senza sponde, contro ogni “infame calunnia” nei confronti dei cannibali). Per qualche motivo risparmiarono Dal Puerto che rimase lì dieci anni, abbandonato dai compagni, finché non incontrò nel 1527 la spedizione di Sebastiano Caboto.
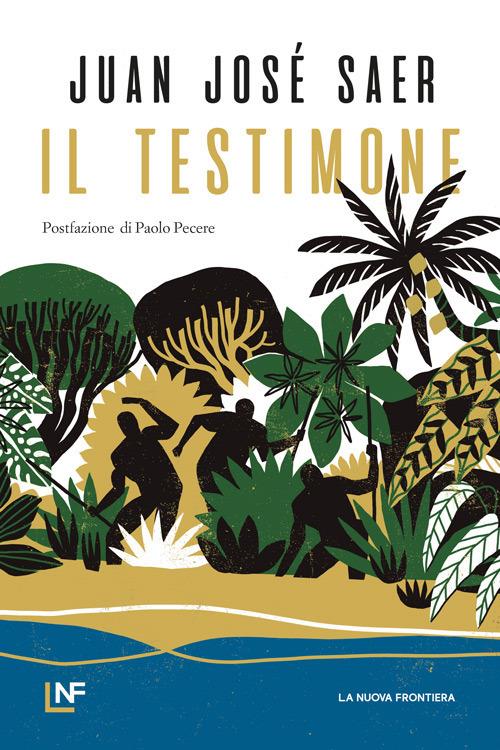
Questa la vicenda de Il Testimone, ma Saer la prende alla rovescia. Non gli interessa quanto avvenne, ma quanto di quella storia si è impresso nel ricordo del mozzo, che ripercorre la sua vita sessant’anni dopo, rievocando il mistero di ogni vita. Di quell’incontro non lo attirano davvero né il dato storico, né l’avventuroso: i generi infatti sono il centro di una spirale, romanzo storico e romanzo d’avventura sono come allusi e trasfigurati, piani ulteriori che si accumulano, insieme al resoconto antropologico, alla favola filosofica, al memoriale di una memoria perduta, al mito di fondazione, in un regime di commistione totale. Gli importa il suo significato: il libro non va avanti perché il lettore si chiede cos’è successo?, ma perché si chiede cosa significhino gli avvenimenti.
La cifra essenziale è l’incontro tra due sistemi di pensiero incommensurabili, fondati su principi di realtà intraducibili: per Saer, relativizzandole nel rispecchiamento tra due mondi, quell’incontro aboliva tutte quelle mediazioni simboliche che percepiamo come un dato di realtà. Gli interessa l’apprendistato a una visione, perché la realtà svuotata dei suoi trucchi appare immensa, ostile, misteriosa, impredicabile; ne Il fiume senza sponde, divertito, notava la sproporzione assoluta tra l’immagine che avevano di sé gli esploratori europei, “all’apogeo della civiltà”, e la funzione loro attribuita dagli indios: cibo.
Raddoppiamento, e rifiuto delle essenze anticipate, qui toccano direttamente il centro di forme elementari (“rumori di osso e legno che umani manipolavano per estrarre dall’indistinto forme riconoscibili”): come altrove tormentava le sue trame forzandole a specchiarsi nel loro doppio, in ipotesi, congetture, prospettive incongrue, così nel Testimone, Saer costringe la vita del suo protagonista a rispecchiarsi e confondersi con quella di un popolo la cui lingua non sa distinguere tra “sembrare” ed “essere”, e per cui “morte” e “vita” sono uguali, abitanti atterriti di un universo che gli si presenta come sempre in procinto di scomparire.
Solo una prospettiva esterna è in grado di conferirgli un’esistenza (“La mera presenza delle cose non ne garantiva l’esistenza. Un albero, per esempio, non sempre bastava a sé stesso per provare la propria esistenza. Gli mancava in ogni caso una parte di realtà. […] L’albero era lì e loro erano l’albero. Senza di loro non c’era l’albero, ma, senza l’albero, anche loro non erano nulla”). Premere un mondo sopra l’altro, naturalmente, non può che dar luogo a un’eclissi. A lasciare la pagina esposta a un cielo “abbondante”, che lascia intravedere la sua “incandescenza interna”.
Saer si chiede: cos’è una vita, esposta al tempo “come un fiume arcaico che trascina carabattole del visibile”, alla memoria, se non una serie di mondi messi una sopra l’altro, se non una serie di nascite successive che si dirigono verso un unico letto anonimo? E, in questo flusso che accumula e abolisce, che altro resta se non racconto, rappresentazione, testimonianza? E cos’è vivere se non “discendere, infruttuoso, come in un sogno, nel proprio fiume”? Le parole che ha scritto, forse non sono una vera risposta, ma quasi.
Può interessarti anche
Ai grandi libri chiediamo di mettere la testa nell’abisso, Saer elabora un metodo. Sa che il punto è un “trattamento del mondo”.
Se il gesto architettonico con cui ogni narrazione indaga la realtà è quello di crearne un modello in piccolo per isolarne una porzione ed esplorarne i territori, il metodo di Saer non fa differenze, solo, esaurisce la realtà eliminando i suoi effetti modellizzanti fino a sondare, ogni volta, un “luogo terribile e neutro”. Scopre il trucco con cui il mondo sa edificare il vuoto a partire dal pieno e glielo rivolta contro: in assenza di una gerarchia che ordini sfere e insiemi, l’accumulo non produce che rumore, il vuoto o il mistero essendo nient’affatto assenza, ma, per stratificazioni di buio, il collasso di ogni piano accatastato l’uno sull’altro. Ne El limonero real (inedito in Italia, 1974), il padre di Wenceslao guarda la nebbia come se si aspettasse di leggerci un significato scritto. “Ora sembra che la nebbia abbia divorato anche il tempo e il suo sedimento, la memoria. Suo padre cerca di perforare con lo sguardo il denso muro di particelle bianche, come se si aspettasse di leggervi un significato, il significato della nebbia stessa, o di ciò che la nebbia nascondeva e che loro sono venuti a cercare, il significato del motivo per cui sono venuti a cercarla”.
“Solo es real la niebla”, ha scritto Octavio Paz. Saer ci insegna che la nebbia pertiene al campo della condensazione, della saturazione, della densità. E ci dice: qui c’è il mistero, qui dovrai provare a leggere, ci puoi arrivare in questo modo. È tutto quello che ci serviva sapere.





