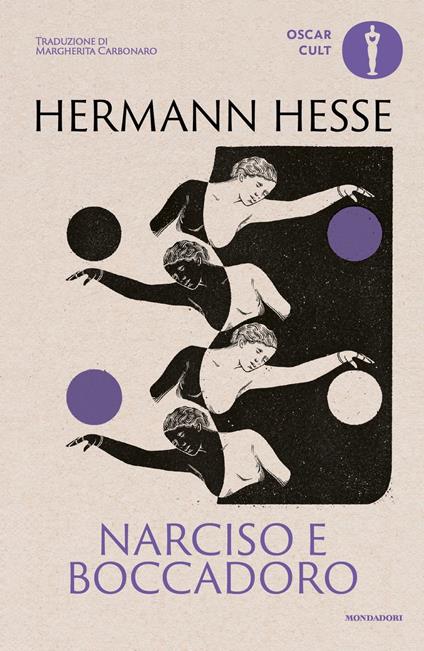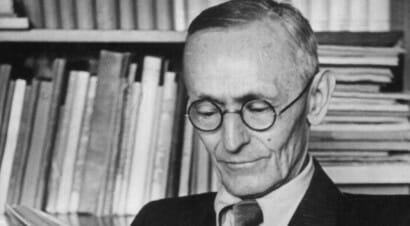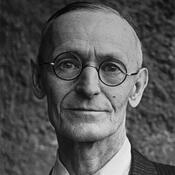Un incontro predestinato, quello tra Narciso e Boccadoro, che, nell’omonimo capolavoro di Hermann Hesse (pubblicato nel 1930), dà vita a una delle più raffinate rappresentazioni letterarie del rapporto tra mentore e allievo: un romanzo sulla necessità di sviluppare autonomamente un’identità propria, intraprendendo un viaggio a cui intanto, però, fanno da filo conduttore un sentimento platonico e sublimato, e un’alchemica fusione degli opposti…
“Non sono sempre i desideri a determinare il destino e la missione di un uomo: ci può essere qualcos’altro, di predestinato”.
Scriveva così l’autore, poeta e pittore tedesco naturalizzato svizzero Hermann Hesse (1877-1962), Premio Nobel per la Letteratura nel 1946, nel celebre romanzo Narciso e Boccadoro (Mondadori, traduzione di Margherita Carbonaro), dato alle stampe nel 1930.
Un qualcos’altro che, nel caso specifico, coincide con l’incontro tra due figure complementari, che sviluppano un’amicizia spirituale basata sul rispetto dell’alterità, proponendoci uno degli esempi letterari più raffinati di tutti i tempi sul rapporto tra mentore e allievo.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
Narciso e Boccadoro e l’affinità degli opposti
Ci troviamo nella Germania medievale, e più precisamente nel convento di Mariabronn, dove il giovane Boccadoro viene mandato dal padre affinché riceva un’istruzione rigorosa.
Qui ha modo di entrare in contatto con Narciso, un giovane e saggio maestro che gli è quasi coetaneo, e che ben presto riconosce nei suoi confronti una profonda affinità d’anima, pur realizzando quanto il loro carattere e le loro vocazioni siano a dir poco agli antipodi.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
Narciso è l’intellettuale, l’asceta, l’uomo che conosce la legge dello spirito; mentre Boccadoro è il fanciullo ancora in cerca di una figura materna di riferimento, che vorrebbe immergersi nel mondo e perdersi fra i corpi, le strade, gli estranei.
Due opposti allegorici, che rimandano allo Yin e allo Yang di cui è composto l’essere umano: la meditazione e l’esuberanza, la stabilità e il cambiamento, la clausura e il libertinaggio, lo studio e la sensorialità, la razionalità apollinea e l’istintualità dionisiaca, per usare due concetti cari al grande pensatore tedesco Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Inesperto com’è, tuttavia, Boccadoro non capisce subito quale strada sia più adatta a sé, ed è grazie a Narciso che si allontanerà da una vita monastica che non gli appartiene, intraprendendo un viaggio all’insegna della formazione e dell’avventura, e al tempo stesso della riflessione filosofico-teologica.
Può interessarti anche
L’archetipo del mentore
La lucidità con cui Narciso indirizza Boccadoro ad allontanarsi dall’abbazia, peraltro, non è casuale: il suo personaggio incarna – come anticipavamo – l’archetipo del mentore, la cui origine letteraria viene fatta risalire all’Odissea (Ponte alle Grazie, a cura di Daniele Ventre) di Omero (VIII-VII secolo a.C. circa).
Nel poema, infatti, la dea Atena sostiene Telemaco assumendo le sembianze di un personaggio chiamato proprio Mentore, che poi per antonomasia ha iniziato a indicare il ruolo di consigliere, guida e precettore (basti pensare a Socrate con Platone, a Pigmalione con Galatea o a Virgilio con Dante, per citare alcuni fra gli esempi più noti del panorama occidentale).
Può interessarti anche
Detto altrimenti, il mentore ha la possibilità di orientare (nel bene, come anche nel male) le azioni, le scelte e i valori dell’eroe, avendo compiuto a propria volta un percorso di maturazione e potendo offrire ora al suo allievo un modello da seguire, un corpus di conoscenze, un qualche dono concreto o anche solo un supporto etico e pratico lungo il cammino.
In Narciso e Boccadoro parliamo soprattutto di un mentore spirituale, di uno specchio (e in questo senso il nome di Narciso è fortemente indicativo) grazie al quale Boccadoro può imparare a vedere con più chiarezza nella propria interiorità; non emulando il maestro o ricevendone la dottrina, bensì ascoltando sé stesso e sviluppando un’identità autonoma.
Afferma del resto Narciso, nel quarto capitolo del romanzo: “Noi due, caro amico, siamo il sole e la luna, siamo il mare e la terra. La nostra meta non è di trasformarci l’uno nell’altro, ma di conoscerci l’un l’altro e d’imparare a vedere e a rispettare nell’altro ciò ch’egli è: il nostro opposto e il nostro complemento“.
Può interessarti anche
Narciso e Boccadoro: un amore platonico…
Una citazione che ci permette di intuire nel rapporto tra Narciso e Boccadoro una dinamica tutt’altro che unidirezionale.
Non è solo l’allievo a provare gratitudine, devozione e attaccamento nei confronti del maestro, ma anche il mentore a sentirsi chiamato dal discepolo, a proteggerlo e a riservargli un’attenzione speciale, prendendosi cura di lui senza però scadere mai nel paternalismo.
Scrive ancora Hermann Hesse, riferendosi a Narciso: “Vedeva la natura di Boccadoro e, malgrado fosse l’opposto della sua, la comprendeva a fondo, perché ne era l’altra metà, la metà perduta“.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
A differenza di quanto potremmo credere, quindi, Narciso e Boccadoro non sono due eletti, bensì due individui irrisolti, che scoprono l’uno nell’altro il proprio completamento: al saggio Narciso manca il contatto diretto con il mondo, a Boccadoro l’abilità di dare un significato più profondo e strutturato al suo vagabondare tra letti e taverne, tra artisti e viandanti, in cattedrali e bordelli.
Ecco perché il loro è di fatto un amore platonico, cioè una connessione intellettuale e interiore che li porta ad arricchire la loro rispettiva visione e comprensione dell’esistenza, ogni volta che entrano in comunicazione l’uno con l’altro.
Proprio come spiegava il filosofo greco Platone (427-347 a.C.) nel Simposio (Garzanti, traduzione di N. Marziano), uno dei suoi dialoghi più famosi e studiati, teorizzando che, dal desiderio iniziale per l’altro in quanto tale, si passi a una ricerca filosofica della verità, arrivando (grazie a uno sforzo di elevazione comune) alla contemplazione di una Bellezza pura e assoluta, che coincide con una conoscenza superiore e che porta a una comunione d’anima più che dei corpi.
Può interessarti anche
…ma anche alchemico
Nel momento in cui Narciso mette in atto la decisione – apparentemente passiva, ma in realtà potentissima – di non trattenere Boccadoro e di non plasmarlo, offrendogli invece gli strumenti per un sano distacco dal maestro, lo sta inoltre incoraggiando a intraprendere un percorso alchemico.
Questa ricerca della Bellezza, infatti, non è tanto diversa da quella della cosiddetta pietra filosofale (o pietra dei filosofi), una sostanza leggendaria capace di trasformare i vili metalli in oro e di produrre l’elisir di lunga vita, rappresentando simbolicamente un processo di perfezionamento spirituale.
Può interessarti anche
In tal senso, è lecito ipotizzare che Boccadoro sperimenti dapprima una sorta di nigredo, cioè uno stato di oscurità e di smarrimento, nel quale dipende ancora da Narciso pur avendo un destino personale inconciliabile con il suo.
Lascia poi il convento per andare incontro alla fase dell’albedo, che sancisce la sua liberazione, il suo risveglio interiore e il raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé.
Dopodiché, il suo cammino culmina nella rubedo, il momento in cui la materia prima – dopo essersi dissolta e purificata – può finalmente ricomporsi.
Può interessarti anche
Boccadoro torna perciò al convento, avendo trovato un equilibrio tra le dicotomie iniziali grazie specialmente alla scoperta dell’arte, che gli permette ora di sublimare la Bellezza e renderla imperitura.
Si è intanto ricongiunto con l’archetipo della madre che aveva tanto agognato, mutando in oro la propria attrazione per la bellezza corporea e accogliendo dentro di sé tutto ciò che è natura e creatività ed Eros, e può così ricongiungersi anche con il suo mentore.
Ora, finalmente, tra lui e Narciso non c’è più un rapporto di subordinazione, ma una relazione di simmetria. Nessuna lezione da imparare, solo l’accettazione di due vite che dall’inizio del romanzo si sfiorano, si separano, si riflettono. E che, nel farlo, sono riuscite a illuminarsi a vicenda.

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.
Fotografia header: "Doppio autoritratto" di Giorgione (olio su tela, 1502 circa, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma)