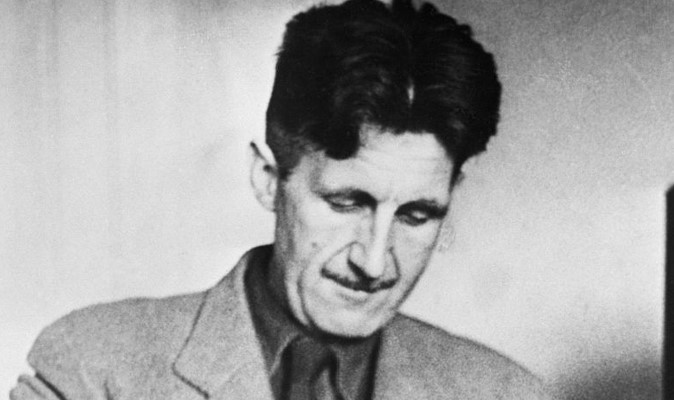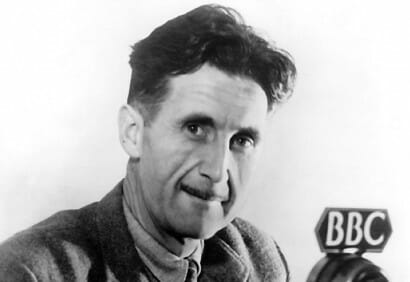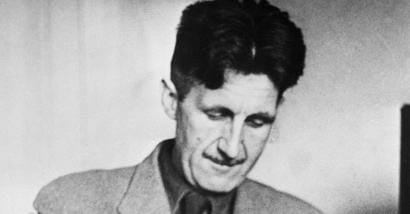Cosa può insegnarci oggi una favola con maiali parlanti e cavalli che credono nella rivoluzione? Molto più di quanto pensiamo. Pubblicata in un tempo in cui criticare l’Unione Sovietica era un tabù, “La fattoria degli animali” (1945) di George Orwell è diventata un classico sulla propaganda e sulla manipolazione ma, soprattutto, un manifesto sul potere; (ri)leggere questa “favola” significa fare i conti non solo con la Storia, ma anche con il presente: chi decide cosa è vero? Chi scrive le regole? E, soprattutto, che ruolo abbiamo in questa “riscrittura”?
C’era un tempo in cui pubblicare una storia di animali impegnati in una rivoluzione sembrava una pessima idea. Nel 1944 George Orwell aveva appena finito La fattoria degli animali, quando Stalin era ancora alleato della Gran Bretagna: per questo, raccontare un’allegoria con maiali, cavalli, pecore che si ribellavano a un padrone umano, per poi finire sotto un padrone peggiore, risultava scomodo. Lo scriverà lo stesso Eric Arthur Blair – vero nome dell’autore – un anno dopo in Libertà di stampa, l’introduzione che aveva pensato per il suo romanzo.

L’edizione Garzanti del libro di Orwell, nella traduzione di Claudia Durastanti
Gli ostacoli alla pubblicazione
“L’idea centrale di questo libro risale al 1937, ma la sua stesura ha avuto luogo verso la fine del 1943. Nel momento in cui è stato finalmente ultimato, è apparso chiaro che […] sarebbe stato molto difficile farlo pubblicare. In effetti è stato rifiutato da quattro editori, solo uno dei quali aveva motivazioni ideologiche; due pubblicavano da anni libri antisovietici, mentre il quarto non aveva un orientamento politico identificabile. Inizialmente, a dire il vero, un editore aveva accettato il libro, ma dopo le intese preliminari aveva deciso di consultare il ministero dell’Informazione, che pare gli abbia intimato, o comunque consigliato energicamente, di non pubblicarlo”.
Non si trattava di una vera e propria censura, dato che La fattoria degli animali non era stata bandita dalla pubblicazione. Piuttosto di un “fenomeno in buona parte spontaneo” che riguardava la stampa britannica dell’epoca, che ignorava alcune notizie e testi “non per intervento del governo ma per un tacito accordo generale secondo cui ‘non stava bene’ menzionare quei particolari avvenimenti”.
A un passo dalla fine della guerra, quindi, parlar male dell’Unione Sovietica anche solo per via indiretta, sarebbe stato fuori luogo, forse addirittura una forma di tradimento. Meglio non rischiare.
Può interessarti anche
Eppure, quella “favola” – così la definì Orwell stesso nel titolo originale Animal Farm: A Fairy – era pronta a raccontare cose di cui nessuno parlava. E a dirle con una semplicità disarmante: il racconto doveva essere accessibile, semplice, quasi ingenuo.
L’idea venne alla moglie dell’autore, Eileen O’Shaughnessy, che ebbe un ruolo cruciale per la stesura del romanzo.
Una favola sul potere
Così nacque una favola, ma non della buonanotte. Perché La fattoria degli animali parla di comunismo, di URSS, di corruzione, di dittature ma, in particolare, parla di potere. Di cosa fa, di come si trasforma, di dove nasce e, soprattutto, parla di chi lo subisce.
Nella Fattoria Padronale del signor Jones gli animali, da tempo relegati a schiavitù, decidono di insorgere dopo un sogno fatto dal Vecchio Maggiore, anziano verro di razza. Guidati dai versi della canzone Bestie d’Inghilterra, abbracciano la ribellione predetta dal saggio e creano un nuovo ordine fondato sull’uguaglianza, libero dai soprusi degli uomini.
Il loro slogan è “Quattro gambe buono, due gambe cattivo”. La società giusta che si immaginano,però, si rivela presto un nuovo dominio da parte dei maiali, i componenti del gruppo descritti come i più intelligenti.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
Il potere nella fattoria non arriva con la violenza, ma entra piano nella vita di tutti i suoi abitanti grazie alle parole. Napoleone, il Capo, le pensa, Clarinetto, il braccio, le comunica, mentre intorno i cani aggressivi fanno in modo di mantenere pacate le reazioni degli altri.
“Tutti gli animali sono uguali…”
Il paradosso è che proprio da quelle parole era nata la rivoluzione: sette comandamenti da seguire nella Repubblica, un concetto semplice che li riassume “Tutti gli animali sono uguali”. È da qui che i maiali iniziano ad accumulare il loro potere.
Un giorno agli animali era vietato dormire su un letto, il giorno dopo bastava che questo non avesse le lenzuola. Le pecore, abituate a belare di continuo lo slogan “Quattro gambe buono, due gambe cattivo”, dopo qualche settimana di lavaggio del cervello non si accorgono che il messaggio è diventato “Quattro gambe buono, due gambe meglio”.
Può interessarti anche
Le parole cambiano, si modificano, vengono usate senza scrupoli per manipolare, fino alla deriva definitiva in cui “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”.
Nessuno tra i cavalli, i cani o le galline protesta, anche perché chi ci hanno provato in passato è finito male. Ma specialmente, nessuno tra loro (a parte Beniamino, l’asino cinico e scettico) lo sa fare: gli animali non sanno leggere, non sanno argomentare, hanno studiato poco e niente rispetto ai maiali e hanno abbandonato presto l’impegno politico. Ciò che possono fare è affidarsi al ricordo o alla fiducia cieca, come fa Boxer, il cavallo che continua a ripetere “Napoleone ha sempre ragione”. Così la realtà non cambia davvero: viene solo riscritta e riletta da chi comanda.
Può interessarti anche
Durante la lettura di questo romanzo è difficile non ritrovarsi fuori dalla favola, lontano dai fatti del Novecento.
Quanto conta sapere, oggi?
Nell’epoca di post-verità in cui viviamo, (ri)leggere l’opera di George Orwell ci racconta qualcosa che ci sembra familiare, che sentiamo nelle urla in televisione, che leggiamo sui social o nei titoli sensazionalistici di alcuni giornali. La domanda che sopraggiunge è inevitabile: quanto conta sapere, oggi? Non sapere tutto, solo abbastanza da riconoscere quando qualcosa, sotto sotto, non ha l’aspetto della realtà.
Quando i maiali iniziano a trasgredire ai sette comandamenti – bere alcol, dormire nei letti, commerciare con gli uomini – in un primo momento lo fanno di nascosto, lo negano, ma poi iniziano a farlo alla luce del sole, assicurando che è sempre stato così. Nessuno li ferma o chiede loro conto, perché ormai gli altri animali sono troppo affamati e stanchi, troppo impegnati a sopravvivere.
La fattoria degli animali è un manifesto del potere, ma lo è in particolare sull’influenza di questo sugli uomini (in questo caso maiali!). Chi ce l’ha si abitua a esercitarlo, chi non ce l’ha si abitua a subirlo, mentre l’idea di rivoluzione si fa sempre più difficile e anacronistica.
Può interessarti anche
Il potere si costruisce sulla semplificazione
Non si tratta più di politica del terrore – almeno per coloro che sono in grado di difendersi – ma di una politica della confusione e del dubbio. Il potere si costruisce sulla semplificazione, sull’idea che la complessità sia una perdita di tempo, proprio come nella Fattoria degli animali.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
A rendere attuale questo testo dopo ottant’anni dalla sua pubblicazione è la sua incredibile capacità di comprendere le regole del gioco: quanti Napoleone ci sono oggi nel mondo? Quanti Clarinetto gli fanno da portavoce per convincere le masse? E quanti cani rabbiosi ci sono a difenderli?
In poche ore di lettura, le cento pagine di questo libro finiscono, ma si incastrano nei pensieri e riemergono ogni volta che – ci sembra – la realtà comincia a somigliare a una versione riscritta della verità.
George Orwell non aveva previsto il futuro, ma aveva intuito un meccanismo che si ripete nel tempo. Forse per questo (ri)leggere La fattoria degli animali oggi è una prova di coscienza, non tanto per capire chi sono i maiali del nostro tempo, quanto per chiederci che ruolo abbiamo noi in questa storia.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it