È con due immagini di suono che si apre e chiude “Vetro, ironia e Dio”, una delle più importanti raccolte poetiche di Anne Carson. Il suono come autobiografia, censura e autocensura (dunque: repressione), può anche essere una chiave di lettura per questo testo così eterogeneo, in cui la realtà appare come filtrata da uno schermo trasparente (il vetro, la luce, la neve, la televisione) che contemporaneamente la illumina, la chiarisce, la modifica, la rende obliqua, mediata…
È con due immagini di suono che si apre e chiude Vetro, ironia e Dio, una delle più importanti raccolte poetiche di Anne Carson, originariamente pubblicata nel 1994 da New Directions, storica casa editrice dello sperimentatore James Laughlin e ora negli scaffali italiani grazie a Crocetti e alla cura e traduzione di Patrizio Ceccagnoli.
Due suoni (“Nei miei sogni sento il ticchettio”, così recita il primo verso) che sono anche due saggi: Il saggio di vetro in entrata e Il genere del suono in uscita, a racchiudere, quasi a circondare atre esperienze che sono altrettante esperienze di senso e di sensi: La verità su Dio, Uomini della tv, La caduta di Roma, Guida di viaggio, Il libro di Isaia. Ma si tratta di due saggi molto diversi: in versi e molto narrativo il primo, che si apre quasi con una dichiarazione lirica (Io), una lirica la cui soggettività – che è appunto, storicamente, la sua caratteristica principale – si diffonde, si disperde, si confonde nel testo, per sovrapporsi con Emily Brontë, la cui lettura accompagna la poeta-narratrice e si fa occasione di una identificazione straniante, quasi una sorta di presta parola per elaborare il trauma della perdita (la fine di un amore, il distacco dai genitori).
Un saggio argomentativo e in prosa, invece, l’ultimo, Il genere del suono, in cui Carson si interroga sulla repressione del femminile a partire dalla loro voce, chiamando in causa personaggi mitologici e letterari che si “rendono discutibili per il modo in cui usano la loro voce”, come la Gorgone, le Furie, le Sirene, il balbettio di Cassandra, il chiasso di Artemide, l’ossessionante garrulità della ninfa Eco. Il suono è considerato come una sorta di autobiografia, ha “un interno assolutamente privato ma la sua traiettoria è pubblica. Un pezzo di dentro proiettato all’esterno. La censura di tali proiezioni è uno dei compiti della cultura patriarcale che (come abbiamo visto) divide l’umanità in due specie: chi può autocensurarsi e chi no”.
Può interessarti anche
Il suono come autobiografia, censura e autocensura (dunque: repressione), può anche essere una chiave di lettura per questo testo così eterogeneo in cui la realtà appare come filtrata da uno schermo trasparente (il vetro, la luce, la neve, la televisione) che contemporaneamente la illumina, la chiarisce, e la modifica, la rende obliqua, mediata.
Lo sguardo diviene, così, non solamente uno strumento di percezione, ma quasi un luogo da abitare: “Perché continuare a guardare? / Alcune persone guardano, è tutto ciò che posso dire. / Non c’è nessun altro posto dove andare”. Così gli occhi possono diventare anche quelli del paesaggio, soprattutto quelli della brughiera, luogo materno, talvolta ostile, con cui l’io si scambia i connotati. Ma questi occhi, questo sguardo, può essere anche quello di qualcun altro, come appunto Emily Brontë, la cui lettura è insieme cura, dispossessione del sé e avvicinamento agli altri: “Ho Emily aperta a p. 216 appoggiata sulla zuccheriera / ma di nascosto sto guardando mia madre”.
La scrittrice, così, fa quasi da guida e Cime tempestose da viatico: e le immagini del viaggio e della guida sono davvero onnipresenti in questo libro: dalla ricerca problematica e difficile di una divinità in cui non si riesce a credere (“La mia religione non ha senso / e non mi aiuta / quindi la professo”) e non di rado espressa con leggera (ma non per questo meno amara) ironia: “His father and grandfather are called Jesus too. / They account me a fool with my questions about salvation. / They say they are saving to move to Los Angeles” – e si potrebbe avvicinare, così, Carson a quella linea (anti-)metafisica che, per guardare al nostro Novecento, conta i nomi del Montale del Diario del ’71 e del ’72, il Landolfi del Tradimento, l’ultimo Caproni e arriva fino all’Enrico Testa di Ablativo.
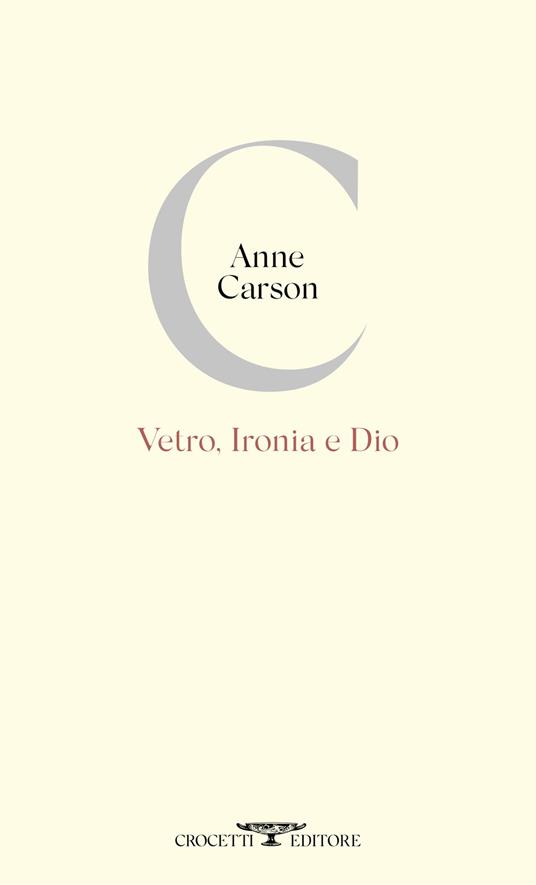
Ma il viaggio è anche un viaggio fisico, che già apre la raccolta (sempre da Io: “Domani andrò da mia madre”) e si fa tema centrale ne La caduta di Roma: Guida di viaggio, in cui l’indicazione quasi turistica si ribalta per farsi meditazione sullo straniero, come già avverte, nomen omen, il personaggio-guida di Anna Xenia, che sta lì a indicare il concetto di ospitalità e dei rapporti fra ospite e ospitante: “In che consiste la sacralità del cittadino? / L’aprire // un giorno // a uno straniero / che non ha un giorno / tutto suo”.
Lo straniero è anche, in questo testi, lo stranio, l’estraniazione, lo straniamento, che fin dai primi versi investe direttamente la persona che dice io: “A quest’ora domani sarò un uomo di Roma” e si sottopone a continui processi di metamorfosi fino a perdere connotati stabili e a abbracciare una pluralità di possibilità, di identità plurime:
Può interessarti anche
Sì, questo è il mio (nostro) primo viaggio a Roma.
Sto (stiamo) facendo un soggiorno di primo’ordine.
Posso presentarvi mia (nostra) moglie (marito,
figlio, figlia, madre, padre, amico,
amica)?
Si consuma, così, il passaggio dall’esperienza del moto all’interrogazione esistenziale e non si fa davvero fatica a capire che dietro a molte di quelle situazioni sulla romanità quotidiana si annida una continua riflessione su ciò che ci rende stranieri ai noi stessi e agli altri, il dolore, il lutto, la perdita, la solitudine, la malattia: “Forse pensate che io parli di fusi orari, / e di un pizzico di insonnia, // un po’ della noia del viaggiatore // No. / Mi secca disturbarvi, ma sto parlando proprio del male”.
È un male che spesso si fa oggetti e carne: “aveva crudeltà accumulata in tutte le crepe del corpo / come neve primaverile”, si fa spazio abitato o un ospite che viene a visitarci: “Poi rientro in hotel. / Tolgo il grande cappotto. // Appendo // i pantaloni enormi. / Mi siedo ad aspettare / l’incubo”. Strania i personaggi da se stessi: come l’Ettore omerico, Artaud, Socrate, Saffo, raccontati come in un set televisivo (nella sezione Uomini della tv).
E rende stranieri, diversi, gli altri: “Fu terribile vedere l’amore tra Law e me / trasformarsi in due animali che si rodono e bramano / l’un l’altro”; talvolta anche irriconoscibili, come avviene nel testo sulla visita al padre malato di Alzheimer – che per certi versi ricorda un altro bellissimo racconto di un’altra grande scrittrice canadese, The bear came over the mountain di Alice Munro.
E di nuovo, come spesso avviene in questo libro, che fin dal titolo la mette in evidenza, l’ironia rischia di essere il più struggente degli artifici: dove la commozione è allontanata, è proprio lì che rientra dalla finestra: “Mi chiedo come si fa a pulire i denti ai matti”.
Vetro, ironia e Dio sono dunque non i temi di questo strano libro, ma forse ne sono proprio gli strumenti, strumenti di allontanamento, dispossessione, straniamento: gli strumenti con cui si fa esperienza dello straniero, e forse l’ultima chiave di lettura può venire, di nuovo, proprio dal saggio finale, apparentemente così scollegato dal resto e, a ben guardare, così perfetto a suggello di questo libro: “Mi chiedo se non ci possa essere un’altra idea di ordine oltre alla repressione, un’altra nozione di virtù oltre all’autocontrollo, un altro tipo di soggettività umana che non sia basata sulla separazione tra intero e esterno. O, addirittura, un’altra essenza per gli esseri umani oltre al soggetto stesso”.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it



