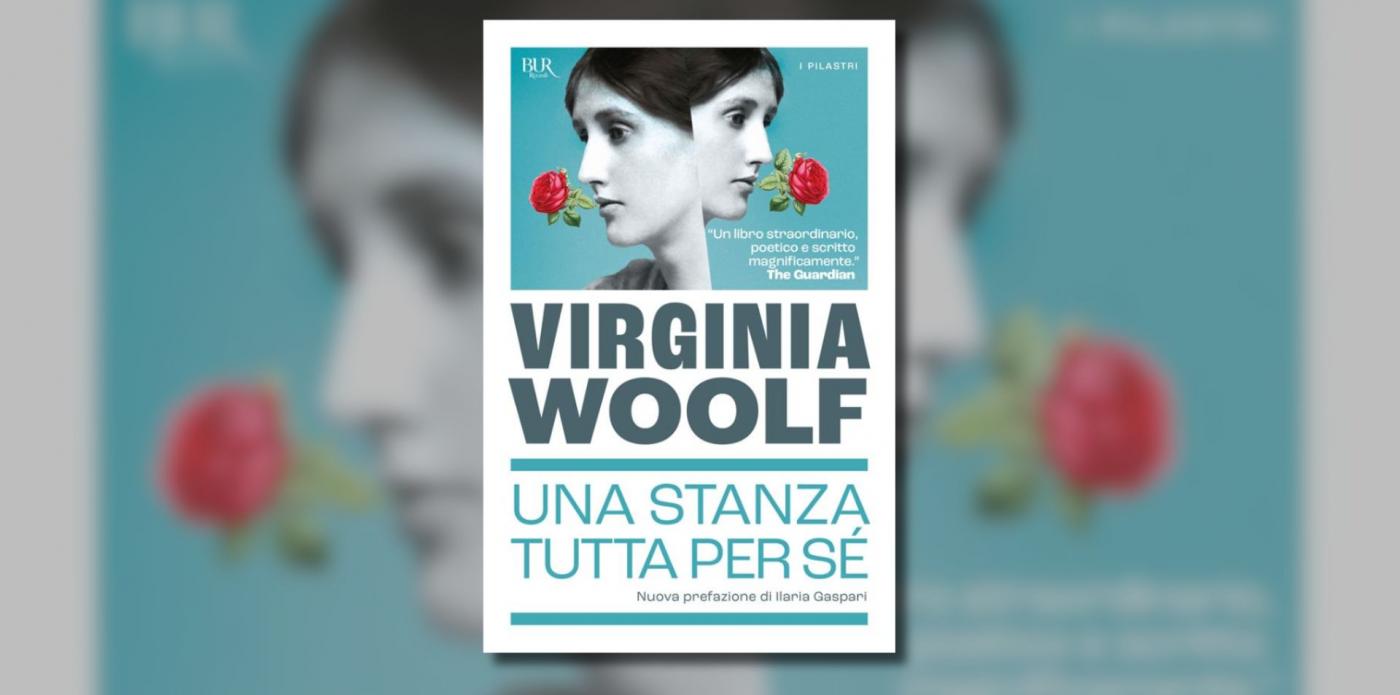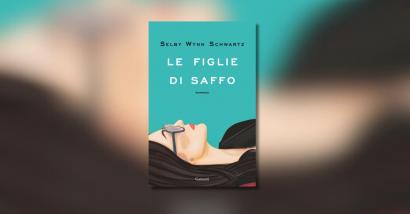“Ma si è mai visto un classico che inizia con un ‘ma’? Certo, non c’è testo che nasca classico: se lo diventa, accade nell’incontro con chi lo legge, lo cita, lo travisa magari, lo ascolta e scopre che non finirà mai di dire quello che ha da dire. E attraverso tutti questi strapazzi gli infonde vita…”. Su ilLibraio.it la prefazione, a cura di Ilaria Gaspari, alla nuova edizione di “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf (1882 – 1941). Un classico del pensiero femminista, pubblicato per la prima volta nel 1929, che ancora oggi non perde forza e attrattiva grazie allo stile dell’autrice e alla capacità di Woolf di raccontare la condizione di molte donne, alla ricerca di un proprio spazio… Ma, soprattutto, “un libro bello: beffardo, divertito, furibondo, con compassata eleganza sovverte la crudeltà impersonale di secoli di sopruso”
Chiamatemi Mary
Ma si è mai visto un classico che inizia con un “ma”? Certo, non c’è testo che nasca classico: se lo diventa, accade nell’incontro con chi lo legge, lo cita, lo travisa magari, lo ascolta e scopre che non finirà mai di dire quello che ha da dire. E attraverso tutti questi strapazzi gli infonde vita, come nei miti antichi succede a certe statue che incominciano a vivere per la forza infusa dall’ammirazione. Una stanza tutta per sé è a tutti gli effetti un classico: continua a parlarci mentre sta per compiere un secolo. È un classico anche perché citato talvolta a sproposito; perché leggerlo significa scoprirlo diverso da come lo immaginavamo. Il suo titolo viene tirato in ballo con una frequenza degna di una frase fatta; ma nella conversazione comune emerge dimezzato il nocciolo essenziale del discorso che Virginia Woolf, con cavalleresca cortesia di conferenziera, si prefigge di donare al suo pubblico, ovvero la sacrosanta verità che “se vuole scrivere romanzi, una donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé”.
Può interessarti anche
La rendita non si menziona quasi mai. Si parla solo della stanza: un po’ sarà perché il testo venne alla luce con questo titolo definitivo, a sostituire il più scialbo Le donne e il romanzo. Un po’, forse, perché nonostante tutto continua a pesare sulla vita delle donne un certo tabù finanziario. Il pubblico di studentesse cui si rivolgeva in origine Virginia Woolf nel corso di cent’anni si è dilatato, sorpassando i confini di geografie trasformate, di gerarchie sovvertite da emancipazioni che proprio questo saggio ha contribuito a incoraggiare. Ma persiste il problema di un divario salariale da cui si dipanano, per le donne, pesanti conseguenze sociali, economiche, intellettuali. Rimane traccia di un antico pregiudizio religioso sulla presentabilità del denaro, come anche di una struttura giuridica patriarcale che, benché smantellata dalla legge, emette ancora le radiazioni della sua presenza venefica. Per fortuna, ci sono testi la cui lettura funziona proprio da antidoto a questi miasmi. E Una stanza tutta per sé è un contravveleno formidabile.
È, del resto, uno di quei libri che, come sassi lanciati in uno stagno, imprimono una vibrazione che increspa l’acqua in circoli sempre più larghi, finché la perturbazione non si allarga alle rive e nemmeno un centimetro della superficie, così calma fino all’impatto col ciottolo, può mantenere lo stato d’inerzia iniziale. È, soprattutto, un libro bello: beffardo, divertito, furibondo, con compassata eleganza sovverte la crudeltà impersonale di secoli di sopruso.
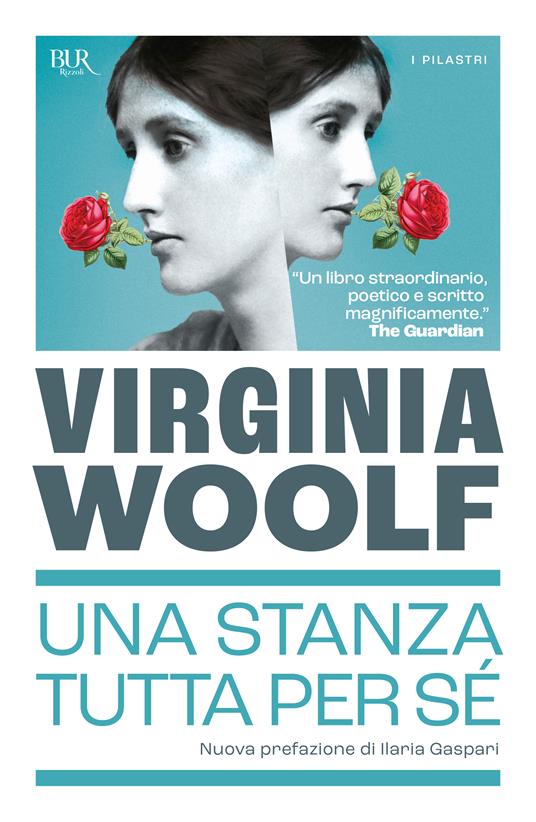
Chiamarlo saggio sarebbe riduttivo, a meno di intendere il saggio nella sua forma più spericolata, più eccentrica e più antica, ovvero quella in cui lo modellò l’esorbitante energia dello spirito di Michel de Montaigne alla fine del Cinquecento, mentre le donne – le signore e signorine di cui Virginia Woolf cercherà di immaginare le vite, furiosamente compulsando i libri, firmati da uomini, che trova negli scaffali della biblioteca – consumavano, nell’adempiere a doveri e cure imposte, i loro giorni: giorni di cui, perciò, non rimane segno se non nell’alveo dell’invenzione popolare, che tiene traccia delle parole tessute insieme in filastrocche, nenie, fiabe, ma non dei nomi. Le vite di queste signore e signorine vanno ricostruite per via di pura immaginazione, perché non è stato loro permesso di essere autrici, perché non hanno avuto una voce cui fosse concesso di dire io e raccontarsi.
Può interessarti anche
Come invece è concesso a un Montaigne, che difatti inventa la forma saggistica ariosa e mutevole in cui, tre secoli e mezzo più tardi, Virginia Woolf intesserà il suo pensiero, trascendendo biografia, autobiografia, inchiesta e riflessione. Una stanza tutta per sé è una magnifica fricassea di pensieri, un capriccio e uno studio sulla storia della letteratura in cui il dato più pragmatico, più fisico, più quotidiano della vita – il denaro, certo; ma pure il cibo – occupa un posto preminente. È anche questa una rivendicazione orgogliosa: gli scrittori raramente dedicano qualche parola a descrivere portate di salmone e carne d’anatra, osserva la narratrice invitata a pranzo in un college maschile dell’immaginaria cittadina di Oxbridge, crasi fra le due roccaforti britanniche della formazione universitaria. Ma a spingerla a rompere l’omertà sul tema, a considerare l’importanza del vitto facendolo rientrare nella traiettoria concettuale della relazione fra donne e romanzo, non sarà quel tripudio di pernici e vini prelibati, bensì la parca cena servita la sera al college femminile, la zuppa esangue che lascia intravedere il piatto in trasparenza, la fame che persiste, e la considerazione che “non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è cenato bene”.
Può interessarti anche
Torniamo però all’inizio, alla prima pagina, anzi alla prima parola. All’avversativa che spezza il periodo prima ancora che cominci: “But, you may say…” È un intoppo, un ostacolo contro cui fa attrito il pensiero, ma anche l’ingresso all’avventura; il primo passo su un sentiero che si inerpica fra rêverie, fantasia bibliografica e ricostruzione storica, rassegna gastronomica e polemica. La voce che comincia dal ma non mira a inamidate, austere pomposità professorali: è una voce proteiforme che fa della divagazione un incanto, che cambia di continuo passo e tono; che s’illanguidisce nella passeggiata su un edenico prato riservato a membri del college e studiosi (tutti maschi), da cui il custode accorre infatti a cacciarla, con un comico zelo che non riesce però a zittirla, questa voce irriducibile. La quale prosegue il racconto, si arrochisce nella collera, si distende nell’ironia. È una voce giovane: le sue parole arrivano fresche anche dalle profondità della biblioteca del British Museum, così simile a una gran fronte convessa e calva, alle teste degli autori degli innumerevoli libri sulle donne firmati da mano maschile che la narratrice consulta, sentendosi niente più che “un pensiero” dietro quella fronte così seria. E poi si alza ancora, la voce, a tessere – un po’ come fa Aristotele nella Metafisica, quando ricostruisce la tradizione dei primi anni di vita della filosofia – una ragnatela di corrispondenze e rimandi fra le tracce lasciate dalle scrittrici: quelle che hanno potuto firmare i loro lavori, malgrado le limitazioni che hanno precluso loro l’accesso alla “integrità” romanzesca da cui la letteratura prende slancio; e quelle i cui nomi sono ipotesi, perché la storia ce li consegna solo in questa forma.
La femminilità intesa come virtù da esercitarsi sotto tutela maschile è stata, nei secoli, un’autentica forma di oppressione; il ricatto della mancata autonomia di spazio, tempo e denaro, ha imposto a generazioni di donne un silenzio che ne rende giovane la tradizione letteraria, com’era giovane la tradizione filosofica ai tempi di Aristotele. Perciò, in contrasto con la pedanteria paternalistica sciorinata nei titoli dei troppi libri scritti sulle donne, ma non dalle donne, suona tanto più deliziosa questa voce narrante di folletto, che non si lascia acchiappare, rompe schemi retorici e intanto rivendica le condizioni materiali della libertà intellettuale.
Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it
L’autonomia finanziaria dà forma a questa libertà perché annulla il risentimento, permette di scrivere inseguendo il piacere e non una qualche forma di riscatto. Woolf abbozza una genealogia della morale come affrancamento dalle piccinerie che troppo a lungo hanno tenuto sotto scacco le donne, sorvegliate e ricattate; ma, invece di costruire un ragionamento tutto teorico intorno all’importanza dell’autodeterminazione economica e intellettuale, la racconta come un’esperienza di vita. Cosicché gli accidenti più pragmatici dell’esistenza prendono una sfumatura di poesia particolare proprio dalla concretezza che finalmente è loro attribuita: negare alla vita vino e calore, o la miriade di minuscole epifanie che le danno forma, o al pensiero il privilegio di superare i cancelli chiusi, equivarrebbe a condannarsi a non mangiare che le famigerate brodaglie trasparenti servite al college femminile, e tenersi per dolce le prugne con la crema, “legnose come il cuore di un taccagno”. La meschinità del corpo è meschinità del cuore: ne abbiamo avuto abbastanza, è ora di buttare all’aria convinzioni e convenzioni inveterate. E, per esempio, iniziare un ragionamento con un “ma”: come una conversazione interrotta. Perché non si contano le interruzioni che hanno punteggiato le conversazioni, le imprese, le opere delle donne che compaiono in Una stanza tutta per sé.
Jane Austen, per esempio, scrive nella stanza di soggiorno, fra chiacchiericci e scalpiccii (“all’inizio dell’Ottocento nelle case della classe media c’era un’unica stanza adibita a soggiorno”), e al cigolio della porta che annuncia l’arrivo di un visitatore si affretta a coprire il manoscritto con un foglio di carta assorbente.
Può interessarti anche
“Le donne non hanno mai una mezz’ora … che possano considerare tutta per loro”, lamenta Florence Nightingale. Nell’alienazione continua del tempo e dello spazio delle donne, quanto talento si sarà dissipato? Le canzoni, le filastrocche, le litanie con cui si cullano i bambini, le fiabe raccontate per ingannare il buio della notte, sono state, con ogni probabilità, cucite da voci di donne. Voci anonime, dimenticate, hanno trovato e composto insieme le parole, hanno consacrato i loro sforzi a un immenso movimento invisibile di cui in superficie non è affiorato che qualche sparuto nome isolato; e talvolta è pure uno pseudonimo. Ma a che prezzo? Lo sanno George Eliot, che dovette scontare la riprovazione del mondo per una convivenza sconveniente, le sorelle Brontë confinate alla brughiera, Aphra Behn che per prima si guadagnò da vivere scrivendo. E certo Jane Austen che, se non avesse dovuto coprire il manoscritto con la carta assorbente all’ingresso di qualsiasi estraneo, chissà fino a dove si sarebbe potuta spingere.

Virginia Woolf (GettyEditorial 05-02-2020)
E tutte le altre? Le altre sono fatiche e talenti che non hanno trovato lo spiraglio da cui emergere. Sono nomi nemmeno scritti nell’acqua; nomi che devono essere inventati, perché soltanto l’immaginazione può supplire all’oblio. E la genialità esiste solo in forma di ipotesi, e qualche volta persino l’ipotesi è impossibile. È il caso di Judith Shakespeare, immaginaria sorella di William: figura d’invenzione (cui Woolf attribuisce quello che in realtà fu il nome di una figlia del drammaturgo), modellata come prova controfattuale dell’attrito che soffoca il genio femminile. Difatti Judith, pur “meravigliosamente dotata”, non può seguire la propria vocazione creativa se non sfuggendo a imposizioni sociali che la vorrebbero sposa dedita al lavoro domestico: lei scappa, invece, e la solitudine cui la fuga la condanna ne farà la preda di un seduttore. E quando si scopre incinta, si suicida.
Può interessarti anche
Ecco perché è così importante che questo libro inizi con un “ma”. Altrettanto importante – e bizzarro – è che nelle prime pagine di questo testo scritto in origine per una conferenza, la conferenziera domandi a chi ascolta di dimenticare il suo nome, e si inabissi in una piccola folla di Mary: “Eccomi, dunque (chiamatemi Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o con qualunque altro nome vi aggradi – non è questo che importa)”. Come in un prisma, l’io narrante si rifrange nelle figure delle protagoniste di una famosa ballata scozzese del XVI secolo, che canta le dame di compagnia della regina di Scozia e si intitola Mary Hamilton: il suo nome non appare che nel titolo, ma è lei – destinata a suicidarsi per essere rimasta incinta, proprio come l’evanescente Judith Shakespeare – la voce della canzone. La bizzarria dell’apostrofe assume un nuovo senso se consideriamo che per molti secoli rinunciare al proprio nome è stato per le donne un atto dovuto, il pegno pagato all’istituto del matrimonio. E l’io della narratrice scompare in una pluralità di voci e di fatiche, nel racconto della prosaica consunzione quotidiana. Se Una stanza tutta per sé è “un’autobiografia economica mascherata”, come ha scritto Hermione Lee, è anche un libro universale, che si realizza nel dissolversi dell’io in una voce polifonica. Di fronte all’impossibilità di rintracciare una vera e propria tradizione letteraria femminile, e alla conseguente difficoltà di trovare una lingua comune – paragonabile a quella che condividono e parlano i romanzieri, i drammaturghi, i poeti e i saggisti, forti della compatta tradizione che loro, invece, hanno a disposizione – il saggio di Virginia Woolf si trasforma in una rivendicazione della libertà creativa, dell’invenzione, addirittura del gioco.
Il prato su cui il custode trafelato corre incontro alla narratrice rappresenta, con molto realismo, la concretezza di un limite imposto. Ma proprio a partire da quel divieto, il pensiero inafferrabile, sognante e linguacciuto, della nuova Eva cacciata dal giardino accademico si tramuta in un’elegia dello sconfinamento. In un vagabondaggio che, paradossalmente, trascende la stanza tutta per sé nella possibilità di un allargarsi infinito dell’orizzonte, sotto il segno di quel famoso pensiero di Pascal secondo il quale i mali della terra derivano dal non sapere, gli uomini, restarsene chiusi in una stanza: per cui si inventano le guerre, e la caccia, e la continua sfida distruttiva ai propri simili, e quella bramosia di onori che Virginia Woolf condensa nell’espressione dell’istinto di possesso.
Può interessarti anche
Questa scorribanda del pensiero, che si chiude con l’immagine quasi messianica di un futuro trionfante in cui il coro delle voci si faccia davvero plurale, e maschile e femminile trascolorino nell’androgino, superamento dialettico delle opposizioni che storicamente hanno imprigionato la parola – come nella fantasticheria di Orlando, uno dei più grandi romanzi mai scritti sul tormento e l’estasi della creatività – è un lussureggiante esercizio di liberazione.
Non è insomma un saggio sulla stanza come spazio di clausura ma, al contrario, sull’apertura che l’autonomia, spaziale ed economica, sola, permette. Mostra con una forza plastica impressionante cosa significa oltrepassare i confini, e infatti prende la sua forma specifica nel superamento del proprio limite: fondendo forma e contenuto, poetica e pragmatica della parola, nella dialettica di una trasformazione in corso. È buffo, e molto appropriato, che il coronamento di questa straordinaria impresa intellettuale, della stesura febbrile di questo testo il cui manoscritto si eclissò in una catalogazione erronea, sia il suo esito più materiale. Anzi: architettonico. I proventi di Una stanza tutta per sé furono infatti tramutati in un’estensione – una stanza per la scrittrice – alla casa dei coniugi Woolf. Mentre scrivo queste righe finali, negli ultimi giorni dell’estate del 2025, un’amica di ritorno da una vacanza inglese mi manda una fotografia. È il piano terra di Monk’s House. E mi confessa, nel messaggio a didascalia dell’immagine, di essere entrata nel giardino, e aver rubato una mela. Nessun custode, per fortuna, è accorso a cacciarla.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
UNA STANZA TUTTA PER SÉ – Pubblicato per la prima volta nel 1929, Una stanza tutta per sé nasce da una serie di conferenze tenute da Virginia Woolf (1882 – 1941) nei college femminili di Cambridge e, nonostante gli anni trascorsi dalla pubblicazione, riesce a essere ancora oggi attuale e incisivo nel discorso pubblico. In queste pagine Woolf non si limita a denunciare l’esclusione delle donne dal mondo letterario e intellettuale, ma evidenzia come alcune autrici, Jane Austen su tutte, siano riuscite a combattere la visione patriarcale ed emergere con il proprio lavoro. Il 14 ottobre Bur – Rizzoli porta in libreria una nuova edizione di questo classico, curata e tradotta da Egle Costantino e con la prefazione di Ilaria Gaspari – proposta qui sopra.
L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, scrittrice, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Dal 2015 collaboratrice di ilLibraio.it, scrive per diverse testate e collabora con radio, tv e scuole di scrittura.
Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi) e, sempre con Einaudi, Vita segreta delle emozioni. Nel 2022 per Giulio Perrone editore è uscito A Berlino – Con Ingeborg Bachmann nella città divisa. Con Emons, (e con il sostegno dell’Institut Français Italia), sempre nel 2022, ha curato e condotto il podcast Chez Proust. Per la collana digitale Quanti di Einaudi ha inoltre pubblicato il saggio breve Cenerentole e sorellastre – Una botanica della bellezza.
Guanda a marzo 2024 ha pubblicato il suo secondo romanzo, La reputazione, in cui la scrittrice affronta temi stringenti della nostra contemporaneità. Da poco è tornata in libreria con il racconto lungo L’hotel del tempo perso – Non rubare, un giallo a tinte filosofiche che omaggia Agatha Christie e le sue atmosfere, uscito in una nuova collana Rizzoli ispirata ai dieci comandamenti.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it