“La questione dell’identità meticcia è uno dei temi che mi guida fin da quando ho cominciato a scrivere (e quindi, a vivere). Mai fino a oggi l’avevo affrontato con tale sfrontatezza. Conosco l’imbarazzo dell’esclusione. Da una vita mi sento ebreo tra i cattolici e cattolico tra gli ebrei. ‘Di chi è la colpa’ è anche questo, il romanzo di un eroe che è sempre nel posto sbagliato, e non sa come uscirne”. Alessandro Piperno si racconta a ilLibraio.it in occasione dell’uscita del suo nuovo libro. Nell’intervista parla di temi a lui cari e della sua idea di letteratura. E ammette: “All’inizio scrivere era un tormento, sempre lì a scervellarsi alla ricerca dell’effetto spettacolare. Pian piano ho imparato a lasciarmi andare e a divertirmi”. Poi aggiunge: “Spero che a questo punto della carriera la mia prosa appaia più ironica che sarcastica. Trovo il sarcasmo una scorciatoia facile, e l’ironia, invece, un’opzione complicata e proficua”. Non mancano le prese di posizione sulla narrativa contemporanea: “Trovo deplorevoli i libri (ce ne sono parecchi in circolazione) che sembrano essere stati pensati a tavolino come una serie tv”. E ancora: “Detesto i romanzi a tesi o le opere engagé…”
Alessandro Piperno esordisce nel 2005 il romanzo Con le peggiori intenzioni (Mondadori): un debutto folgorante, che avvince critici e lettori grazie a una scrittura colta, ironica e tagliente, e con cui si inserisce a pieno titolo nel novero dei grandi scrittori italiani. Un ruolo che conferma negli anni venire: a fortunati pamphlet saggistici si aggiunge infatti il dittico del Fuoco amico dei ricordi, composto dai romanzi Persecuzione (Mondadori, 2010) e Inseparabili (Mondadori, 2012), che gli vale il Premio Strega 2012, mentre del 2016 è Dove la storia finisce (Mondadori).
Piperno torna ora in libreria, sempre per Mondadori, editore a cui è rimasto fedele, con Di chi è la colpa, un romanzo che l’autore stesso definisce ‘vittoriano‘, una vicenda che potremmo definire di formazione, in cui un giovanissimo protagonista senza nome si trova ad affrontare drammi intimi che si propagano nei suoi rapporti con il mondo, nelle sue scelte di vita e nella sua percezione dell’altro e di se stesso. Una vicenda familiare di verità nascoste, di astio mai davvero sopito, di attrazione e repulsione, di ripiegamento interiore. Ancora una volta Piperno racconta il singolo per raccontare una storia che parla a molti e di molti.
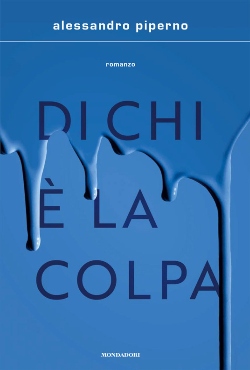
Piperno, da dove nasce Di chi è la colpa?
“Nasce dall’interazione fra il desiderio di offrire la mia versione di romanzo vittoriano, con tanto di peripezie drammatiche e spettacolari, e la necessità di dare forma narrativa a un paio di temi che mi dominano da che ho memoria: l’impostura e la colpa”.
Impostura e colpa che nel romanzo si intersecano ad altre due riflessioni tipiche della sua narrativa: quella sulle classi sociali e quella sulle relazioni familiari. In questo caso due diversi milieu si scontrano nel medesimo protagonista, attratto da una famiglia d’origine verso cui prova anche biasimo. Ci troviamo di fronte a una mimesi di stampo girardiano?
“Direi proprio di sì. Del resto, se ci pensa, non solo il romanzo borghese ma anche la vita di ciascuno di noi è dominata dal cosiddetto desiderio mimetico: ancora oggi l’intuizione antropologica più felice di René Girard. Anche gli amori apparentemente genuini sono indotti dall’imitazione e dallo snobismo. Non c’è scampo. Non se ne esce. È fatale: sin dalla culla si è portati a desiderare ciò che gli altri desiderano. E il mio giovane narratore, tutto fuorché un cuor di leone, non fa eccezione. Al netto dell’educazione austera e pauperista ricevuta in famiglia, un vero e proprio lavaggio del cervello, quando entra in contatto con le delizie offerte dal benessere e dal lusso ne rimane incantato e avvinto al punto da farne una malattia. Vien da chiedersi a questo punto se non sia l’adesione acritica a un modello che non gli appartiene a scatenare in lui il senso di colpa e il timore di essere un impostore”.
Può interessarti anche
Infatti il romanzo è pervaso dalla paura e dal rimorso. Il protagonista ha paura dei suoi sentimenti: teme di esporsi e, quando non lo fa, rimpiange di non aver dato libero sfogo a quello che prova ma, se si espone, vorrebbe non averlo fatto. Cosa ci racconta questo dissidio interiore dominato da un generalizzato timore?
“Il narratore sin dalle prime righe si definisce un ‘cacasotto’ ma ecco che, messo alle strette, di fronte ai rovesci della vita, quasi malgré lui, deve dare prova di un certo coraggio, purtroppo è sprovvisto della tenacia che il coraggio reclama. Da qui il dramma. Mi piace credere che i dubbi che lo affliggono abbiano una qualche rilevanza universale: chi di noi prima o poi non si è trovato a desiderare di alterare le proprie generalità, di stravolgere i connotati e di entrare a far parte di una famiglia nuova di zecca? Chi di noi non ha desiderato genitori migliori di quelli che gli sono capitati in sorte? Peccato che per lui l’impostura si riveli tutto fuorché una passeggiata. In fondo il suo nuovo status di privilegiato – o come dicono i francesi, di enfant gâté – è figlio di una serie di peripezie tragiche e cruente da cui non gli sarà facile riaversi. Ecco, in qualche modo lui si sente responsabile. Ciò rende impossibile ogni abbandono, e la colpa pressoché ineluttabile”.
Un altro tratto identificativo del protagonista, che si lega a questa paura atavica, è la tensione all’invisibilità: né ammirato né perseguitato, cerca di stabilizzarsi in una sorta di medietas. Questo desiderio di invisibilità si manifesta anche nell’assenza di nome del narratore/protagonista?
“Privare il protagonista di un nome proprio – oltre che un omaggio palese alla Recherche proustiana – si è rivelata sin dal principio un’esigenza narrativa fortissima. Mi piaceva l’idea che il narratore potesse assurgere a pura coscienza. Una coscienza critica, introspettiva, in preda a fosche inutili ubbie morali. Inoltre, non le nascondo – anche se ciò ha poca importanza – che in nessun mio libro precedente ero riuscito a creare una sintonia così simbiotica tra personaggio e autore. Sono stato tentato di chiamarlo Alessandro Piperno. Ma converrà con me che si sarebbe trattato di un espediente a dir poco corrivo. Ciò detto, lei ha ragione: il libro è costruito su una minuta, deliberata strategia dissimulatoria. Fornendo le generalità al protagonista avrei corso il rischio di togliergli un po’ di vita e parecchio mistero”.
In questo romanzo torna alla narrazione in prima persona, a quale esigenza risponde questa scelta?
“Che posso dirle? Se avessi maggiore consapevolezza dell’itinerario dei miei processi competitivi, se riuscissi a identificarli immediatamente e illustrarli a me stesso, sarei uno scrittore migliore, di certo più prolifico. Comunque, dovendo proprio rispondere, le dirò che questo romanzo non avrebbe potuto essere scritto altrimenti. Ma la prego di non chiedermi la ragione: la ignoro. Una cosa però vorrei dirgliela. Negli ultimi anni ho fatto un uso smodato e disinvolto della prima persona: soprattutto nei miei saggi narrativi sul Corriere della Sera. Nel farlo ho ritrovato un agio che credevo oramai compromesso. Mi rinfrancava constatare come questa nuova voce avesse poco a che spartire con le querule risentite elucubrazioni di Daniel Sonnino, il protagonista di Con le peggiori intenzioni, l’eroe del mio fortunato romanzo di esordio. Sentivo che il tono si era fatto più morbido, suadente e ironico, e per questo assai congeniale a un’opera narrativa. Perché non provare a scriverci un romanzo? Il rischio semmai era smarrirsi in una selva di esercizi digressivi e rapsodici. Per evitare questo pericolo mi sono affidato al modello rigido e inflessibile offerto dal romanzo vittoriano. Mentre scrivevo vedevo Charles Dickens e George Eliot che, dagli scaffali in cui ho riposto i loro libri assoluti, mi guardavano in cagnesco. Il monito era sempre lo stesso: non perdere la bussola, non sbarellare. Spero di esserci riuscito”.
Può interessarti anche
Nel protagonista, figlio di madre ebrea e padre non ebreo, all’ambivalenza nei confronti della famiglia d’origine si aggiunge anche una tensione dettata dalla tardiva scoperta di appartenere a una religione diversa da quella che pensava.
“La questione dell’identità meticcia è uno dei temi che mi guida fin da quando ho cominciato a scrivere (e quindi, a vivere). Mai fino a oggi l’avevo affrontato con tale sfrontatezza. Conosco l’imbarazzo dell’esclusione. Da una vita mi sento ebreo tra i cattolici e cattolico tra gli ebrei. Di chi è la colpa è anche questo, il romanzo di un eroe che è sempre nel posto sbagliato, e non sa come uscirne. Per esacerbare il suo disagio ho fatto in modo che tra le due famiglie – quella cattolica e quella ebraica – ci fosse anche un siderale squilibrio sociale. Se il padre del protagonista, di famiglia cattolica, è un essere debole, infingardo, cialtrone, ma a suo modo dotato di una straripante umanità, la madre ha ereditato dalla famiglia ebraica le tipiche tracotanze appannaggio delle classi agiate, settarie, inclini all’autocelebrazione. Rispetto al padre e alla madre, il mio personaggio ha un vantaggio: non è né carne né pesce, è un bastardo, un déraciné. Ciò gli consente di valutare le sue due famiglie con un certo distacco panoramico. Vede i difetti di una confessione e le storture dell’altra, e per così dire se ne fa carico”.
Il suo stile è sostenuto dal sarcasmo e dall’ironia, in che modo questi aspetti giocano a favore della narrazione?
“Spero che a questo punto della carriera la mia prosa appaia più ironica che sarcastica. Trovo il sarcasmo una scorciatoia facile, e l’ironia invece un’opzione complicata e proficua. Il sarcasmo è monotono, l’ironia è flessibile, eclettica. Le confesso, inoltre, che alle soglie dei cinquant’anni ho difficoltà a leggere opere narrative non rischiarate dalla luce dell’ironia. Per questo detesto i romanzi a tesi o le opere engagé. Le ideologie, così come le cause perse e i programmi elettorali, nuocciono alla narrativa. Gli scrittori che amo sono accumunati da una vena comica, talvolta spavaldamente satirica: che sia Flaubert o Kafka, Proust o Nabokov, Bellow o Cheever, Svevo o Parise, per godermi un pezzo di narrativa devo sentire un senso di distacco tra il dramma narrato e chi lo racconta. Un’adesione completa mi disturba”.
Può interessarti anche
Di opera in opera il suo stile si è modificato, un processo per certi versi fisiologico avendo lei esordito molti anni fa. Ci racconta questo percorso?
“È molto difficile percepire la propria evoluzione stilistica ‘dall’interno’. E tuttavia non mi nascondo, lo so, lo sento: qualcosa è cambiato. Diciamo che il mutamento è avvenuto naturalmente, per gradi, e mi sa proprio che il tempo ci abbia messo lo zampino. È così che funziona. Invecchiando la voce di un narratore si fa più roca e e profonda, come il timbro di un cantante blues. Quel che posso dirle è che nel corso degli anni si è modificato soprattutto il mio approccio alla scrittura: all’inizio scrivere era un tormento, sempre lì a scervellarsi alla ricerca dell’effetto spettacolare. Pian piano ho imparato a lasciarmi andare e a divertirmi, tutto a vantaggio di fluidità e naturalezza, senza per questo tradire i miei stilemi: l’alternanza tra forbitezza e tono colloquiale, l’ipotassi, il ricorso continuo all’interlocuzione, il gusto per la divagazione”.
Nella pratica, come avviene il processo di scrittura di un romanzo, qual è la genesi “tipica” di un romanzo di Alessandro Piperno?
“L’inizio è un sempre uno strazio. Mi ci vuole un sacco di tempo prima di iniziare a divertirmi. Finché non arriva il momento in cui avverto di avere il libro in pugno, allora si addensano nuovi spettri: tipo morire prima di riuscire a terminarlo. Comunque, di norma procedo lentamente, forse perché non riesco ad andare avanti se quello che ho alle spalle non mi persuade. Ho amici, per esempio Mario Desiati, che lavorano per stesure. Non so proprio come ci riescono. Ripeto: non posso andare avanti se quello che ho già scritto non è soddisfacente. Ciò non significa che alla fine anche io non debba sottoporre il romanzo a una revisione serrata. Può durare diversi mesi. Anzi, molto spesso solo allora, dopo che la parola ‘fine’ è stata scritta, il libro rivela i difetti più marchiani: di struttura, tono, equilibrio. Questo è un momento del lavoro molto piacevole. Come i ritocchi per un pittore. Un’altra cosa che posso dire è che quando scrivo un romanzo vado avanti un po’ a tentoni, alla cieca. Trovo deplorevoli i libri (ce ne sono parecchi in circolazione) che sembrano essere stati pensati a tavolino come una serie tv. Non mi piacciono i trucchetti da sceneggiatore. I ritorni furbi messi lì allo scopo di produrre un brivido facile e caduco. Preferisco fidarmi del libro, mettermi nelle sue mani: se è buono prima o poi rivelerà la sua natura benigna, e il dato buffo è che lo rivelerà proprio a te che l’hai concepito”.
Può interessarti anche
Passando all’ambientazione, che ruolo ha Roma nelle sue storie e, nello specifico, in Di chi è la colpa?
“Roma è onnipresente. Ma come avrà notato, nei limiti del possibile, ho cercato di evitare chiare indicazioni urbanistiche. Ciò non significa che mentre scrivevo non avessi chiaro in testa dove collocare le scene. Per esempio, casa Sacerdoti in cui svolge il Seder di Pesach che tanto peso avrà nella vita del protagonista si trova sull’Aventino: una di quelle palazzine signorili affacciare sui Fori… Però ho scelto di non esplicitarlo, perché solo così potevo dare il senso della vaghezza e dell’incanto che un adolescente inesperto, a suo modo provinciale, prova quando si trova immerso in un pezzo sconosciuto della sua città. Nelle mie storie, Roma funziona come un lenitivo: nell’explicit del romanzo, il narratore, dopo aver vissuto un’esperienza importante e dolorosa, s’immerge nella sua Roma: un luogo rumoroso, bello, antico, cinico e sporco. Solo allora capisce che lasciandosi andare ai clangori della città, la vita potrà acquisire di nuovo un senso. Diciamo che nessuna città meglio di Roma ti consente di mettere le cose in prospettiva. È una metropoli sostanzialmente ironica ed è evidente che, nel momento in cui scegli di ambientarci un romanzo, non puoi non farci i conti”.
Può interessarti anche
Quanto è importante per lei conoscere l’ambiente di cui parla? Parliamo di luoghi ma anche di relazioni, di ambiente sociale…
“Direi che rappresenta uno degli sproni fondamentali. Mi intriga il caleidoscopio sociale, così come mi avvincono le mille stratificazioni di una città e di un ambiente intese in senso balzachiano: è uno dei temi con cui da sempre amo misurarmi. Mi piace vedere gli altri vivere. Mi piace interrogarmi sui tic, le stravaganze, i gusti. Quando sono al ristorante adoro farmi i cavoli degli altri avventori. Mi illudo di saperli collocare. Mi piace immaginare dove vivono, cosa pensano, per chi votano, le aspirazioni che li animano. E Roma, da questo punto di vista, è un autentico giacimento aurifero, divisa com’è in microcosmi ermetici. Come dicevo, Roma si presta particolarmente a questi esercizi di bravura: è una città divisa in piccoli microcosmi ciascuno dei quali ha leggi molto precise. Tutto può essere rivelato da un segno distintivo: un capo d’abbigliamento, un’espressione gergale, un tatuaggio. Basta saperlo riconoscere. Una delle parti del romanzo che mi sono più divertito a scrivere è quella ambientata a scuola, un refugium peccatorum in cui si incontrano diversi milieu: l’ebreo di buona famiglia, l’aristocratico decadente, il proletario, il borghese sinistrorso, l’arricchito. Sa, da qualche mese mi sono trasferito all’Esquilino, un quartiere che somiglia a Belleville, allo stesso tempo borghese e multietnico. Ogni tanto mi piace passeggiare partendo da San Giovanni, passando per l’Esquilino e spingendomi fino a Monti. Non ci crederà, ma da un isolato all’altro l’atmosfera cambia radicalmente: è come passare da un film sugli indiani, a un quadro di David, a un romanzo di Jane Austen. Tutto questo mi commuove e mi fa ridere”.







