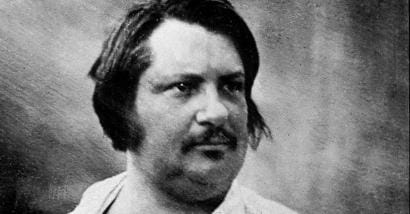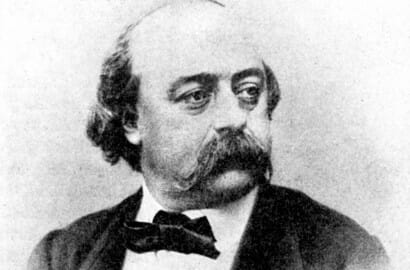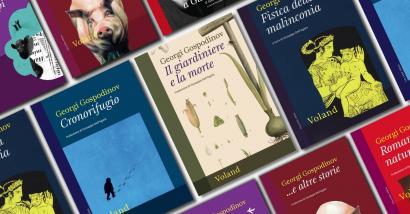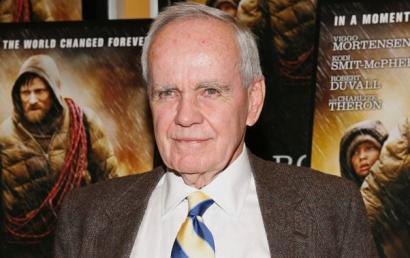Cosa tiene insieme quei libri in cui si distillano decenni di riscritture e ossessioni? A guardare “Il Mago”, capolavoro di John Fowles, che di questa famiglia è un esempio paradigmatico, si potrebbe pensare che sia il gesto di conquista di un nuovo territorio, l’esplorazione di una terra sconosciuta. Quale sia questa terra, tuttavia, è difficile dirlo. “Il Mago”, romanzo in cui niente è ciò che sembra, ci introduce a un gioco che sbriciola qualsiasi concezione ingenua della realtà e crea, al suo posto, una vertigine o un abisso. Mentre ci chiediamo cosa possiamo conoscere, finiamo per domandarci in che mondo siamo. È questa la matrice da cui nasce la ricerca letteraria di Fowles. Scrittore postmoderno, si dice di lui, ma “Il Mago” dimostra la lenta costruzione di una strada solitaria, in cui i flussi di idee che attraversano tutto il secolo si saldano in un unico organismo vivo. In un presente che sempre più spesso sembra germogliare da un terriccio pynchonesco, l’esplorazione dell’autore forse ci introduce in un panorama diverso, non meno complesso, ma neanche meno ostinato nel cercare, quantomeno “per noi”, un appiglio che, come una bussola, permetta di seguire una rotta anche quando i punti cardinali sembrano dissolti…
Bisognerebbe pensare a qualcosa per tutti quei libri che hanno accompagnato i loro autori per decenni. Qualcosa, intendiamoci: il modulo a scelta di un esame universitario, un podcast in dieci puntate, l’attività eroica e finanziariamente creativa di un microeditore senza tema di fallimento, andrebbe bene anche una targa commemorativa in una biblioteca di provincia, qualsiasi cosa, insomma, che permetta di tracciare dei confini e osservare le dorsali, le radure e gli anfratti di un territorio pericolosamente enigmatico.
Accademicamente magari la categoria sarebbe anche sghemba. Troppa roba, troppo diversa. C’è una cifra segreta che unisce Tasso – la sua esigenza di conciliare l’inconciliabile (epica e cristianità, bellezza e dottrina, propaganda e innovazione: quello che vi pare) – a Rousseau, per esempio, alla sua domanda infinita: come dire la verità, senza filtri, su di sé, con un mezzo – il linguaggio – che è fatto per creare finzioni?
Ci sono punti di contatto tra il progetto di Balzac, guardare Parigi da uno spioncino e riprodurre nientemeno che la sua totalità sulla carta; quello di Flaubert, mettere in un libro tutto il sapere umano, tutta la sua insensatezza; e quello di Mallarmé, scrivere il Livre assoluto, pura potenzialità tramata dall’idea di dire il silenzio col silenzio stesso?
Proust e Kafka, Stein e Joyce, Musil e Bachmann, metteteci chi volete, il punto non cambia: c’è un filo che li attraversa?
Cos’hanno in comune quei testi scritti, poi riscritti, pubblicati, rinnegati e…?
Le cautele del buon senso direbbero no. Eppure c’è un’aria di famiglia – di famiglia felicemente disfunzionale – in tutti quei libri che invece della peristalsi di idea-scrittura-revisione-pubblicazione, affiorano lenti, coi modi di un malanno, di una contaminazione batterica, di una mutazione.
Cos’hanno in comune quei testi scritti, poi riscritti, pubblicati, rinnegati, pubblicati in seconda edizione ampliata o scarnificati da tagli autoriali, quei libri pubblicati postumi dopo revisioni accumulate in scala logaritmica, oppure frammentari, incompiuti, incompleti, quei testi costitutivamente tendenti all’infinito o al silenzio?
Può interessarti anche
Si potrebbe pensare alla mania: qual è il nome clinico di uno che sta, metti caso, vent’anni a perfezionare un’idea?, di uno che cambia una virgola che ha tracciato un decennio prima? Ma comunque non basta: “Che cos’hai fatto tutto questo tempo?”, scrive Malcolm Lowry, e sembra parlare al frammento ubriaco del suo libro impossibile, “ti ho scritto non so quante volte. Ti ho scritto finché non mi si è spezzato il cuore”.
Il Mago è figlio di una gravidanza complicata…
Ci aiuta in questo senso la pubblicazione de Il Mago di John Fowles, per i tipi di Safarà, in un’edizione a cura di Lucrezia Pei e Pasquale Donnarumma, tradotto da Gioia Zannino Angiolillo e Lucrezia Pei, perché in questa strana famiglia occupa un posto del tutto peculiare, soprattutto se lo si guarda in rapporto ai flussi di idee che nel Novecento attraversano il pianeta Letteratura come eserciti fatti solo di disertori, come eserciti alla deriva.

Il Mago chiaramente è figlio di una gravidanza complicata.
Fowles ci lavora dall’inizio degli anni Cinquanta, dopo due anni passati nell’isola di Spetsai, e lo pubblica nel 1965.
Le date ci dicono che è il suo terzo libro, ma Fowles avverte che è da considerarsi “in tutto e per tutto” come un primo libro. L’ultima revisione, questa pubblicata per la prima volta in Italia da Safarà, è del 1977: quindi Fowles ci lavora per circa venticinque anni.
Viene naturale chiedersi perché. Sarà per amore? Ci aveva già avvertito Lowry: non ci sono parole al miele per questo bambino che nel frattempo è diventato un adulto fatto e finito.
“Il diario di un’esplorazione, spesso errata e mal concepita, in una terra sconosciuta”
Nella prefazione del ’77, la prima pagina è densissima. Fowles lo include nelle “opere che professionalmente mi sono piaciute meno”; si lamenta che questo “storpio infinitamente torturato e rimaneggiato” abbia avanzato le sue pretese su altre idee “più presentabili”; parla della sua lunghissima gestazione nei termini di un fallimento infinito: “Il mio ricordo più vivido è quello di dover continuamente abbandonare le bozze a causa dell’incapacità di descrivere ciò che volevo”, ma poi arriva al punto: “Il Mago – scrive – “sotto la superficie della storia, era il diario di un’esplorazione, spesso errata e mal concepita, in una terra sconosciuta”.
Si potrebbe raccontare la storia di tutta la letteratura come la vicenda di tutti quei testi che, pur sembrando giocare partite differenti, sono accomunati solo da un puro gesto di volizione: dichiarare una guerra al linguaggio, alla realtà, alla percezione, all’immaginario, al principio di contraddizione, a tutto ciò che non sembra poter stare assieme e invece eccolo qua in formato tascabile; la vicenda di quei libri che testimoniano, prima di ogni distinzione, lo sforzo di guadagnare alla letteratura nuovi territori, farla passeggiare sul versante in ombra di un nuovo pianeta per piantare il suo vessillo, in quella che Fowles chiama “una terra sconosciuta”, anche se il sacrificio di questo rituale lo si paga nella vita di chi scrive.
Ora, salvo rarissime eccezioni, questa guerra richiede tempo, paga dazio in tributi di sangue, mira a conquiste impossibili: lo sapeva Proust, chiuso in una stanza foderata di sughero a dar seguito a un’intuizione lunga trent’anni, lo sapeva Musil, perso a suonare un brano “la cui partitura non è stata ancora scoperta”, Joyce lo sapeva, mentre progettava di infilare in una lingua tutte le lingue, Stein, chiarissima, “I am altogether a discouraged one”, Lowry, Bachmann, certo, lo sapevano, e lo sapeva ovviamente Kafka: sebbene sia impossibile mettere la parola fine in uno dei suoi capolavori, ha conquistato alla letteratura non un territorio, ma un intero mondo con un sapore di primi uomini, di notti infinite prima del tic tac del tempo, un mondo – ha scritto Calasso – “precedente a ogni separazione o distinzione”.
Ma limitiamoci al caso di Fowles, che, appunto, è paradigmatico.
Di cosa parla Il Mago?
Di cosa parla allora Il Mago? Riassumerne la storia è un bel problema. C’è un video in cui Billy Williams, direttore della fotografia, quarant’anni di successi a Hollywood, in margine al tentativo di trasporlo su pellicola, si chiede se qualcuno ne abbia mai capito la trama.
Risposta: no, “it’s a film in which nothing was really what it seemed to be”, donde, ne deduce, l’insuccesso al botteghino. Qui basti dire che assistiamo alle vicende di Nicholas Urfe, un tipo che oggi diremmo performativo (uno iscritto al club L’homme révolté; ai tempi l’aggettivo spendibile era forse inautentico), maschio certamente tossico (chiedere ad Alison), un ventiseienne cinico, manipolatorio, che dopo il lutto dei genitori fugge da un’Inghilterra assurda, da una relazione complicata, da ogni responsabilità, accettando un posto da insegnante sull’isola greca di Phraxos che sta per qualcosa come un “esilio dalla realtà contemporanea”.
Ora, nel blu dell’Egeo, dopo aver scartato l’opzione suicidio – che sarebbe stato un “atto estetico”– incontra Maurice Conchis e il manipolatore diventa manipolato. Conchis, aiutato da una coppia di gemelle-attrici, gioca con la mente di Nicholas (e del lettore): crea un flusso ininterrotto di finzioni in una calcolata raffica di colpi di scena e letteralmente gioca a fare Dio.
Ordisce il godgame: fa della vita di Nicholas una specie di happening di teatro totale attraverso una serie di prove morali, finte biografie, rituali, apparizioni, trabocchetti erotici, maschere – a un certo punto c’è un rapimento-processo-mitico-simbolico – e lo attira in “acque più profonde” di quelle in cui dovrebbe addentrarsi.
Il godgame è un percorso di ascesa o discesa che spinge Nicholas a dubitare di se stesso, del tessuto della realtà (la parola “realtà” appare 155 volte nel Mago; si può dire con qualche certezza: il tema del libro) e di tutte le sue sovrastrutture; lo obbliga a domandarsi cosa faccia la “foschia” delle parole alle cose, quale sia il ruolo della “sadica cospirazione contro l’individuo”, la Storia, a chiedersi se verità e realtà potrebbero essere poli divergenti e quale significato abbia l’esistenza di individui che vivono come se una terza persona li osservasse in mondi congiurati da un dio-romanziere dentro un universo incomprensibile.
Ma il punto era altrove – diceva Fowles – “sotto la superficie della storia”, nel diario di un’esplorazione in una terra sconosciuta. Il che è vero almeno in due sensi: il primo sta dentro all’opera di Fowles, il secondo, collegato, ha a che fare con lo spazio che occupa in un panorama più ampio.
Il Mago è, in un certo senso, lo scrittore John Fowles
Il Mago è inscindibile dalla ricerca letteraria di Fowles, dalla sua poetica e anche da una sua certa inclinazione esistenziale a vivere la vocazione di scrittore come esilio. Il Mago è, in un certo senso, lo scrittore John Fowles. Qui mette a punto il congegno narrativo che appare come matrice in tutti gli altri suoi libri: la vicenda di un giovane uomo inserito in uno spazio magico, dove viene manipolato da un uomo più anziano e da un’eroina idealizzata, in una bildung trasfigurata che, mettendo in crisi la struttura della sua realtà, dovrebbe fargli acquisire (o meno) una nuova maturità. “Ci sono degli artisti”, scrive Musil, “che vengono afferrati da un tema. Essi sentono o questo o nessuno: è come l’amore al primo sguardo”.
Ecco cosa potremmo scrivere sulla targa della nostra quieta biblioteca, ecco anche il motivo per cui Fowles non può fare a meno di tornare al suo “storpio”. Lo scrittore John Fowles non sembra poter esistere senza questa matrice, senza la tecnica che continua a collaudare contro l’incapacità di descrivere ciò che voleva, la sua ricerca – il perché scrivi – non sa non attraversare questo dispositivo narrativo.
In un secondo senso, la morfologia di questo congegno, la terra sconosciuta su cui pianta la bandiera il signor Fowles, costituisce quel tanto di peculiare del Mago. Perché Fowles non sa fare a meno di questo giovane, di questo itinerario, di questo domaine dove la realtà e l’illusione procedono con passo spiraliforme?
Una delle prime cose in cui si imbatte chi vuole capirci qualcosa di Fowles è che viene considerato uno scrittore postmoderno, il padre del postmodernismo britannico annuncia la prima riga della pagina Wikipedia italiana.
L’etichetta postmodernismo da sempre è un minestrone in cui entra di tutto
L’etichetta postmodernismo da sempre è un minestrone in cui entra di tutto. La parola “postmodernismo” appare prima del cosiddetto “modernismo” è sempre pronto a dire il professore col ditino alzato, eccetera, eccetera.
Una delle poche distinzioni accettate l’aveva proposta Brian McHale nel 1987: secondo lui, i testi a “dominante” modernista sono guidati da questioni epistemologiche (“cosa posso conoscere?”): presuppongono l’esistenza di una singola realtà a cui si accede solo parzialmente attraverso mediazioni come le parole, la coscienza, la percezione; strumenti fatalmente approssimativi. Il flusso di coscienza, i tempi complessi, i montaggi, i narratori inaffidabili, i gialli filosofeggianti, tutta la varia casistica di epifanie, occasioni, squarci nei cieli di carta, sono tecniche che spiano dietro il velo che cela il centro inaccessibile dell’essere.
Nei testi a dominante postmoderna, invece, ci sarebbe uno slittamento verso questioni ontologiche (“in che mondo sono?”): non più una singola realtà insondabile, ma quante sono le cose che chiamo realtà? In quale realtà mi trovo? Qual è la differenza tra finzione e realtà? I mondi possibili esistono nello stesso modo dei mondi veri?
La metafinzione, la rottura delle cornici narrative, l’autore che parla direttamente al lettore dicendogli Ehi, stai leggendo un libro: il libro, te lo ricordo, è una cosa finta, l’accostamento di codici incongrui, il gioco delle citazioni, sarebbero tecniche usate per creare quegli effetti di vertigine ontologica (la percezione che esistano più mondi, nel mondo) e sparigliare le carte di quel bizzarro monolite della realtà.
Che poi tutte queste realtà moltiplicate edifichino piani e sotterranei in ciò che era già un labirinto, che poi collassino l’una sull’altra, che poi queste realtà siano tutte, ognuna e nella somma dei loro prodotti, comunque inafferrabili, che non risolvano manco per niente le questioni moderniste, ma, anzi, le complichino ulteriormente, per ciascun mondo e ciascun livello fino a fare della parola realtà una specie di poltiglia, un buio solido e opaco o una città distrutta, è, come dire, un altro paio di maniche.
Fowles, quando comincia a scrivere Il Mago, all’inizio degli anni Cinquanta, a guardare i manuali, intorno a sé vede gli ultimi botti dell’alto-Modernismo e la temperie esistenzialista (che si domanda, per farla breve, come faccio a vivere in un mondo che, senza fondamenti, mi sembra assurdo?) e parte da qui.
Mentre la storia procede, cambiano completamente le domande che si fa il protagonista…
La cosa straordinaria de Il Mago è che il lettore viene tirato dentro il libro trovando cose familiari: un protagonista che sembra una macchietta di Camus si interroga sulla possibilità di conoscere: chi è Conchis? come faccio a conoscere davvero la sua storia? Qual è la verità sul mistero della Villa di Bourani? e poi, senza che ce ne si accorga, si viene risucchiati nel congegno di Fowles. È il senso della matrice del Mago: mentre la storia procede, cambiano completamente le domande che si fa il protagonista, da chi-sono-cosa-so-cosa-vivo-a-fare-in-questo-mondo-assurdo, il godgame, spinge a chiedersi con lui in che mondo sono? in quale livello di realtà sono? in che modo la finzione contamina la realtà?, rendendo letterale, rendendo addirittura testuale, il passaggio da una temperie culturale a un’altra, entrando in una terra prima sconosciuta.
Dicevamo che tra la famiglia dei testi tormentati in un gorgo di riscritture, la cui cifra è la conquista di nuovi territori, Il Mago ha un posto del tutto peculiare. Il Mago ha qualcosa di unico: che io sappia non esistono molti altri libri che comincino in un clima culturale e finiscano in un clima che, a posteriori, viene riconosciuto come il passaggio successivo, né che lo facciano nello spazio di una singola narrazione, né che lo facciano attraverso un congegno narrativo progettato per saldarli in un unico organismo, dove l’avvicendamento risponde alle necessità degli eventi, alla logica di cosa accade al suo protagonista, alle domande che è lecito si faccia in quella situazione, un organismo entro il quale le questioni di un clima culturale (o un paio) si trascinano, aggiornate, nell’altro.
Ovviamente, sono categorie imprecise, pensate a posteriori, semplificazioni: la mappa sacrifica ogni dettaglio del territorio.
Può interessarti anche
Una ricerca che vale i bei venticinque anni di riscritture…
Non esiste nessun individuo che, finito in questa gabbia, non ringhi per uscirne. Ma è facile, ragionando per categorie, accorgersi come la zona Fowles abbia delle caratteristiche tutte sue: laddove per buona parte il postmodernismo americano, almeno nella vulgata, ha un che di giocoso, disimpegnato, derealizzante, cinico-ironico, corteggia la farsa e il grottesco perché non può fare a meno di ridere di ogni illusione modellizzante, qui ha sì senso invocare il parapiglia del postmodernismo, ma, per virtù di trascinamento, mai del tutto sganciato dall’ansia del conoscere, e anche di qualcosa come un post-esistenzialismo, un esistenzialismo aggiornato di fronte alla moltiplicazione dei mondi. Di fronte a una realtà imprendibile, in una realtà i cui livelli proliferano fino alla dispersione, in Fowles continuano a premere le questioni di un per noi. Nicholas non fa altro che chiedersi cosa può sapere, come vivere, come farlo eticamente, perché, come agire in modo responsabile proprio perché non sa districare il nodo scorsoio che lo appende di fronte a se stesso e al mondo. Non scioglie tutte le domande, non scioglie nessuna domanda – Il Mago si chiude aperto –, ma è una ricerca che vale i bei venticinque anni di riscritture; è quel tema che lo afferra ed è questo o nessuno, quel rancore che lo riporta sempre in basso, sempre al punto da cui è partito.
Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.itScopri la nostra pagina Linkedin

![]() Seguici su LinkedIn
Seguici su LinkedIn
La riscoperta di Alasdair Gray
Resta da capire perché Safarà abbia deciso di ripescare questo gigante “storpio” proprio adesso, il che forse sarebbe un altro discorso. Basterebbe scorgere le famose classifiche dei cento libri del secolo scorso, in cui Il Mago inevitabilmente compare, accorgersi che era introvabile da almeno un ventennio, per dire Perché mancava, chiuderla qui e grazie mille. Ma viene in mente il caso di Alasdair Gray. Safarà ha già ampiamente dimostrato di essere un editore tanto lontano dalle mode, quanto particolarmente attento ai nuovi territori, tirando fuori dal cappello Lanark e Povere creature proprio nel momento in cui l’universo di Gray, libri dell’81 e del ’92, è stato letto come il nuovo territorio cercato da molti, con la sua commistione impossibile di piani, immaginari, allucinazioni, visioni entro una città che collassa. Qui, tocca almeno chiedersi, vale lo stesso? Forse sì, forse no.
Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
A una ragazza di diciassette anni che gli chiedeva quale fosse il significato del Mago, Fowles rispondeva così in una lettera: “Il Mago cerca di suggerire a Nicholas che la realtà, l’esistenza umana, è infinitamente sconcertante. Uno ottiene una spiegazione – quella cristiana, quella psicologica, quella scientifica… ma questa svanisce come la nebbia estiva e appare una nuova spiegazione.
Suggerisce che l’unica realtà o principio valido per noi risiede nell’eleutheria, la libertà. Accettare che l’uomo abbia la possibilità di una libertà limitata e che, se così è, debba essere responsabile delle proprie azioni. Essere liberi (il che significa rifiutare tutti gli dei, i credi politici e tutto il resto) non lascia altra scelta che agire secondo la ragione: cioè, umanamente verso tutti gli esseri umani.”
Può interessarti anche
Quando la complessità non sembra poter star più dentro nessun contenitore…
Ora, è un’ipotesi, e vale quel che vale. Ma quando la complessità non sembra poter star più dentro nessun contenitore; quando l’unica idea circolante di realtà ha la forma di un crollo o di una caduta; quando, dunque, nessuna spiegazione sta dentro le cose e quindi tutte le spiegazioni competono senza il fantasma di una gerarchia; quando il ciclo di finzioni e realtà accelera nel delirio o nel deliquio, ma sa essere anche strumento di potere e governo per chi ha i mezzi per dargli un indirizzo, lasciandoci sgomenti a osservare la nostra insignificanza nell’entropia che tira i fili; quando la farsa è la faccia con cui si annuncia la tragedia, che per questo non è né meno farsa né meno tragedia, ma il grottesco entro cui si danno di gomito; quando, cioè, mentre il sangue scorre come non si vedeva da decenni, ci ritroviamo a scrutare il cielo cercando droni, mentre sciamani futuristi costruiscono bunker o investono speranze e capitali puntando tutte le fiches della partita in un sistema di calcolo bruto che genera, computando probabilità, nientemeno che il linguaggio, e dal linguaggio strizzi fuori il pensiero, poiché da questo, e solo da questo, si trovi la soluzione, ogni soluzione: si riordini la linea del tempo e si riattivino le meravigliose sorti progressiste, si colonizzi Marte o risolva l’annosa questione del senso, è uguale: un dio tutto può, e intanto osserviamo divertiti bambini distrarsi scambiandosi figurine di personaggetti assurdi e simpatici, che bestemmiano o bombardano, generati a mezzo sempre di quell’entità che qualcuno teme seriamente possa sostituire o distruggere la specie, la specie che vediamo morire contenuto dopo un contenuto, la morte, live, essendo nella sintassi dell’attenzione merce uguale alle altre merci; quando, ci dilunghiamo, l’immaginario delle relazioni internazionali allinea senza distinguerlo il piano di missili e pop-quiz; quando macchine di amorevole grazia vengono filmate mentre piegano i panni o mentre marciano in parata militare, mentre chi le guida si lascia riprendere a pontificare di immortalità, come a dire che il futuro è uno spazio militarmente occupabile: scegli, cosa che si potrebbe desumere ugualmente dal peso inaspettato nello spazio del dicibile di ideologi neomonarchici, da editoriali progressisti che si chiedono cosa c’è dopo la democrazia o dalla bandiera dei cartoni animati che sventola affermando la corruzione di qualsiasi istituzione, la di loro miopia di fronte all’orologio che segna il punto di non ritorno per il pianeta; quando chiunque concorda solo sull’idea della fine di un’epoca, di una civiltà, o comunque presentisce una disfatta generale, infinita, inappellabile, ma non sa non partecipare, nel suo piccolo, a uno scannamento su tutto il resto; quando, insomma, il sugo della storia si addensa, in virtù di malia o per doti di profezia, in una trama interamente, assurdamente, letteralmente pynchonesca, nei suoi elementi discreti mistico-tecnologici, apocalittico-grotteschi, paranoico-sistemici, postmoderna nel midollo, qualsiasi cosa significhi, abbia significato, nel dubbio che abbia mai significato qualcosa, e qualsiasi tentativo di cambiarne l’inerzia, cambiare la mappa di un gioco sfuggito al controller, si misura con la sensazione che tutto sia impossibile e tutto sia per sempre, in un sistema, primo mobile, buco nero o boss finale, di simulazioni che simulano se stesse o distruggono, terzo non dato; quando, anche prescindendo dai destini generali, ogni esistenza accade all’ombra dell’enormità della scala del proprio non capire, del proprio non poter agire, del piano inclinato di un lunghissimo scivolare, prigioniera di uno stato mentale inceppato, ecco, è allora che vale la pena considerare un’altra via, postmoderno e va bene, stiamo lì, ma alternativo, come a tirare un freno che devii la traiettoria su un binario parallelo, che riconquisti quantomeno certi fondamentali, come il fatto che “per noi”, scriveva Fowles, per non sbagliare, e può suonare un po’ retorico, ma è pur sempre meglio dell’alternativa, non c’è nessun’altra scelta, che agire secondo ragione, cioè umanamente verso tutti gli esseri umani.
Questa, la terra sconosciuta del bambino storpio infinitamente torturato di John Fowles, questo, mi pare, il suo momento.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it