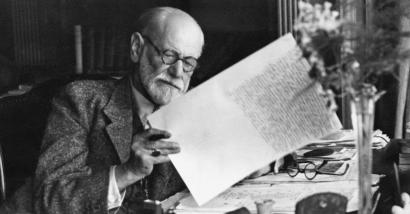“Quando leggo, vengo attratta fatalmente dalle narrazioni che contengono in sé qualcosa di ingannevole, di inesatto, di doppio. L’ho sperimentato l’ultima volta con “Tre piani” di Eshkol Nevo, il libro dal quale Nanni Moretti ha tratto il suo ultimo film presentato al Festival di Cannes. Ma dal Novecento a oggi, la letteratura è piena di voci inaffidabili, ambigue, piene di ombre e tranelli…” – Su ilLibraio.it, un approfondimento che va da “La Coscienza di Zeno” di Svevo al “Il lamento di Portnoy” di Roth, passando per l’autofiction di Carrère, Cusk e Ciabatti
Sarà pure un’affermazione ambigua, ma su di me il mito della verità non ha mai fatto presa. Non per questo spero che le persone che ho attorno mi ricoprano di menzogne e falsità, semplicemente penso che dietro a certe bugie bianche ci siano delle motivazioni, se non innocue, comunque accettabili.
In altre parole: in alcuni casi le legittimo, le comprendo. Le trovo giuste e rispettose, come se in quell’alterazione e manipolazione del reale – “le cose come stanno” – ci fosse molta più umanità e trasparenza di quanto ci sarebbe in una trasposizione fedele dei fatti.

E forse è per questo che, anche quando leggo, vengo attratta fatalmente dalle narrazioni che contengono in sé qualcosa di ingannevole, di inesatto, di doppio. L’ho sperimentato l’ultima volta leggendo – anzi, ascoltando in audiolibro – Tre piani di Eshkol Nevo, il libro dal quale Nanni Moretti ha tratto il suo ultimo film, presentato al Festival di Cannes e in questi giorni nelle sale.
L’ho ascoltato quasi tutto d’un fiato, dicevo, e mentre la trama scorreva, avvertivo uno strano senso di disorientamento, come se non mi fidassi mai del tutto di chi stava raccontando la storia. Per capirci meglio, le voci narranti sono tre: hanno ciascuna una vita diversa, una famiglia diversa, e attraversano ciascuna un conflitto molto diverso. Eppure, mi sembrava avessero qualcosa in comune, qualcosa che andava oltre al fatto di condividere lo stesso palazzo: dalle loro parole emergeva la stessa insincerità.
A turno, infatti, i tre personaggi decidono di confessarsi (e cosa dovrebbe essere la confessione, se non il momento più alto di sincerità?) e, rivolgendosi a un “tu” non ben definito, raccontano la propria versione della storia: c’è chi si giustifica, chi riavvolge il nastro, chi finalmente riesce a liberarsi di tutte le parole non dette. Ma ognuno di loro, mentre si rivela, tradisce dei segni di inattendibilità: non ricorda bene cosa sia accaduto, si confonde, esagera, si contraddice.
La rielaborazione personale diventa più importante di quello che è accaduto veramente, perché fa trasparire molto di più di quello che sarebbe necessario sapere.
Non è importante scoprire se il vecchio vicino ha abusato davvero della bambina di Arnon; non conta più niente se Hani e Evatar sono davvero stati insieme; è irrilevante capire cosa farà Dovra dopo aver ritrovato suo figlio: quello che conta è come queste tre figure percepiscono il proprio vissuto e, soprattutto, come ce lo restituiscono (diversamente accade nel film, dove invece il regista ha deciso di dare risposte chiarissime, di chiudere i cerchi e di consegnare al pubblico una versione della storia decisamente più rassicurante).
“Un misto di verità e bugie“.
Mi sono tornate in mente le parole che pronunciai diversi anni fa all’Università, mentre sostenevo un esame di letteratura del Novecento. Corso monografico su La coscienza di Zeno, un libro che avevo letto svogliatamente durante il liceo e che avevo dovuto riprendere tra le mani sempre a causa degli studi. La seconda volta fu quella buona, e credo che a determinare un maggior coinvolgimento – oltre a una maggiore maturità – abbia contribuito la guida che la docente del corso, Giovanna Rosa, ci fornì per affrontare la lettura del romanzo.
In particolare, l’accento che pose sulla voce del narratore, che lei stessa definì “inaffidabile“, spiegandoci che niente di quello che avremmo trovato nel racconto sarebbe stato da intendere come vero.
Non lo diceva proprio lei in realtà, ma Svevo stesso nella prefazione che fa firmare a un certo Dottor S. (Dottor Svevo? Dottor Sigmund?), dove infila un’informazione apparentemente superficiale, ma necessaria per comprendere l’intera natura del testo.
“Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!”.
Non tutti – o almeno, non io al liceo – sono abituati a leggere prefazioni o note introduttive, ma in questo specifico caso la prefazione ha un ruolo fondamentale, perché determina il nostro atteggiamento nei confronti di chi ci sta raccontando la storia. In questa prefazione siamo avvertiti: Zeno Cosini, il personaggio considerato l’inetto per eccellenza, l’uomo senza qualità della nostra letteratura, è, prima di ogni altra cosa, un bugiardo.
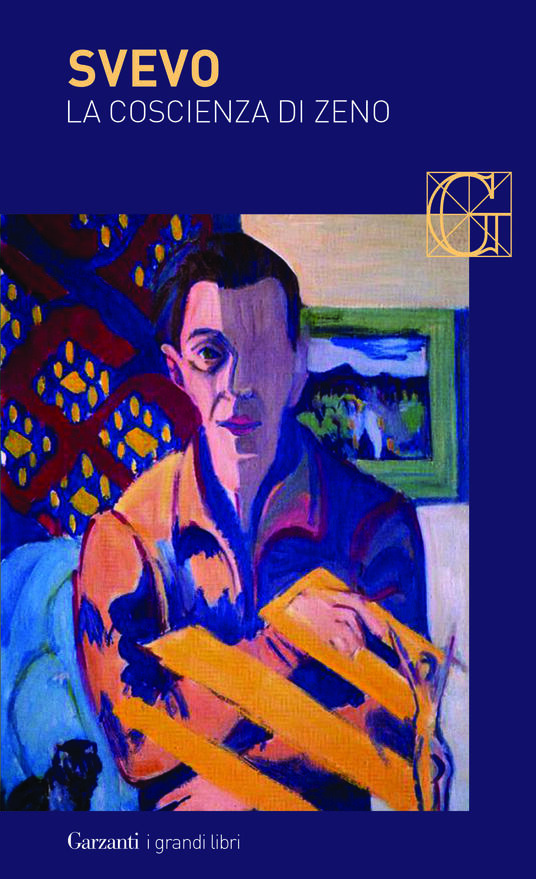
Non lo fa per cattiveria o con secondi fini. Lui stesso si autoinganna e rimane vittima delle sue bugie. Del resto, quello che sta facendo è cercare di ricordare, di raccontarci il suo passato – il rapporto con il padre, quello con le donne, le insicurezze, la dipendenza dal fumo -, ma per quanto si sforzi, non riesce a vedere bene, a mettere a fuoco quello che è successo.
“Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora.
Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. […] Ecco che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il passato“.
Non si può quindi biasimare Zeno se la sua è una narrazione contraddittoria e ombelicale, perché di fatto è la pretesa stessa di raccontare qualcosa di vero a rappresentare una contraddizione in termini. Questo di sicuro lo avevano ben chiaro gli scrittori del Novecento, durante il quale si può dire che abbia avuto inizio una vera e propria stagione letteraria animata da voci ambigue, piene di ombre e di tranelli.
È in fondo il periodo in cui si diffondono le teorie del relativismo (“Maledetto sia Copernico!”, scrive Pirandello ne Il fu Mattia Pascal) e dell’inconscio (per l’appunto, la teoria dei “tre piani” della personalità): nel 1899 viene pubblicata L’interpretazione dei sogni di Freud; nel 1905 è resa nota la prima teoria della relatività ristretta di Albert Einstein; nel 1925 il principio d’indeterminazione di Heisenberg; nel 1902 prendono piede le teorie sociologiche e antropologiche di Durkheim; tra il 1906 e il 1911 partono i corsi di linguistica generale a Ginevra di De Saussure. Insomma, è il momento in cui storicamente crollano tutte le certezze, le convenzioni e i codici dell’Ottocento.
Può interessarti anche
Così si definisce questa voce narrante inaffidabile, sprezzante e dissacrante, una voce anche dolorosa, perché riflette e si sofferma sul caos della vita, e al tempo stesso umoristica (e non ironica), perché svela la drammaticità e l’ambiguità dell’esistenza.
Di queste voci che raccontano per grumi, che riportano a galla la propria esperienza secondo una parabola per niente lineare, è piena la letteratura, anche quella dei giorni nostri.
Se penso al Lamento di Portnoy di Philip Roth (1969) o a Il senso di una fine di Julian Barnes, mi sembra di riconoscere quella stessa incertezza e titubanza che ho provato di fronte alle opere di Nevo e Svevo. E forse perfino nell’odierna autofiction – genere ancora in fase di codificazione, su cui è sempre difficile esprimersi – si possono scorgere tracce di un narratore in cui la memoria è instabile, e si traduce in una sorta di frammentario flusso di coscienza: Emmanuel Carrère in Vite che non sono la mia e nell’ultimo Yoga, Rachel Cusk in Resconto e Transiti, o ancora Teresa Ciabatti in La più amata e Sembrava bellezza.
Ogni volta che ho concluso la lettura di queste storie, mi sono sempre ritrovata a dover fare i conti con dubbi e interrogativi. Sentivo di non avere in mano nessuna certezza, eppure ne rimanevo completamente sedotta, abbindolata: forse perché ascoltare le bugie è invitante, accogliente e, probabilmente, perfino più piacevole e interessante che conoscere la verità.

L’AUTRICE – Jolanda Di Virgilio lavora nella redazione de ilLibraio.it. È co-autrice, con Sara Canfailla, del romanzo d’esordio Non è questo che sognavo da bambina (Garzanti). Nel libro, in cui chat, mail e social entrano nella narrazione (del resto, la trama vede al centro la storia dello stage della protagonista, Ida, ed è ambientata in un’agenzia di comunicazione milanese), si racconta cosa significa diventare adulti oggi: le relazioni finite prima di cominciare, il senso di impotenza di fronte a un sistema lavorativo precario e ingiusto, la frustrazione di vivere in una città difficile, dove dicono che ci sia posto per tutti dimenticandosi di dire che, in quel posto, ci si sente molto soli.