“Ho conosciuto Emmanuel Carrère tre o forse quattro anni fa (…). In questi giorni sono tornata a quei pensieri, perché una persona che la vita vera di Carrère l’ha conosciuta bene, perché è stata una vita anche sua per diversi anni, cioè Hélène Devynck, la sua ex moglie, ha scritto una lettera in cui accusa pubblicamente l’ex marito di aver rotto, nel suo ultimo libro, ‘Yoga’ (che in Italia uscirà l’anno prossimo), un accordo legale in base al quale lui non avrebbe dovuto usare mai più, senza esplicito consenso, il suo ‘personaggio’, la persona di lei, in quello che scrive”. Su ilLibraio.it la riflessione della scrittrice Ilaria Gaspari sulla polemica del momento: “Il materiale letterario, uno scrittore ha il diritto sacrosanto di cercarlo nelle pieghe della sua esistenza, nei punti che fanno più male, o no? Io credo di sì. Anche se non è un gesto elegante, anche se farlo lo rende un essere umano spregevole agli occhi di molti. Eppure…”. Nel suo intervento non mancano le domande e dubbi
Ho conosciuto Emmanuel Carrère un giorno di tre o forse quattro anni fa, a un festival letterario a Berlino. Ero seduta su una panchetta del piccolo Biergarten, aspettavo la macchina che doveva portarmi all’aeroporto e nel frattempo cercavo di finire di scrivere un articolo; a pochi passi da me, attorniata da una nuvola di ragazze e ragazzi, c’era una vecchietta deliziosa, vestita di rosa chiaro e con un filo di perle gigantesche al collo: era nientemeno Judith Kerr, l’autrice di Quando Hitler rubò il coniglio rosa, e aveva un sorriso irresistibile, a bocca chiusa, come una bambina che ha voglia di ridere e non osa, e così fa sorridere te che la guardi.
Insomma, mentre mi distraevo a guardare il sorriso di Judith Kerr e pensavo a quanto fosse incredibile ritrovarmi a pochi metri da lei, un tizio, in un inglese molto francese, mi chiede se mi dà fastidio che si sieda un attimo lì, così si riposa un po’. Io per fare la splendida gli rispondo direttamente in francese, pensando così di vendicare le innumerevoli occasioni in cui i francesi mi si sono rivolti in inglese per farmi sentire straniera, e proprio allora, però, alzo lo sguardo e mi rendo conto che il tizio è nientemeno che Emmanuel Carrère. Il quale, come niente fosse, mi dice, Che bello che parli francese, piacere, io sono Emmanuel; al che io respingo la tentazione di dirgli Guarda, so bene chi sei, però passo dallo stupore di trovarmi a pochi metri da Judith Kerr a quello, analogo ma ingrandito in un rapporto inversamente proporzionale al ridursi della distanza, di essere a qualche centimetro da Emmanuel Carrère.
Può interessarti anche
Voi penserete magari che vi racconti questa storia in un afflato di esibizionismo mitomane: ma, per quanto non possa rispondere del mio inconscio, che spesso fa strani scherzi (del resto, non è forse quello di fare strani scherzi, il mestiere dell’inconscio?), non era questa la mia intenzione, anche perché un incontro casuale non è certo qualcosa di cui vantarsi – che merito può esserci, nel caso?
Quello che volevo dire è che in quel momento sono stata attraversata da uno di quei pensieri di un’ovvietà sconcertante, che però cambiano molto, come se cambiassero di segno, quando nascono da un’esperienza diretta e quando invece li concepiamo solo speculativamente. Il pensiero era questo: che in quel momento stavo seduta vicina a uno sconosciuto come tanti, eppure avevo letto, sulla vita di quello sconosciuto, più cose di quante avessi mai sognato di leggerne sulla vita segreta, non so, dei miei vicini di casa, dei miei professori di università, di una folla di altre persone anche molto importanti nella mia vita.
So – mi dicevo – come si chiamano i suoi cognati, so di certi strani giochi che fa con sua moglie; conosco, come migliaia di lettori, almeno qualcuna delle sue paure. So come pensa, o almeno: ho l’illusione di saperlo. E questi pensieri mi sembravano fascinosi e inquietanti, e nel frattempo il simpatico Carrère mi diceva che a ben pensarci si sarebbe proprio sdraiato sulla panchetta perché era stanco morto, e si sdraiava e schiacciava un sonnellino a pochi centimetri dal mio stupore. E ho pensato, allora, chissà come dev’essere strano far parte della vita reale, della vita ‘vera’, quella fatta di risvegli la mattina, di lampadine fulminate, di mal di piedi, di raffreddori, di bolli dell’assicurazione, di qualcuno che quella vita la distilla, la racconta, la trasforma in libri letti da milioni di persone.
In questi giorni sono tornata a quei pensieri, perché una persona che la vita vera di Carrère l’ha conosciuta bene, perché è stata una vita anche sua per diversi anni, cioè Hélène Devynck, la sua ex moglie, ha scritto una lettera all’edizione francese di Vanity Fair in cui accusa pubblicamente l’ex marito di aver rotto, nel suo ultimo libro, Yoga (che in Italia uscirà l’anno prossimo per Adelphi, ma in Francia è stato pubblicato a fine agosto), un accordo – un vero accordo legale – in base al quale lui non avrebbe dovuto usare mai più, senza esplicito consenso, il suo ‘personaggio’, la persona di lei, in quello che scrive. Non dopo il divorzio: prima, invece, prima andava bene, dice il passaggio della lettera che mi ha affascinata di più: “negli anni in cui abbiamo vissuto insieme, Emmanuel poteva utilizzare le mie parole, tuffarsi dentro i miei lutti, i miei dolori, la mia sessualità”, scrive Devynck: c’était amoureux, era un atto d’amore e quindi lei era sicura che la sua persona fosse rappresentata in un modo che piaceva a tutti e due.
Quindi: musa sì, ma solo con amore, dice; e come darle torto, sul piano legale, dato che il suo ex marito, firmando quell’accordo, è riuscito a finire dalla parte del torto. Ma, se quell’accordo non fosse stato firmato, fermo restando che lei avrebbe avuto tutti i motivi per arrabbiarsi con lui, mi chiedo: si sarebbe potuto dire che avesse ragione lei, in una controversia del genere? A mio parere, no. Senza quell’accordo, che legalmente dà ragione a lei, la questione sarebbe stata diversa; e in un certo senso, è proprio questo a far sembrare così buffo, così artificioso, così aggirabile il contratto che cerca di imbrigliare un problema troppo selvatico per lasciarsi addomesticare da qualche clausola legale.
Può interessarti anche
È un bel gesto, un gesto elegante, mettere in piazza le debolezze della persona che hai amato, con cui hai condiviso la vita? No che non lo è; come mi ha detto, mentre ne discutevamo, la persona con cui la vita la condivido io, se riesci a sfidare la morale comune, il pudore e tutto quanto, potresti magari fare uno sforzo in più e sfidare anche l’anagrafe, rendendo quantomeno irriconoscibile l’identità delle persone che trasformi in personaggi.
Certo, ho ribattuto; ma il fatto è che l’epoca in cui viviamo rende particolarmente facile soddisfare tutte le curiosità possibili sulla vita privata di chicchessia, dal nostro vicino di casa, a – figuriamoci – un autore famoso; ci bastano cinque minuti su un social per sentirci detective dilettanti capaci di ricostruire tutte le vicende sentimentali del nostro compagno di asilo. Quindi, se sei uno scrittore famoso, per quanto tu possa mascherare l’identità di tua moglie, riconoscerla sarà un gioco da ragazzi – se non altro per quelli a cui interessa questo: riconoscere i personaggi, tracciare pettegolezzi, leggendo un’opera letteraria; interesse discutibile, forse, ma chi sono io per dire che non è legittimo? E poi, se essere esposta le stava bene quando era amata (e come non capirla?) Hélène Devynck dovrebbe forse accettare di esserlo anche nel disamore; sicuramente è un’esperienza più amara, ma altrettanto reale, o no? Essere una musa non è questione di vanità. Non è nemmeno una forma di committenza – ora tu fai un ritratto al nostro amore, ora taci.
Il materiale letterario, uno scrittore ha il diritto sacrosanto di cercarlo nelle pieghe della sua esistenza, nei punti che fanno più male, o no? Io credo di sì. Anche se non è un gesto elegante, anche se farlo lo rende un essere umano spregevole agli occhi di molti. Anzi, proprio perché questo lo rende un essere umano spregevole, mi spingo a pensare.
E poi, cos’è quest’ossessione del riconoscimento? A parte il fatto che non c’è scritto autobiografico che, malgrado l’intenzione di raccontare la verità, non si scontri con il fatto che proprio nella scrittura si crea un’altra verità che risponde a regole sue: che, per il fatto stesso di essere un autoritratto, un libro in cui autore, protagonista e narratore sono la stessa persona, è già un’alterazione, un’interpretazione, una deformazione – come dice Devynck nella sua lettera, quando insiste sul fatto che Carrère racconta un po’ quel che gli fa comodo – del modello.
Ma un libro non è un’istruttoria, né un verbale: è un libro, e chi lo legge non lo legge per stabilire come siano andate le cose, ma per seguire una voce che racconta una storia, e se quella voce ha bisogno di interpretazioni idiosincratiche, anche fallaci, di certi fatti, che fare?
È un paradosso della scrittura autobiografica, che per cercare la verità la deve costruire e quindi la altera, la inventa, la distrugge. E, al di là di questo, se il problema fosse la possibilità del riconoscimento dei personaggi che circondano l’io dell’autore, allora non dovremmo sognarci di leggere gli epistolari, le biografie. Ed ecco che mi chiedo: perché, in effetti, leggiamo epistolari, biografie? Un po’ per curiosità, certo che siamo curiosi. Vogliamo sapere chi ha amato chi, chi ha tradito chi, vogliamo conoscere i bisticci, i dissidi, chi erano queste persone. Ma è tutto qui, davvero? Non saprei, non credo.
A volte si usa un’espressione brutta, per dire questo tipo di curiosità: si dice “spiare dal buco della serratura”. Mi domando oggi, per la prima volta: perché non mi piace questa espressione? Presuppone una porta chiusa a chiave, in cui la chiave manca. Forse stiamo cercando la chiave, e invece di impegnarci a trovarla, ci fermiamo a guardare il punto da cui è stata tolta. Forse lo sguardo allora sostituisce la ricerca della chiave, il bisogno stesso di avere quella benedetta chiave, di aprire quella porta, di essere anche noi nella stanza di cui abbiamo intravisto un pezzettino, il pezzettino che si vede solo per via della fortuita mancanza della chiave. Cosa rappresentano la porta, la chiave, non lo so. Forse solo, semplicemente, il desiderio inesaudibile di esplorare l’umano, e il surrogato di quel compimento, che è poi il nostro sguardo: non una cosa di cui vergognarci, un modo, fra i tanti che ci inventiamo, di esperire il mondo.
La porta chiusa è un segreto, la serratura, la possibilità di violarlo; e mi sorprendo a pensare che questo tempo, in cui tenere i segreti sembra forse più difficile di quanto sia mai stato nella storia, coincide anche con un’ondata di diffidenza collettiva per il turbamento: cerchiamo trasparenza, cerchiamo di tener lontano il perturbante. Ci infastidisce, ci offende, essere turbati!
Chiediamo agli artisti il loro parere su questo e quello – è così facile, in questi tempi, sapere come il Tal dei Tali la pensa su qualsiasi questione – però non lo chiediamo per saperlo, ma perché vogliamo che il loro parere ‘ci rappresenti’: e se non risponde come ci aspetteremmo, scoppia un dibattito sui social, e i miti cadono uno dietro l’altro. Ma forse questo atteggiamento dice più di noi – del modo in cui giudichiamo l’arte – che degli artisti che sottoponiamo al nostro vaglio critico. Ci dice che siamo miopi, che guardiamo dal buco della serratura e ci scordiamo di cercare la chiave. Che vogliamo violare i segreti senza prenderci la responsabilità di farlo.
L’arte che vocazione può mai avere, se non quella di turbare – di costringerci a spingere lo sguardo dove noi non oseremmo, da soli, guardare? Perché dovrebbe rassicurarci a richiesta? L’unica maniera in cui, io penso, ci dovrebbe rassicurare, è attraversando il turbamento, allargando il senso che ha per noi la condizione umana; spingendoci a perdonare, a perdonarci, a sentirci partecipi di un destino tremendo e vertiginoso, quello di vivere con la coscienza di farlo.
Ma certo, poi però mi dico: e se succedesse a me, per pura ipotesi, di stare nella posizione di Hélène Devynck? Saprei accettarlo? Con quanto dolore affronterei questa cosa?
Eppure. Eppure si è innamorata del campione vivente dell’autofiction – un genere letterario nato con esplicite aspirazioni psicoanalitiche, con l’ambizione di esplorare l’inconscio: e l’inconscio, di accordi legali, direi, non sa proprio che farsene, sbaglio? – di uno scrittore la cui opera verrà ricordata proprio per questo tentativo spudorato, svergognato, non addomesticabile, di esplorare degli angoli di vita in cui, anche recalcitranti, anche disgustati, infastiditi, irritati, siamo costretti a riconoscerci.
E un’altra cosa mi viene in mente a questo punto: non fosse per la letteratura, sarei in grado di mettermi nei panni di questa donna sconosciuta, lontanissima da me? Non mi fossi esercitata a farlo leggendo tonnellate di romanzi, leggendo autofiction, pura fiction (è una distinzione formale, ha davvero senso insisterci tanto?), autobiografie, epistolari? La risposta è che come sempre non lo so, ma propendo per il no. No: questa possibilità mi viene proprio dalla familiarità che ho con la letteratura. Con la lettura di libri non rassicuranti, di libri che mi hanno turbata, cambiata; che mi hanno costretta a pensare.
Come vedete, su questa storia, su cui molti hanno opinioni precise e tranchant – e come sempre penso, beati loro – al solito, vedo solo domande, a cui do risposte contraddittorie e parziali. Mi viene in mente però una frase che ha scritto una mia alunna di un corso di autobiografia, qualche giorno fa, a chiudere un breve racconto in cui svelava, di sé, un tratto che la imbarazzava. Diceva pressappoco così: vi ho raccontato questa cosa, anche se mi è costato, perché sento la vostra benevolenza. Lo sguardo della benevolenza, uno sguardo che non costringa dentro rigide categorie morali un autore che si espone; lo sguardo di un lettore che ha ferite simili a quelle dell’artista, forse, se lo esercitassimo, potrebbe risparmiarci molti grattacapi. O forse no.
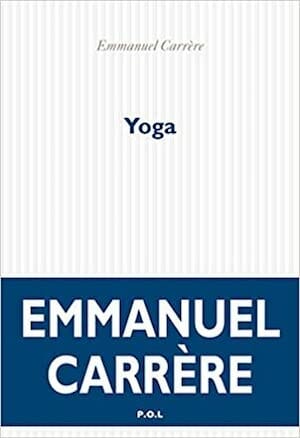
ALTRE RIFLESSIONI SULL’ARGOMENTO
La coppia è mia e la gestisco io. Carrère scopre che raccontare il suo matrimonio è appropriazione culturale – di Guia Soncini (da Linkiesta)
Il contesto ero io – Yoga, di Emmanuel Carrère, è un punto d’arrivo e un fallimento – di Vincenzo Latronico (da Il Tascabile)
Può interessarti anche
L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, collaboratrice de ilLibraio.it, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno) e Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi).
Fotografia header: Emmanuel CarrèreGettyImages 04-02-2020





