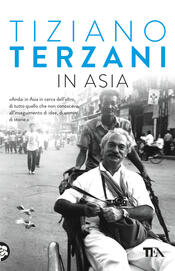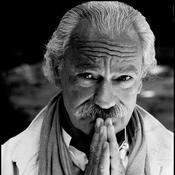A girovagare per il mondo aveva iniziato molto prima di fare il giornalista, facendo tanti diversi lavori. Per il Corriere della Sera ha rischiato la pelle ovunque vi fosse un campo minato, una pulizia etnica, una guerra santa, un traffico di droga, dall’Iran alla Cecenia, dal Medio Oriente al Pakistan all’Africa. Attraverso le sue parole e i suoi racconti, ripercorriamo l’incredibile vita (e carriera giornalistica, che iniziò tardi, 31enne) di Ettore Mo, lo storico inviato di guerra, scomparso a 91 anni. Mo detestava i furbetti e le scorciatoie, dosava gli aggettivi e schivava la retorica. Ora è facile trasformarlo in santino, dipingerlo come l’ultimo dei mohicani, alfiere di un giornalismo romantico che non esiste più, ma…
C’è un lusso, anzi due, che il giornalismo di oggi non può (o non vuole) più permettersi: andare sui posti e perdere tempo. Tanto tempo. Semplicemente perché serve. Per entrare nella cultura del posto, perché si vanno a raccontare storie di matti, poveracci e disperati, potenti astuti e delinquenti incalliti, perché le guerre, le calamità, le crisi sono un groviglio inestricabile di molte cose insieme: politica, passioni, perversioni, storia, geografia, religione, tradizioni, situazioni.
Ecco, Ettore Mo – lo storico inviato di guerra del Corriere della Sera scomparso lunedì a 91 anni – ha costruito la sua carriera su questi due lussi. “Sono da sempre un accanito sostenitore della testimonianza diretta“, ripeteva, “bisognerebbe vedere con i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie”.
Può interessarti anche
Come reporter di guerra è andato dappertutto. Per il Corriere ha rischiato la pelle ovunque vi fosse un campo minato, una pulizia etnica, una guerra santa, un traffico di droga, dall’Iran alla Cecenia, dal Medio Oriente al Pakistan all’Africa.
Non aveva barriere né pregiudizi. Come quando, ha ricordato Lorenzo Cremonesi sul Corriere, “andò a trovare i leader del neonato movimento di Hamas a Gaza quando vennero espulsi in Libano dal governo israeliano tra il 1992 e 1993. Rimase nelle loro tende nella terra di nessuno vicino al confine israeliano per 48 ore”.
Può interessarti anche
A girovagare per il mondo aveva iniziato molto prima di fare il giornalista. Da studente squattrinato di Lingue a Ca’ Foscari, dove si era iscritto dopo il Liceo Classico: “Avevo girato mezza Europa, Jersey, Parigi, Amburgo, Svezia, Inghilterra, mantenendomi come sguattero, barista e cameriere“, ha raccontato in un’intervista, “a Londra ho fatto l’infermiere in un ospedale per incurabili. E intanto scribacchiavo, leggevo il Corriere, Vittorio G. Rossi, i grandi viaggiatori, Hemingway e Conrad. Finché mi sono imbarcato su una nave da crociera della P&O Orient Lines. Southampton, Gibilterra, Napoli, Suez, Bombay, Australia, Fiji, Hong Kong, Yokohama, Honolulu, Vancouver, Panama, Jamaica, Le Havre, Londra. Quattro mesi e mezzo di mare. Nei porti scendi, ti ubriachi, ma a un certo momento arriva la sirena, Uuh-uuh, e se la perdi sei fottuto. No, direi una scuola di indipendenza. Si impara a non avere più paura di niente. Sbarcavo nelle Filippine, e mi sembrava di veder sbucare Lord Jim. Anni romantici, per me. E alla vigilia di uno di questi viaggi, a Londra, sono andato a trovare Piero Ottone, corrispondente del Corriere. Pensavo fosse un vecchiaccio, invece aveva pochi anni più di me. Gli lascio due raccontini, e il mio itinerario. Al porto di Yokohama mi arriva una lettera. ‘Caro Mo, ho letto le sue cose. Lei è persona atta a fare il giornalista‘. E mi invita ad andare a trovare, passando per Napoli, il suo amico Giovanni Ansaldo, direttore del Mattino. Scendo a Napoli, mi metto il vestito della festa e saluto i miei colleghi dicendo ‘Io vado a fare il giornalista’. Ma Ansaldo non c’è. Altro giro per il mondo. Al mio rientro a Le Havre, ebbi una lettera di Alfredo Pieroni, il nuovo corrispondente da Londra. Segnalato da Ottone, fui preso come numero tre, vice del vice. Cinque anni, una paga da fame, senza firmare mai. Ero il milite ignoto. I miei pezzi erano quasi sempre firmati ‘V.’. Una volta Gianni Brera, leggendo un mio articolo, chiese in milanese: ‘Ma chi l’è chel fiol lì che scrive inscì ben…?’“.
Per cinque anni racconta la Londra che s’avvia a diventare capitale del mondo: i Beatles e la minigonna, le rapine sul treno e gli scandali della Royal family.
Può interessarti anche
Al giornalismo era arrivato tardi per la media dell’epoca: 31 anni.
E ce ne passa di tempo perché diventi Ettore Mo.
Dopo gli anni londinesi, va a Roma dove deve coprire per il Corriere le ore notturne della Capitale e del Sud: “Copiavo dal Messaggero. Cinque anni di fogna. Pensai di lasciare, di tornare sulle navi. Alla fine divenni redattore. L’unica volta che in serata parlai col direttore, Giovanni Spadolini, fu quando il marchese Casati uccise la moglie, il suo amante e poi se stesso. ‘Professore’, avvertii, ‘il fatto verrà ripreso da tutti con grande evidenza’. ‘Ma saì, rispose, ‘queste cose non interessano’. Dovetti insistere. Lui minimizzava, non coglieva. Di Spadolini non ho un ricordo felice. Amava i giornalisti-professori. ‘Al giornalismo bisognerebbe accedere solo per ceto e per casato‘, disse una volta. Gli chiesi di poter rientrare a Milano: avrei potuto rendermi utile con la mia conoscenza dell’inglese, anche solo per le didascalie. Lui mi frenò. Per poi esclamare: ‘Ora anche Mo vuole fare il giornalista militante!’. Finii cronista agli spettacoli a Milano”.
Può interessarti anche
Passano quindici anni. Nel 1979, a 46 anni, si “accorge” di lui Franco Di Bella: “Fu il migliore dei miei direttori, e lo dico da uomo di sinistra”, ricordò una volta, “perché era un ex cronista, conosceva il mestiere a fondo. Io privilegio la cronaca all’opinionismo che dilaga oggi. Narrare con gli occhi è nel mio Dna. Non contavo niente, non sapevo neanche chi fosse Bruno Tassan Din. La vicenda P2 mi passò sopra la testa. La mia è stata la carriera giornalistica più lenta del dopoguerra“.
Con Di Bella comincia agli spettacoli, dove lo mandano soprattutto a fare interviste: “Una volta”, ha raccontato a Silvia Truzzi del Fatto, “arriva Richard Burton: vado al Grand Hotel et de Milan. Chiedo alla reception di chiamarlo, ma lui risponde, come aveva già fatto con tutti, ‘Niente interviste’. Me lo faccio passare: ‘So che lei è un grande amante di Dylan Thomas, come me’. E lui: ‘Please, come’. Salgo al terzo piano: alloggiava nella stanza dove era morto Verdi. Glielo dico. E lui: ‘Do you know the Quartet of Rigoletto?’. Ci mettiamo a cantare'”.
Poi Di Bella lo chiamò e gli disse: “L’inglese lo parli, no? Vai in Iran e raccontalo perché dal corrispondente che c’è adesso non capiamo nulla“.
“Sono andato a Istanbul, poi in treno a Erzurum, Anatolia, e 400 chilometri di taxi fino al confine iraniano”, ha raccontato, “avevo una paura matta, era zona di banditismo, tenevo i soldi nelle calze. Impiegai due settimane per arrivare a Tabriz. Il primo pezzo lo feci raccontando la marcia di avvicinamento. Descrissi un ragazzino della polizia segreta portato via in mezzo alla strada, tra bastonate, sputi, urla. E i suoi occhi, gli occhi di chi sta per essere ammazzato. Il giorno dopo da Milano arrivò una menzione laudativa… E nacque Ettore Mo ‘war reporter’“.
Può interessarti anche
Torna ed è destinato al Festival di Sanremo, ma nel corridoio di via Solferino trova Di Bella che lo investe sul campo cronista di guerra: “Prepara la valigia e parti per Kabul, assediata dai carri armati sovietici“.
A Kabul, però, bisognava arrivarci, a dorso di mulo, in sella a una sgangherata motocicletta o a piedi attraverso montagne coperte di neve.
Mo ci arriva per primo, attraversando la valle di Kunar, dove vede una piccola zattera che galleggia su vesciche di animale gonfie d’aria e uomini che armeggiano nella vorticosa corrente. Raggiunge il quartier generale dei ribelli, parla con i loro capi: Hekmatyar, che mette il Corano sulla canna della rivoltella, e Massoud, “il Leone del Panshir”, che diventerà suo amico fraterno e intervisterà più volte: “Pur essendo laureato in Ingegneria aveva una grande cultura umanistica e aveva sempre lo sguardo triste“.
Può interessarti anche
Si divertiva a raccontare l’incontro con Madre Teresa di Calcutta: “Un anno andai da lei senza dirle chi ero. Dovetti fare una lunga anticamera. Le sue collaboratrici dissero: ‘Ecco, ce n’è qui un altro, questa volta dall’Italia’. Intendevano giornalista. Così, su ordine della madre superiora, mi spedirono a lavare i pavimenti e le pentole per una settimana. Se resistevo, Madre Teresa si sarebbe concessa per l’intervista. Molti rinunciarono dopo pochi giorni, io non mi arresi. Le portai una scatola di cioccolatini. Con quei suoi occhi penetranti mi guardò le mani, e accettò di rispondere alle mie domande”.
Sposato con Christine, da cui ha avuto tre figli, la quale ha raccontato Elisabetta Rosaspina sul Corriere, “seppe soltanto dopo molti anni che Ettore si preparava a morire durante un combattimento, accovacciato dietro un terrapieno dalle parti di Jalalabad: ‘Mi confessò che quella volta si era messo a scrivermi un messaggio d’addio’. Che fortunatamente lei non ha mai letto: ‘Cosa mi avevi scritto?’, gli chiede. ‘E chi se lo ricorda?’, ride lui”.
“La pagina bianca per me è sempre stata un martirio“, ammise una volta vantandosi scherzosamente di non aver mai scritto un libro.
Alla fine i suoi libri saranno numerosi, pubblicati quasi tutti da Rizzoli: Sporche guerre. Dall’Afghanistan ai Balcani le avventure e gli incontri di un grande inviato (1999), Alla guerra in bicicletta, (2000), Gulag e altri inferni – Un grande viaggiatore tra le rovine della Storia (2001), Kabul (2001), I dimenticati – Un grande cronista nei mondi al margine della globalizzazione, con le fotografie di Luigi Baldelli, (2003), Treni. Nove viaggi ai confini del mondo e della storia (2004), Fiumi – Lungo le grandi strade d’acqua del pianeta (2006), Ma nemmeno malinconia – Storia di una vita randagia (2007), Lontani da qui – Storie di ordinario dolore dalla periferia del mondo (2009).
Ettore Mo non s’interessava agli scoop ma s’arrabbiava di brutto, come quando prese a male parole il taxista che lo doveva portare a Grozny, in Cecenia, nel 1995, e lo voleva lasciare alla frontiera.
Detestava i furbetti e le scorciatoie. Soprattutto, dosava gli aggettivi e schivava la retorica.
Ora è facile trasformarlo in santino, dipingerlo come l’ultimo dei mohicani, alfiere di un giornalismo romantico che non esiste più e non possiamo permetterci.
La sua lezione, parola che lui detesterebbe, è una sola: andare sui posti è l’anima antica e sempre nuova del giornalismo. In ogni tempo e sotto ogni cielo.
In una delle ultime interviste disse che nell’aldilà si sarebbe portato il racconto del “mio primo incontro con Massoud, nella Valle del Panshir”. A quest’ora, di sicuro, lo starà già intervistando.
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it