“Amore” è il titolo di un libro in cui questo stato d’animo è stato esplorato dettagliatamente da Emilio Pasquini e Guido Favati, nella sua articolata evoluzione e nelle più diverse declinazioni all’interno della produzione di Dante Alighieri – Su ilLibraio.it l’introduzione al volume, curata dalla scrittrice Ilaria Gaspari
“Amor ch’a nullo amato amar perdona”: chi di noi non conosce, ha sentito o declamato almeno una volta nella sua vita il famoso verso 103 del Canto V dell’Inferno della Divina Commedia, tra i più famosi dell’intera opera e della letteratura italiana in generale?
Diventate simbolo per eccellenza dell’amore, quelle parole pronunciate da Francesca da Rimini, alla quale il Canto è quasi interamente dedicato, contengono il senso e l’intrinseca contraddizione di un sentimento che procura gioia incontenibile e allo stesso tempo indicibile dolore, e che il sommo poeta Dante Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321) seppe descrivere in modo ineguagliabile.
Può interessarti anche
Termine-chiave dello Stilnovo e al centro del lessico dantesco, Amore è anche il titolo di un libro edito ora da Treccani in cui questo stato d’animo viene esplorato dettagliatamente, nella sua articolata evoluzione e nelle più diverse declinazioni all’interno della produzione del sommo poeta. Gli autori, i critici Emilio Pasquini e Guido Favati, hanno ripercorso infatti le sue apparizioni nella Vita nuova, per poi notare come l’amore vesta i panni della donna gentile-filosofa nel Convivio ed esploda in un crescendo espressionistico nelle Rime, fino a innestarsi nella Commedia in un contesto di magistrale respiro.
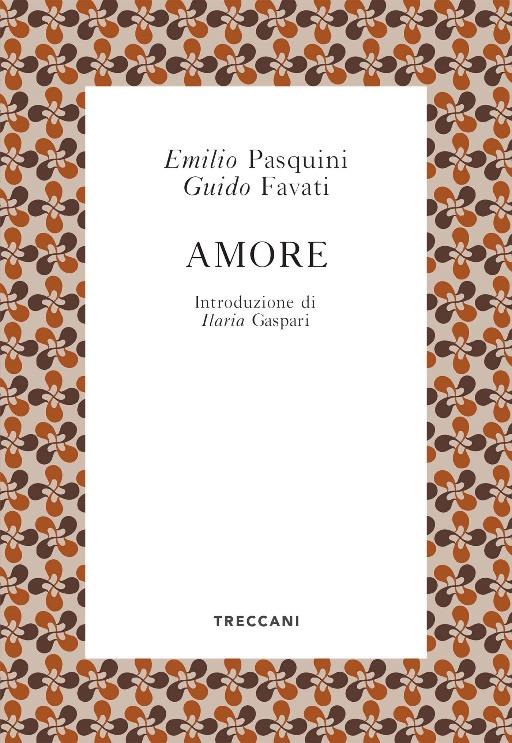
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo l’introduzione al volume, a cura della scrittrice Ilaria Gaspari, che all’universo sentimentale ha dedicato gran parte della sua produzione:
È bello tornare a parlare di Beatrice, nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri; parlare della donna che nel racconto della Commedia, mossa a pietà dall’ambasceria della Madonna che tramite Santa Lucia le rivela lo smarrimento di Dante sulla terra, non teme di scendere fin nell’inferno per assoldare Virgilio come guida del poeta sperduto, e così facendo consente a Dante di farsi pellegrino nel viaggio all’oltretomba. E parlare, anche, della donna che ispirò un’intera teoria amorosa in cui gli stilemi cortesi nati in Linguadoca si fondono in un’idea salvifica dell’amare; della donna angelica, la musa a cui è dedicata la più magnifica lode mai scritta. Beatrice che muore ben prima di Dante, che muore senza aver scambiato mai con lui altre parole che il saluto; e che, pure, sublimata in una rete di segni, presagi, rimandi, intesse la sua vita inaccessibile e simbolica a quella del poeta, alla sua impresa letteraria fra la Vita Nuova e la Commedia. Tornare a parlare di Beatrice oggi, esplorare il costituirsi di quella teoria dell’amore nata per intercessione di una donna il cui nome, sette secoli dopo, è noto a tutti, ma la cui reale personalità non conosceremo mai, è un modo per aprirci un nuovo accesso alla figura maestosa il cui profilo aquilino vediamo, quest’anno, stampigliato un po’ ovunque: pure su borsine di cotone, spillette e quaderni. Soprattutto se l’accesso avviene attraverso una porticina che solitamente il pubblico non accademico esita ad aprire, ma che ha l’utilità di disvelare, nella tela fittissima dei riferimenti e delle occorrenze, quello che una lettura meno attenta al dettaglio non vedrebbe: la porticina, insomma, di un’analisi filologica rigorosa, come quella dispiegata da Emilio Pasquini e Guido Favati in questa voce pubblicata per la prima volta nel 1970.
Cominciamo con la prosopopea, niente di meno. Non nel senso di una gravità eccessiva, tronfia, baldanzosa, soffocante; ma risalendo al senso originale della figura retorica, della personificazione che, come un orefice fonde il metallo di due gioielli per forgiarne uno solo, più prezioso, mescola due termini dal carattere opposto – astratto e concreto, assente e presente – in un’unica maschera, e la fa parlare. In questo caso, i due termini che danno luogo a una figura nuova sono da un lato l’amore come sostantivo comune, come sentimento; dall’altro, Amore come nome proprio di una divinità antica, pagana, in cui riverberano echi ovidiani.
Nel capitolo XXIV della Vita Nuova, Dante sente il suo cuore che gli parla con la voce di questo Amore con l’iniziale maiuscola; e mentre il cuore gli parla, due donne vengono verso di lui. Le riconosce a prima vista: sono monna Vanna e monna Bice, non creature di sogno, ma donne in carne e ossa, che il Dante personaggio conosce per averle incontrate nelle strade di Firenze. Ma Amore, parlandogli nel cuore, gliele presenta con parole sue.
Amor mi disse: “Quell’è Primavera,
e quell’ha nome Amor, sì mi somiglia”.
Può interessarti anche
E quell’ha nome Amor, sì mi somiglia, dice il cuore al poeta con la lingua d’Amore – un verso semplice, disarmante, pur nel gioco letterario degli omaggi, dei segnali e delle figure retoriche. Perché anche in questo lavoro raffinatissimo, la frase alla fin fine vuol dire qualcosa di così semplice, così vero; qualcosa che tutti facciamo quando chiamiamo “amore” qualcuno: ha nome Amor, sì mi somiglia, immaginiamo tutti, o meglio immagineremmo, che dicessero anche i nostri cuori, se, come fa Dante in questo passaggio, avessimo l’ardire di scrutare le ragioni dell’impulso a chiamare una persona amore.
La persona intorno alla quale la fusione fra l’amore come sostantivo generico e la sua personificazione parlante si addensa è una giovane signora fiorentina, di nome Beatrice, detta monna Bice. Una donna che fu un giorno in carne e ossa, e che si meritò di essere chiamata Amore da un poeta anche se fra loro due mai ci fu l’intimità che siamo soliti associare all’uso di nomignoli dolci; è lei, però, che riveste l’amore di un’aura tutta nuova, gli dà una forza fresca di
illuminazione.
È Beatrice, questa donna disarmante. Tanto simile all’amore stesso da meritare l’identificazione attraverso il passaggio del nome (come spiega, nella Vita Nuova, la prosa che segue i versi: «Ed anche mi parve che mi dicesse, dopo, queste parole: “E chi volesse sottilmente considerare, quella Beatrice chiamerebbe Amore, per molta simiglianza che ha meco”»).
La mirabile Beatrice scalza, con il suo apparire al poeta nella fantasticheria, la consistenza della bella Giovanna, detta Primavera con nome in codice – senhal, secondo l’uso della lirica provenzale – perché è una giovane donna in fiore, ma anche per calembour, come chiarisce Dante nella prosa: «Primavera, cioè prima verrà lo die che Beatrice si mosterrà dopo la imaginazione del suo fedele». Primavera è un gioco di parole. Giovanna è «una gentile donna, la quale era di famosa bieltade, e fue già molto donna di questo primo mio amico»: l’amico è Guido Cavalcanti, e per il giovane Dante è molto più che un amico: è un compagno di scorribande poetiche, insieme al quale inventa un nuovo stile, raccogliendo – e portando a uno sviluppo inimmaginato – l’eredità di Guido Guinizzelli che, precedendoli di una generazione, già aveva iniziato a intessere una lirica cortese in cui le parole dell’amore prendevano un senso nuovo, un senso etico quasi rivoluzionario.
Cavalcanti è per Dante l’amico della giovinezza, sodale e rivale tra sfide, tenzoni e scherzi: come il famosissimo sonetto Guido, i’ vorrei in cui Dante, riprendendo l’uso provenzale del plazer, elenco poetico di desideri, immagina di veleggiare insieme a Guido e a Lapo Gianni, altro poeta della loro cerchia, su una barchetta, un vasel che per incanto per mare andasse al voler vostro e mio, in cui realizzare una fantasticheria di dolce edonismo – direi quasi di edonismo epicureo, non fosse che poi Dante nell’Inferno gli epicurei li tratta da eretici, e non senza durezza –: una vita in cui la gioia di stare insieme si alimenti di continuo, nel ragionar sempre d’amore, mentre le tempeste si sfuggono, si sfugge la malasorte veleggiando sereni secondo il vento, e nel vento si va senza bisogno di resistergli. Questo quadretto, nella sua stessa grazia semplice e incantevole, porta il sigillo delicato delle immaginazioni ben riuscite, dei sogni a occhi aperti che per fortuna anche i poeti grandissimi si concedono, pur sapendo bene che ai fortunali e al tempo rio non si scampa mai davvero; e difatti, quando si pensa alla bella amicizia di Dante con Guido Cavalcanti, un’altra scena si accosta a questo piccolo schizzo idilliaco, il quale però, va detto, malgrado tutto quel che sarebbe poi successo ai due poeti, malgrado il destino di esuli, le liti, le strade divergenti, resiste indomito nella sua leggiadria deliziosa, nella sua aria di spontaneità pur nell’interpretazione ricercata di tòpoi letterari. L’altra scena è ben più cupa di questo acquerello edonista; è una scena infera, nel vero senso della parola. È l’incontro fra Dante pellegrino e Cavalcante Cavalcanti, padre di Guido, nel X canto dell’Inferno – guarda caso, lo stesso in cui Dante e Virgilio incontrano gli epicurei che «l’anima col corpo morta fanno» – fra le tombe scoperchiate a cui sono destinati gli eretici. In quello scenario sinistro da cimitero profanato, i due viandanti incontrano il fiero condottiero ghibellino Farinata degli Uberti, e subito dopo il suo vicino di tomba, Cavalcante, che in preda all’ansia nel vedere l’amico del figlio vagare per l’Inferno, senza Guido al suo fianco, freneticamente gli domanda notizie: dapprima ferito nell’orgoglio paterno («piangendo disse: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’è? E perché non è teco?”»), nel suo compiacimento per il genio del figlio. Poi, allarmato da un lapsus di Dante, che gli parla di Guido al passato, si spaventa all’idea che sia già morto, cosa che in effetti, nel momento in cui i versi verranno scritti, sarà già successa, ma non ancora nell’aprile del 1300, il mese in cui si situa il viaggio nell’oltretomba – e qui si spiega il lapsus, il suo carattere rivelatore, e l’ingegnosa strategia dantesca di rendere palpabile il presagio nefasto pur rispettando il tempo della narrazione.
Può interessarti anche
Malgrado l’atmosfera cupa, però, anche nell’incontro con Cavalcante, il padre dell’amico perduto, vibra una vicinanza, un affetto, che è precisamente quell’affetto che conosciamo tutti, se abbiamo avuto anche un solo amico d’infanzia dal quale siamo stati un tempo inseparabili, e se abbiamo conosciuto i genitori di questo amico, frequentato la sua casa, se abbiamo impresso nella memoria il profumo che arrivava dalla cucina, il disordine o l’ordine della mensola del bagno, di quella casa in cui non mettiamo piede da decenni; il legame quasi indefinibile che si crea con i genitori degli amici del tempo in cui ci stavamo trasformando nelle persone che saremmo state da adulti, magari anche molto distanti da quelle che eravamo al tempo dell’adolescenza, è lo stesso per noi che viviamo oggi, e per Dante nella Firenze del tardo Duecento, lo stesso per noi e per il pellegrino che incontra, dentro la maschera del dannato, il padre di un amico già perso; e anche se è stato il suo insindacabile giudizio di autore a confinare quel poveretto nell’inferno, la pietà resiste, più forte di ogni condanna, più tenace.
L’amico del soleggiato plazer, del resto, è lo stesso di cui ansiosamente si chiedono notizie in quel buio buco infernale. Così come la monna Vanna che compare in Guido, i’ vorrei… è la stessa Primavera che in un passo della Vita Nuova annuncia la venuta di Beatrice: Giovanna, amata da Cavalcanti che però, nella sua poesia, come sottolineano le voci di Pasquini e Favati, ne dissolve ogni presenza fisica in un accecante, etereo splendore. Esiste, e dal suo esistere irradia il suo incanto d’amore, sì: ma pare quasi non avere consistenza corporea, e quel che è più bizzarro è che non viene identificata per mezzo del suo nome se non dallo stesso Dante, come per l’appunto accade qui.
Monna Vanna non è insomma il suo devoto Cavalcanti, ma Dante, a chiamarla per nome, tanto in quella fantasticheria che parla con la voce di Amore, quanto nel plazer del vascello magico. E così, è proprio Beatrice la prima donna a comparire con il suo nome e un’identità precisa, capace di lasciare il segno, addirittura di proiettare un’ombra, nelle parole del poeta stesso che lei ispira.
Precorre, il corpo di Beatrice, l’impronta che le membra di Laura sapranno lasciare agli occhi di Petrarca innamorato addirittura nell’acqua – in chiare, fresche et dolci acque che misteriosamente conservano il suo segno. Ma è Beatrice la prima donna della letteratura italiana a comparire con il proprio nome, nel ruolo di ispiratrice di un poeta che spinge non solo a scrivere di lei, ma anche ad amarla, secondo un’idea dell’amore che oggi ci appare tanto nuova quanto doveva apparire allora, forse. L’idea che l’amore sia un segno di nobiltà d’animo, nel solco di un’immagine “feudale” del rapporto fra la donna e l’innamorato. È uno stilema, questo, che il Dante che compone plazer sulla vita con gli amici e ancora, probabilmente, non si immagina esule, cacciato da Firenze, né pellegrino nella città dei morti, a rassicurare il padre di Guido sulla sorte del figlio già perduto, Dante prima che tutto succeda, insomma, riprende da un tòpos della poesia cortese elaborato dall’ingegno del duca Guglielmo D’Aquitania. L’idea cioè che il rapporto amoroso possa essere prospettato in termini di vassallaggio, con la donna che diventa il signore feudale – midons – e l’uomo il vassallo, il fedele; una corrispondenza che introduce nella lirica amorosa una terminologia giuridica di ascendenza feudale che ancora resiste – pensiamo solo all’etimologia della parola donna, dal latino “domina”: signora, che si impone proprio allora – e ribalta, nel senso che la mette proprio sottosopra, la credenza antica per cui l’innamoramento, raccontato e cantato perlopiù, guarda caso, da uomini, sarebbe un abbassarsi al livello della donna: stigmatizzata da una lunga tradizione culturale e religiosa che ahinoi, a distanza di oltre sette secoli da questa piccola rivoluzione lirica, non è del tutto sradicata. Ma per Guglielmo, come per Dante, al contrario, l’innamoramento è un moto che tende verso l’alto.
Nella Vita Nuova, la canzone Donne ch’avete intelletto d’amore indica, come ascoltatrici prescelte delle lodi di Beatrice, la donna del poeta, altre donne che abbiano compreso la natura dell’amore. E l’idea che la donna d’amore sia maestra, che sia lei a indicare la strada all’innamorato – il quale, oltre che vassallo, è anche un apprendista –, l’idea cortese di Guglielmo D’Aquitania, insomma, resiste anche nella Commedia, anzi: è lì che trionfa, probabilmente. Nella Beatrice già morta e ritrovata alle soglie del Paradiso, nella Beatrice che dà l’abbrivio all’intero viaggio oltremondano, l’amore si rivela il tramite perfetto per una sublimazione che trasforma, che salva. Come la Giovanna-Primavera, anche Beatrice ha un nome che è già un segno, anzi un senhal alla maniera provenzale, un omaggio in codice in cui è iscritto un messaggio. Beatrice è il suo nome ed è anche il nome del suo mandato nella vita del poeta che la canta e le dà vita e forme in poesia, che la fa vivere nella sua opera e insieme la sublima. Beatrice è la prima musa della poesia volgare italiana, ma è certo anche molto di più. Come dice il suo nome, è inviata sulla terra con una missione piuttosto precisa: una missione religiosa, addirittura cristologica, suggerisce la Vita Nuova attraverso il parallelo fra la Giovanna e il Battista, il profeta che dice di essere una voce che grida nel deserto («però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo: “Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini”»).
La missione di Beatrice è quella che il suo nome stesso annuncia – portare beatitudine – e che il poeta esplorerà in lungo e in largo, attraverso segnali e simboli coperti e scoperti. Beatrice è un angelo, nel senso etimologico: porta un messaggio; è una creatura venuta «di cielo in terra a miracol mostrare». È il perfetto prototipo della musa d’artista, ma essendo l’artista un artista medievale, l’ideale filosofico e religioso che innerva la sua opera conferisce alla missione della musa una mira precisissima e accurata, il che spiega anche l’influenza che questo prototipo di musa avrà nella storia, nella poesia e nell’arte successiva, fra i preraffaelliti, ad esempio; musa letteraria, ma anche protagonista di una storia d’amore e di sublimazione, musa due volte, dunque.
Beatrice, all’anagrafe, pare fosse una certa Bice Portinari, della cui vita ci rimangono tracce scarse in documenti notarili che raccontano cosa poteva essere la vita di una donna in un tempo in cui il suo passaggio terreno si risolveva tutto nell’avere un marito e dei figli, eventualmente: come successe a Bice Portinari, figlia di Folco, sposa di un certo Simone, detto Mone, della famiglia dei Bardi, banchieri proprio come i Portinari. Di Beatrice ci resta quasi solo – anzi, ci resterebbe!, se non fosse per quello che, chissà con quanta e quale verosimiglianza, di lei racconta
Dante –, oltre a un accenno nel testamento di Folco Portinari, una menzione in un atto notarile del 1280, con il quale il suddetto Mone de’ Bardi cede certi terreni a suo fratello, Cecchino, con il beneplacito della moglie Bice. La quale all’epoca doveva avere all’incirca quindici anni, proprio così: quindici. Un documento successivo ritrovato nell’archivio Bardi, datato 1313, fa menzione del matrimonio di una figlia di Simone (chissà se avuta dalla seconda moglie, oppure da Beatrice?): lei, a quelle date, doveva essere già morta da un pezzo. Un’apparizione fugace, che
non avrebbe lasciato altre tracce se non, forse, qualche discendente concepito abbastanza in fretta da esser nato prima che Bice morisse, appena ventiquattrenne, forse proprio di parto.
È così incredibile pensare che la breve vita sulla terra di questa monna Bice che nacque Portinari, forse nell’anno stesso in cui nacque Dante oppure un anno più tardi, sia stata sublimata nella trama dei simboli al punto da trasformarsi in una vita ideale, tramutando in pratica poetica vera e propria quella stessa missione che il poeta a lei attribuisce: a salvare Beatrice, a trattenerla dall’oblio sono i versi di Dante che si dichiarano ispirati dal ruolo salvifico di lei; anche se, naturalmente, le condizioni di questo salvataggio sono scelte dallo sguardo metamorfizzante
del poeta. E dunque, della vita reale della musa, non ci restano che congetture, ipotesi, frammenti da cogliere per sprazzi.
Ma, al di là di quello che la storia ci rivela, il personaggio di Beatrice è forse la prima dimostrazione di come una forma letteraria, una convenzione, in mano a un poeta geniale riesca a mutarsi in una storia che trascende i suoi elementi reali, e resta, e dice, e pesa, diventando a sua volta convenzione letteraria ma senza perdere – mai! – la sua perturbante concretezza. La Beatrice di Dante, musa, senhal, donna da omaggiare, morta, santa, creatura miracolosa – chi è, che cos’è? È viva, in tutto questo coacervo di caratteri, persino nelle contraddizioni fra l’uno e l’altro.
È viva ed è morta, ed è il dolore di un’iniziazione finita con l’esilio, ma anche il trionfo di un segreto conquistato. È un amore impossibile eppure fondamentale, un rimprovero così potente da dare all’innamorato un potere tutto nuovo su sé stesso. È prima di tutto, però, la creatura incredibile colta nell’atto di camminare per le strade – la vediamo: occhi bassi, la veste che accompagna i passi – mentre fa l’unica cosa che a una donna, allora, per la strada fosse concesso fare senza dare scandalo: saluta. E tanto gentile e tanto onesta pare, nel suo contegno candido che la rivela diversa da ogni altra donna sul pianeta, agli occhi di chi la vede, agli occhi di chi coglie il suo saluto, che intorno a lei la folla ammutolisce. Nel sonetto del XXVI capitolo della Vita Nuova in cui Dante mostra il saluto di Beatrice, è evidente che si compie un miracolo, nel racconto stesso del fascino salvifico della musa: perché quella che il poeta racconta è una scena convenzionale, una breve passeggiata in città, la modestia del saluto; eppure ha una forza che la tramuta in un’epifania, una potenza di rivelazione che viene proprio dalla consistenza fisica, vivida, reale, della persona di Beatrice. Beatrice ha una voce, ha un passo. Ha occhi, anche se li abbassa. Beatrice che nella Vita Nuova ha un colorito di perle, che da bambina, al tempo del primissimo incontro con Dante, porta un vestito rosso sangue, e bianco nove anni dopo, quando si incontrano nuovamente, nel fiore di un’adolescenza che per la vita dell’epoca è già maturità. Beatrice che quando, dieci anni esatti dopo essere morta, incontra Dante nella fantasticheria maestosa del XXX canto del Purgatorio, è di nuovo vestita di rosso, come lo era stata a nove anni, con un gran mantello verde e un velo bianco trattenuto da una piccola corona di ulivo; e sorprendentemente – ma davvero: con sorpresa del poeta stesso, che riprende le parole di Didone per dirci quanto forte divampi in lui, a rivederla, la fiamma di un amore che non si era mai fatto brace – non lo accoglie affatto con tenerezza e moine ma, al contrario, gli si volge contro tanto aspra da muovere a compassione gli angeli stessi. Ma in quei rimproveri non è solo la forza – forse ai nostri occhi un po’ troppo correzionale – del suo amore; è, soprattutto, la musa che prende vita, dentro questo libro straordinario che, come e molto più del libro galeotto che Paolo e Francesca lessero, senza mai arrivare alla fine, in una stanza di un castello di Rimini, ha riscritto le regole dell’amore. D’altra parte, è l’opera di un poeta che nella sua straordinaria dichiarazione di poetica nel bel mezzo del Purgatorio, al lucchese Bonagiunta da Orbicciano, dice di scrivere sotto la dettatura dell’amore:
I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
Ch’e’ ditta dentro vo significando.
Dante, insomma, il poeta eccelso, il sommo, il più laureato d’allori che mai si sia visto, dichiara con umiltà forse civettuola di scrivere sotto dettatura; e a dettargli le parole è Amore. Il quale, noi sappiamo, altri non è che Beatrice: e quell’ha nome Amor, sì gli somiglia. La musa è l’autore, e tanto ci basti.
Tratto dalla prefazione di Ilaria Gaspari a “Amore” di Emilio Pasquini e Guido Favati
2021 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., Roma
Per gentile concessione dell’Editore
Published by arrangement with The Italian Literary Agency
(continua in libreria…)















