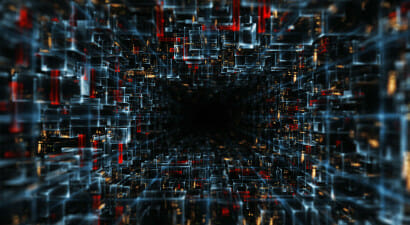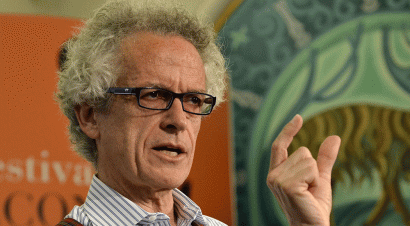Il rapporto tra scienza, tecnologia e narrativa è sempre stato dinamico e, spesso, conflittuale. Ne parla Luca Pantarotto nel saggio “Fuga dalla rete – Letteratura americana e tecnodipendenza” – Su ilLibraio.it il capitolo “Stephen King e il cervello degli zombie”
Negli ultimi decenni le tecnologie digitali hanno visto realizzarsi un’accelerazione quasi fuori controllo, mentre la letteratura spesso guardava a tratti da un’altra parte.
Tuttavia, non sono mancati gli audaci pronti ad accettare questa sfida narrativa, specialmente in un’America che ha spesso accompagnato, anticipato o evitato le implicazioni della rivoluzione digitale.
Così, nel saggio Fuga dalla rete. Letteratura americana e tecnodipendenza, in uscita per Milieu edizioni, Luca Pantarotto, che cura la comunicazione digitale per NN Editore e scrive di narrativa americana e di rapporti tra letteratura e tecnologia su minima&moralia, ne ha ripercorso le tappe decisive.
Può interessarti anche
Dalle origini del cyberpunk alle più recenti satire sull’“era Trump”, dalle fantasie lisergiche all’immaginario della fuga, da Dave Eggers a Ling Ma, da David Foster Wallace a Jarett Kobek, da Stephen King a Don DeLillo, in un percorso di senso che, nel paesaggio in frantumi generato da Internet, ricostruisce le visioni degli scrittori americani degli ultimi decenni.
Dopotutto, il rapporto tra scienza, tecnologia e narrativa è sempre stato dinamico e, spesso, conflittuale. Da un certo momento in poi, è stato necessario trovare nuove prospettive da cui guardare una realtà in continua trasformazione, dal momento che l’impatto della rete sulla nostra mente chiama in causa le nostre possibilità di adattamento, il nostro rapporto con la memoria e perfino il nostro senso della realtà, senza trascurare il linguaggio.

Nel testo, Pantarotto racconta quindi la nascita di mitologie contrapposte e di nuove inquietudini proprio ricorrendo a uno degli strumenti che più da vicino e da sempre riflette gli esseri umani: la letteratura.
Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un capitolo del libro:
Stephen King e il cervello degli zombie
Sono passati dieci anni da quando Mark Zuckerberg è stato proclamato “Person of the Year” da “Time”, per aver saputo imprimere una svolta decisiva alla storia della rivoluzione digitale. Allo scadere degli anni Dieci, Zuckerberg si staglia sulla sua generazione come il creatore di un nuovo modo di concepire la rete, il nostro ruolo all’interno del web e la funzione di Internet nella società. In questo decennio i chiaroscuri che la natura di Facebook e degli altri social network mostrava fin dagli esordi si sono accentuati in scala direttamente proporzionale alla crescita sfrenata degli utenti, all’impatto sempre maggiore della profilazione sulla gestione delle piattaforme e ai compromessi imposti dalla consapevolezza di basare le nostre esistenze su strumenti che ricavano profitto dalla quantità di dati personali che ogni giorno vi immettiamo volontariamente.
I social network, con cui oggi identifichiamo più o meno consapevolmente la rete nel suo complesso, rappresentano lo stadio finale di un’evoluzione che a un certo punto è diventata un’involuzione: un cambio di marcia con cui il web ha preso la direzione contraria a velocità persino maggiore di prima e ha trasformato le proprie promesse in altrettante minacce. Vista da questa prospettiva, la storia recente di Internet è la cronaca di un colossale tradimento.
Può interessarti anche
Prendiamo uno dei cardini della filosofia alla base della rivoluzione digitale: l’idea che i computer ci avrebbero consentito di incrementare in modo significativo il nostro potenziale intellettivo. Insomma, che ci avrebbero fatto diventare più intelligenti. Già negli anni ’60 questa teoria aveva ispirato uno dei documenti più importanti della storia dell’informatica, il rapporto di Douglas Engelbart che abbiamo citato nel primo capitolo. La si ritrova anche nella rappresentazione letteraria del cyberspazio creata da William Gibson in Neuromante: le avventure di Case all’interno della rete sono di fatto esperienze di espansione mentale al di là dei limiti dell’umano. Più in concreto, era legittimo pensare, ad esempio, che la possibilità di affiancare alla nostra mente la memoria inesauribile di una macchina e lo sterminato repertorio di conoscenze disponibile in rete ci avrebbe consentito di “alleggerire” il carico del nostro cervello, destinando ad altro le funzioni cerebrali prima deputate alla semplice archiviazione di informazioni.
La verità è che, in questo senso, la rivoluzione digitale ci ha resi più stupidi. Trasferendo ai computer quelle funzioni, abbiamo finito per smettere di utilizzarle, atrofizzandole. Non riusciamo più a ricordare quasi niente senza l’aiuto dei nostri strumenti tecnologici. I numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica sono conservati nelle rubriche, perché memorizzarli anche in testa? Nomi, indirizzi, appuntamenti, impegni, compleanni, anniversari: tutto ciò che un tempo costituiva il normale contenuto dell’agenda mentale di chiunque oggi ci scivola via dalla memoria come acqua da un setaccio. Personalmente non riesco nemmeno a ricordare quali libri ho letto nell’ultimo mese, senza consultare la mia libreria di Goodreads.
E a proposito di libri: proprio nella lettura si misura il fiato sempre più corto della nostra attenzione e della nostra capacità di comprensione di un testo nell’era digitale. Se n’era già accorto nel 2008 Nicholas Carr, che al tema ha dedicato un pezzo molto famoso dal titolo Is Google Making Us Stupid?, pubblicato su The Atlantic e poi ampliato in un vero e proprio saggio (in Italia pubblicato da Raffaello Cortina nel 2011 con il titolo Internet ci rende stupidi?). Nell’articolo Carr analizza l’influenza delle nuove tecnologie sul nostro cervello, partendo da un piccolo dato di esperienza personale: la sensazione che negli ultimi anni, mentre leggeva, qualcosa nella sua testa cominciasse a non funzionare più come prima. Carr nota che, mentre una volta la lettura di un saggio argomentativo o di un romanzo gli riusciva facile e gli procurava svago e piacere, ora la sua concentrazione iniziava ad andare alla deriva dopo appena due o tre pagine. La lettura non era più un’attività appagante, tutt’altro: era un’impresa sempre più lenta e faticosa, portata avanti in modo nervoso e irrequieto, con la testa che si perdeva tra mille altri pensieri e distrazioni. “Non riesco più a pensare nel modo in cui ero abituato a farlo”, scrive Carr, e individua la responsabilità di questa degenerazione proprio nell’utilizzo del web.
Può interessarti anche
Consentendoci di spaziare attraverso un oceano sconfinato di dati, sulla cui superficie navighiamo senza mai immergerci troppo, saltando irrefrenabilmente di link in link, di contenuto in contenuto, il web ci ha abituati alla ricerca veloce, all’immediatezza in luogo della concentrazione, alla dispersione invece dell’approfondimento, alla rotazione continua e distratta degli oggetti della nostra attenzione. È capitato a tutti di lanciare Google per cercare qualche notizia sull’autore del libro che stiamo leggendo e ritrovarsi alle due di notte a guardare video di gatti che suonano la pianola. La rete dopotutto è fatta così, è un agglomerato di informazioni tutte correlate tra loro tramite nessi non necessariamente causali. La sua influenza sui meccanismi del nostro pensiero è una questione di cui si discute praticamente da sempre e Carr non ha dubbi in proposito: “nel momento in cui arriviamo a contare sulle macchine per mediare la nostra comprensione del mondo, è la nostra intelligenza che si appiattisce sull’intelligenza artificiale”.
Inutile lamentarsi, la colpa è nostra. Con il passare del tempo abbiamo basato il nostro rapporto con le macchine su un numero sempre crescente di equivoci; era inevitabile prima o poi pagarne il conto. Per esempio: avete presente il paragone tra cervello umano ed elaboratori elettronici? Quello da cui nasce la definizione ibrida di “cervello elettronico”, per indicare i microprocessori che fanno funzionare i computer. È un gioco piuttosto popolare da sempre, ma sul lungo periodo rischia di finire male. Come scrive John Freeman, un computer non è un cervello più di quanto un cervello non sia un computer. E non si tratta solo di differenze quantitative: che i computer siano in grado di elaborare e processare dati con rapidità e velocità incomparabilmente superiori alle nostre è una faccenda quasi accessoria. La vera questione è strutturale: i meccanismi attraverso cui i computer leggono e organizzano la realtà non hanno nulla a che vedere con i nostri.
L’ha spiegato nel modo migliore Ellen Ullman nel suo memoir del 1997 Accanto alla macchina:
Il pensiero umano può fare salti vertiginosi, sorvolare sui piccoli fraintendimenti, confinare i se e i ma negli angoli più remoti della coscienza. Ma la macchina non ha angoli remoti. Nonostante tutti gli sforzi di paragonare il computer a un cervello, la macchina non ha una superficie e una profondità […] La mente umana è un casino, pensa un po’.
Può interessarti anche
Ullman non parla a sproposito: la sua posizione è maturata in trincea. Da programmatrice ha potuto osservare la nascita del nuovo mondo da una prospettiva privilegiata: la Silicon Valley del primo boom digitale, l’alba della nuova corsa all’oro, quando la bolla delle dot-com, poco prima di deflagrare bruciando quasi tutto, poteva ancora permettersi l’entusiasmo dell’onnipotenza. Il racconto che consegna alle pagine del suo bellissimo memoir si forma nel chiuso di innumerevoli stanze buie, raffreddate da condizionatori sempre accesi e ronzanti per mantenere a regime i server, su scrivanie ingombre di lattine accartocciate di energizzanti e residui sparsi di cibo spazzatura ingurgitato in fretta per rispettare le scadenze di consegna dei software, nel corso di lunghe notti passate a perfezionare e debuggare programmi che non volevano proprio saperne di corrispondere in tutto e per tutto alla realtà immaginata dal cliente.
Proprio questo è il cuore del problema: la realtà. O meglio, l’impossibile compresenza di due versioni inconciliabili della medesima realtà. Il pensiero umano è caotico, anarchico, impossibile da ridurre a unità. Procede per scarti logici, concepisce l’errore come parte dell’ordine di fenomeni che conducono alla verità, sviluppa accostamenti imprevedibili che portano a risultati inattesi. Impara a modificare se stesso in rapporto alla realtà che si ritrova a interpretare, ricavando da questi continui adattamenti nuovi schemi di comportamento. Anche gli algoritmi, in un certo modo, funzionano così, è vero; ma, mentre il loro scopo è adeguarsi alla complessità per semplificarla e ridurla a schemi ricorsivi e ripetibili, la mente umana non smette mai di lasciarsene modellare, diventando a sua volta più complessa.
Nella linea di confine che separa la realtà caotica e fluida della mente umana dalla sua sistematizzazione informatica sta, secondo Ullman, il programmatore. Il suo compito è travasare l’una nell’altra, instaurare un dialogo tra uomo e macchina che consenta alla seconda di rappresentare in modo efficiente, fedele e funzionale il mondo di idee, dati e concetti del primo. Un procedimento puramente meccanico, all’apparenza, che ci illude di essere gli artefici di un sistema di organizzazione e lettura della realtà modellato a nostra immagine e somiglianza. Ma si tratta appunto di un’illusione: quello che stiamo davvero facendo è l’ennesimo patto con il diavolo, un compromesso vizioso che finisce per alterare la portata delle nostre facoltà di pensiero in scala inversamente proporzionale alle nostre ambizioni di universalità.
Può interessarti anche
C’è qualcosa nel sistema, nella logica formale dei programmi e dei database, che ricrea il mondo a propria immagine […] Pensiamo di creare un sistema per i nostri scopi. Pensiamo di crearlo a nostra immagine. Chiamiamo il processore «cervello», diciamo che i computer hanno «memoria». Ma non sono come noi. Sono una proiezione di una parte molto sottile di noi stessi: quella in cui regnano la logica, l’ordine, la chiarezza. È come se prendessimo il gioco degli scacchi e decidessimo di modellare su di esso ogni aspetto dell’esistenza umana. Ci circondiamo di queste piccole proiezioni di noi stessi, e finiamo per farci affidamento: per conservare le informazioni, per fare benzina, per scrivere – non possiamo più farne a meno. Ma il problema è che più tempo passiamo a osservare un’idea ristretta dell’esistenza, più la nostra idea di esistenza si restringe. Ci adeguiamo al margine di movimento che il sistema ci concede. Diventiamo più ordinati, più logici. Rispondi alla domanda, Sì o No, Ok o Cancel. […] Siamo convinti di creare il sistema, ma al contempo è il sistema che crea noi. Lo abbiamo costruito, ci viviamo dentro, ne siamo trasformati.
L’idea che i sistemi informatici (e per estensione la rete, che per Ullman rappresenta “l’ultimo passo in un graduale instupidimento dei computer”) abbiano il duplice potere di aiutarci a riorganizzare la realtà in cui viviamo e al tempo stesso di riplasmare a propria immagine e somiglianza il mondo e il nostro modo di pensarlo spiega, tra l’altro, perché Nicholas Carr faccia sempre più fatica a leggere un libro senza distrarsi. E spiega anche perché la similitudine tra computer e cervello umano sia poco più che un cliché: semplicemente la capacità di un computer di condizionare i nostri meccanismi di lettura della realtà appiattendoli sui propri è molto superiore a quella del cervello di insegnare a una macchina come afferrare la complessità in quanto tale, riproducendola senza limitarla.
Leggere oggi Accanto alla macchina fa uno strano effetto, una specie di disorientamento sensoriale: un po’ come quando il nostro cervello si inganna e crede di vedere qualcuno con in mano uno smartphone in un film di Charlie Chaplin. Le grandi tech-company, l’esplosione delle startup, il trasferimento di ogni aspetto dell’esistenza fisica nella dimensione virtuale del cyberspazio (denaro, lavoro, attività commerciali, rapporti personali, reazioni emotive), l’avvento di un’economia immateriale basata esclusivamente sul puro atto della transazione, sul click, sulla continua e ossessiva presenza di chiunque in rete: Ullman ha descritto nei minimi dettagli una società che ha tutte le caratteristiche di quella in cui viviamo noi, solo che l’ha fatto alla fine degli anni Novanta.
Può interessarti anche
Soprattutto ha saputo intravedere la genesi di una società basata su un rapporto uomo – macchina pesantemente sbilanciato sul secondo polo. Lavorando nel cuore del punto zero, vedendoli all’opera e parlando con loro Ullman ha capito ben presto che tutti quei giovani imprenditori multimilionari, lanciati alla conquista della valle del silicio dagli spazi asettici dei loro enormi uffici condizionati, stavano progettando sì un mondo nuovo, ma incardinato su tutte le premesse sbagliate. L’inevitabile sottoprodotto, appunto, dell’errata convinzione che il cervello umano e i computer ragionino seguendo gli stessi percorsi logici, che le esigenze individuali vadano sempre subordinate all’interesse per la funzionalità tecnica dei sistemi informatici e che l’intera vita umana sia, in ultima analisi, un insieme di processi ancora troppo inefficienti, che richiedono un upgrade di ottimizzazione.
Sfortunatamente si tratta di un parallelismo che ha sempre rappresentato un’esca fin troppo ghiotta per gli autori di fiction. Per questo, oltre a indirizzare il mondo verso una china estremamente pericolosa, il confronto tra cervello umano ed elettronico ha avuto un risultato forse anche più deprecabile: una notevole serie di pessimi romanzi. Il peggiore dei quali, purtroppo, lo dobbiamo a uno dei più grandi scrittori viventi: Stephen King, che in Cell ha provato a svecchiare il tradizionale soggetto dell’apocalisse zombie collegando la diffusione dell’epidemia non a un qualche non meglio identificato agente virale, ma a un misterioso segnale acustico (“l’Impulso”) che si propaga attraverso la rete globale dei cellulari. Un nuovo tipo di inferno in terra, aggiornato all’era della comunicazione e riassunto, a scansare ogni dubbio, nella tagline dell’edizione americana: “There’s a reason Cell rhymes with Hell”.
Non si sa bene cosa sia l’Impulso, da dove venga o chi l’abbia creato, ma si sa cosa fa: trasforma la gente in zombie. O meglio, in creature che all’inizio hanno diversi tratti in comune con il classico zombie (ferocia, aggressività, irrazionalità, cannibalismo), ma poi evolvono in qualcosa di diverso. Dopo la follia omicida della prima fase della trasformazione, i phone crazies o phoners, come King chiama le legioni di individui cerebralmente lesionate dall’impulso telefonico, sviluppano una specie di primitivo linguaggio fatto di monosillabi rantolati, manifestano poteri telecinetici e telepatici, si rivelano persino capaci di levitazione; ma soprattutto iniziano a organizzarsi secondo logiche di intelligenza collettiva simili a quelle che governano le migrazioni degli stormi di uccelli. È come se l’Impulso trasmesso dai cellulari, qualsiasi cosa sia, abbia riprogrammato il loro cervello, prima resettandolo a una specie di stato di natura e poi riavviandolo secondo percorsi completamente diversi da quelli che l’avevano regolato fino a quel momento.
Può interessarti anche
La terminologia informatica è d’obbligo: la tesi che il cervello umano sia paragonabile a un sistema operativo è l’idea (l’unica, in effetti) che tiene in piedi tutto il romanzo. A un certo punto un personaggio lo dichiara esplicitamente: ok, le persone non saranno uguali ai computer, “ma i computer sono come le persone […] perché noi costruiamo in base a ciò che sappiamo”. Un concetto piuttosto elementare, che del resto King non sembra interessato ad approfondire troppo. La sua ambizione di dare una rinfrescata all’immaginario di Richard Matheson e George Romero, i due numi tutelari a cui è dedicato il romanzo, è interessante, ma il risultato delude. Quella raccontata in Cell è poco più che una normalissima storia di ordinaria follia zombie, che si attiene scrupolosamente a tutte le tappe consuete del genere limitandosi ad ancorare lo sviluppo delle vicende a una sovrastruttura ideologica goffa e posticcia, fatta di parole chiave buttate lì un po’ a casaccio ogni tanto da un personaggio che è a sua volta un cliché (un dodicenne timido, nerd e geniale). Se togliamo quella, resta ben poco: un gruppo di personaggi monodimensionali che compiono azioni prevedibili in una storia dagli sviluppi tutt’altro che inattesi.
Eppure, come capita spesso ai romanzi dotati di scarso valore letterario, oggi Cell mantiene se non altro una funzione documentaria di un certo interesse. Pubblicato in America nei primi giorni del 2006 e in Italia pochi mesi dopo, il romanzo ci si presenta oggi soprattutto come la testimonianza di un profondo cambiamento sociale e culturale fotografato nel momento in cui iniziava a manifestarsi in tutta la sua pienezza: la dipendenza dal cellulare. Un fenomeno tanto diffuso che, proprio nel 2006, il Webster’s New World College Dictionary sceglie come parola dell’anno un neologismo che associa l’utilizzo ossessivo del BlackBerry all’assuefazione indotta dal crack: “crackberry”.
Se alla fine degli anni ’90 avere un “telefonino” era ancora percepito come un lusso, e nei primissimi anni 2000 controllare di continuo le chiamate e digitare un sms dopo l’altro poteva sembrare l’ostentazione di una moda passeggera, all’epoca dell’uscita di Cell era ormai evidente che l’inarrestabile moltiplicazione dei cellulari non si poteva più liquidare semplicemente come una frivola e costosa eccentricità. Ce n’erano troppi, li avevano tutti. Non si poteva neanche più definirli soltanto telefoni: i BlackBerry permettevano anche di navigare in rete, controllare le mail, lavorare sempre e ovunque, essere connessi sempre e ovunque. I cellulari di nuova generazione stravolgevano atteggiamenti, abitudini, comportamenti sociali consolidati in centinaia di anni e ora improvvisamente sostituiti da nuovi modi di fare che, solo poco tempo prima, sarebbero stati stigmatizzati come inconcepibili stramberie. Stavano creando, in poche parole, un nuovo tipo di mondo. Un mondo in cui, per dirne una, rivolgersi a qualcuno senza interrompere nemmeno per un secondo una telefonata “stava ormai diventando un’accettabile ricorrenza della quotidianità”, come nota con perplessità Clay, il protagonista del romanzo.
Può interessarti anche
L’idea che il cambiamento del mondo passi anche attraverso l’adozione e la diffusione virale di innovazioni i cui effetti sulla gente sono simili a quelli delle droghe rappresenta l’unico punto di contatto tra il romanzo di King e il memoir di Ullman. Tuttavia, se la premessa è analoga, le due posizioni approdano a conclusioni opposte. In Cell quel tipo di cambiamento è una deriva maniacale che apre la via alla distruzione della società. Per Ullman, ex attivista politica con una formazione culturale improntata al materialismo storico marxista, la dipendenza dalle tecnologie digitali trova un’interpretazione più suggestiva:
Mi dico che ormai siamo tutti collegati alla rete globale – non solo: ci siamo legati a essa, ne siamo dipendenti. È la nuova droga: l’istante, l’adesso, il globale […] Forse la rete globale è solo l’ultima forma di rivoluzione. Forse la rivoluzione è l’unica cosa che ci dà dipendenza. Forse la forma non ha importanza – il socialismo, il rock and roll, la droga, il capitalismo finanziario, il commercio elettronico – poco importa, purché sia la cosa più nuova che capita nel tuo tempo. Forse ogni generazione produce un certo numero di persone desiderose di cambiamento – del cambiamento più drastico possibile.
La rete come rivoluzione, la rivoluzione come dipendenza: la storia di Internet in due passaggi. Al quadro descritto da Ullman ne manca però un terzo, inevitabile: la dipendenza come negazione della rivoluzione. Finora abbiamo visto che il sogno di espansione mentale promesso dai primi teorici della rivoluzione informatica ha prodotto alcuni inattesi effetti collaterali di segno opposto: distorsioni cognitive, indebolimento delle facoltà di pensiero, semplificazione della realtà, ossessività nell’utilizzo dei nuovi strumenti. Gli zombie di King sono una metafora fin troppo sfacciata della piega che stavano prendendo le cose, e del resto proprio in quegli anni inizia a diffondersi l’espressione “digital zombie”, con cui si indica una dipendenza da Internet e social media così maniacale da provocare in chi ne soffre un autentico scollamento dalla realtà circostante, con ripercussioni anche sui rapporti personali e sociali. Ed è proprio nell’ambito dei social media che si consuma il più grande tradimento dell’utopia della rete.
(continua in libreria…)