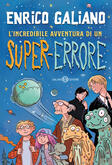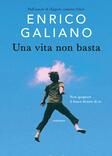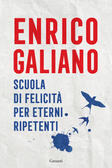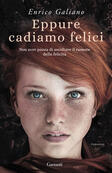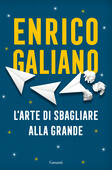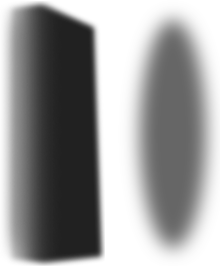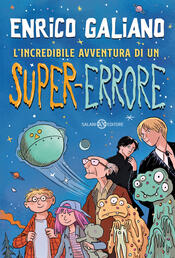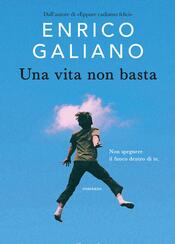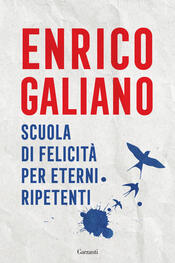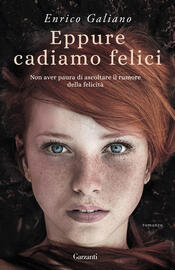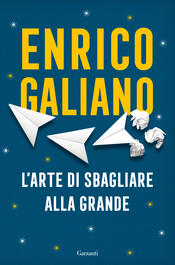“Il punto è che abbiamo smesso di chiederci cosa significhi davvero ‘essere maturi’. E, soprattutto, che chiamiamo ‘maturità’ un rito ormai così vecchio da avere più che altro i tratti della senilità”. Su ilLibraio.it la riflessione di Enrico Galiano, insegnante e scrittore, dopo le polemiche per lo studente che per protesta ha fatto scena muta alla Maturità, e per la studentessa che ha raccontato di aver vissuto l’esame come un’umiliazione, e non come un momento di crescita: “Forse, prima di giudicare, dovremmo ascoltare cosa ci stanno dicendo ragazze e ragazzi…”
Uno si è alzato, ha firmato il registro, ha detto: “Grazie, ma io l’orale non lo faccio”.
L’altra ha parlato, ha risposto, ha esposto il suo progetto, e poi ha scritto una lettera aperta per dire: “Non è stato un esame, è stata un’umiliazione”.
Due storie diverse, Gianmaria e Marina.
Lui a Padova, lei a Nardò. Lui silenzioso, lei in prima linea. Eppure, se ci fermiamo un attimo a sentire bene, sembrano la stessa voce. Solo che noi, quella voce, facciamo finta di non sentirla.
Perché il punto non è se sia giusto o sbagliato fare scena muta. Non è nemmeno se le domande dell’orale fossero vaghe o precise, se Marina ha avuto una reazione eccessiva o giustificata.
Maturità o senilità?
Il punto è che abbiamo smesso di chiederci cosa significhi davvero “essere maturi”. E, soprattutto, che chiamiamo “maturità” un rito ormai così vecchio da avere più che altro i tratti della senilità.
Può interessarti anche
Gianmaria ha detto no, con gentilezza, a un rituale che non riconosceva più.
Marina ha detto sì, ma si è ritrovata – a detta sua – di fronte a un interrogatorio, più che un’interrogazione.
E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo commentato i loro voti, giudicato i loro modi, analizzato i loro toni.
Ma quasi nessuno ha provato ad ascoltare davvero quello che stavano cercando di dire.
Hanno parlato di un esame vecchio. Di una scuola che misura, pesa, classifica: e così facendo non forma davvero. Più che altro, deforma.
Hanno messo in discussione il sistema dei voti — quel dio minore a cui da decenni sacrifichiamo entusiasmo, creatività, libertà.
E noi, in risposta, abbiamo parlato di rispetto. Di dovere. Di “così si è sempre fatto”.
Ma davvero vogliamo che la scuola sia solo questo?
Un posto dove “si è sempre fatto così”?
Un luogo dove la voce di chi protesta viene zittita in nome della forma?
Può interessarti anche
In Germania, l’esame di maturità non è solo una giornata da affrontare col cuore in gola: è un percorso più ampio, che può includere anche un progetto personale preparato nei mesi precedenti. Conta non solo cosa sai, ma come ci sei arrivato. Nei Paesi Bassi, il voto finale si basa a metà sul lavoro fatto durante l’anno e a metà su prove nazionali. Ogni studente prepara anche una specie di tesina personale, una ricerca su un tema scelto, che viene valutata seriamente. L’obiettivo? Coltivare autonomia e spirito critico, non solo memorizzazione. In Finlandia, l’esame finale è addirittura facoltativo: serve solo se vuoi andare all’università. Altrimenti ti diplomi in base al percorso fatto negli anni. E l’idea che devi dimostrare tutto in venti minuti davanti a sette adulti non appartiene proprio alla loro idea di scuola.
Può interessarti anche
E noi?
Siamo ancora lì a giudicare la maturità di una persona da come risponde a una domanda generica, magari sotto stress, più che da come ha camminato lungo tutto il percorso.
A decidere chi è “maturo” in base a come riesce a collegare Svevo all’energia nucleare, a come maneggia una mappa concettuale, a come ha scritto l’ennesimo tema dopo una vita passata a scriverne.

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.
Forse non siamo noi a doverli giudicare.
Forse sono loro – non a giudicare noi – ma a chiederci: volete che continuiamo ad adeguarci in silenzio, o avete il coraggio di cambiare con noi?
Perché quando due ragazzi, così diversi, così lontani, dicono la stessa cosa in due modi opposti, forse non sono loro a dover spiegare qualcosa.
Forse, siamo noi a dover cominciare ad ascoltare.
Sul serio.
L’AUTORE – Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano classe ’77, in classe come sui social, dove è molto seguito, sa come parlare ai ragazzi.
Dopo il successo di romanzi (tutti usciti per Garzanti) come Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È poi tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande. Con Salani Galiano ha quindi pubblicato la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole. Ed è poi uscito, ancora per Garzanti, il suo secondo saggio, Scuola di felicità per eterni ripetenti. Dopo il romanzo Geografia di un dolore perfetto, è tornato in libreria con Una vita non basta, e ha poi pubblicato con Salani il ultimo libro per ragazzi, L’incredibile avventura di un super-errore.
Da metà maggio 2025, per Garzanti, è in libreria il nuovo romanzo, Quel posto che chiami casa.
Qui è possibile leggere tutti gli articoli scritti da Galiano per il nostro sito, con cui collabora con costanza da diversi anni (anche con dei video per Instagram e TikTok).
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it